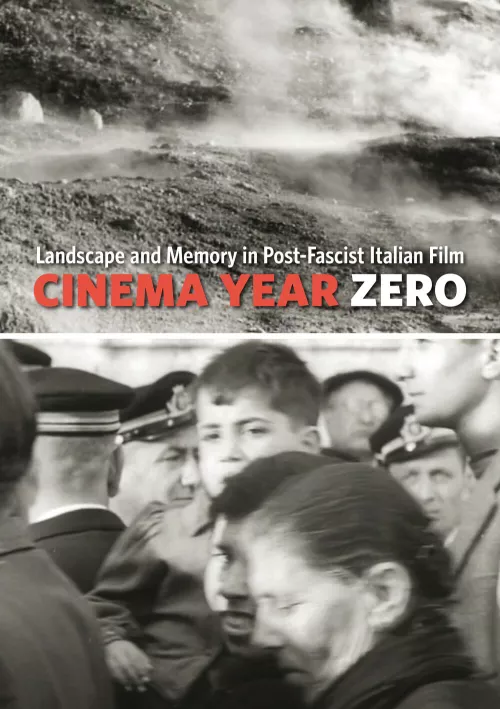Giuliana Minghelli, Cinema Year Zero
In un saggio famoso André Bazin scriveva che “le néorealisme est aussi une révolution de la forme vers le fond” (Bazin, Qu’est-ce que le cinéma? Une esthétique de la réalité: le néoréalisme. Vol. 4 Paris: Les Èditions du Cerf, 1962, p. 141). L’apparente semplicità dell’enunciato nasconde in realtà un velo di ambiguità: il termine fond può intendersi non
solo come “contenuto”, ma anche come “sfondo”. Non è un’ambiguità da poco: sottende la possibilità di poter adottare un diverso sguardo critico rispetto all’interpretazione dominante del Neorealismo come cinema post-resistenziale attento ai contenuti sociali.

È proprio da una rinnovata attenzione al paesaggio inteso come luogo di esperimenti formali che prende le mosse Cinema Year Zero. Landscape and Memory in Post-Fascist Italian Film. Come rivela il titolo, nel cinema neorealista l’interesse per lo sfondo va di pari passo con un’operazione di scavo nella memoria, individuale e collettiva: “il cinema del dopoguerra” scrive l’autrice “ci offre una mappa per ripercorrere la genealogia dell’amnesia collettiva che ha afflitto e ancora affligge la società italiana del dopoguerra, dicendoci molto sulla relazione ancora irrisolta – anche oltre i confini nazionali – con la storia del ventesimo secolo, il fascismo e la guerra” (p. 4).

Diviso in cinque capitoli preceduti da un’articolata premessa, il saggio di Minghelli si ripropone di concentrarsi su quattro film che illustrano alcuni punti focali di questo processo: Ossessione (1943), Paisà (1946), Ladri di biciclette (1948), Cronaca di un amore (1950). Diverse per stile e realizzazione – e riconoscimento critico: Cronaca non è certo tra i film più noti di Antonioni –, le pellicole rappresentano diversi momenti di un cinema capace al tempo stesso di segnare un nuovo punto d’inizio ma anche di basarsi su un “atto paradossale di simultaneo oblio ed espiazione” (p. 3).
La dettagliata analisi di alcuni tratti e della struttura complessiva di Ossessione, girato da Visconti quando il regime era ancora nel pieno dell’attività, mette in risalto le contraddizioni su cui si poggeranno i successivi film neorealisti: da un lato il regista mostra degli “uomini vivi nelle cose” (così si era espresso in un articolo uscito per «Cinema» nel 1943), immersi in squarci paesaggistici – urbani e non – che per la prima volta facevano capolino sullo schermo dopo anni di “telefoni bianchi”; dall’altro è proprio la ricerca di quel paesaggio inteso come “altrove” a mettere i suoi personaggi di fronte all’impossibilità di ricominciare una nuova vita, essendo troppo forte l’incombenza della memoria del passato. I due protagonisti, Gino e Giovanna, sono due outsider incapaci di accettare i valori fascisti della famiglia e della vita borghese (lui è un vagabondo, lei è una donna che ha sposato un uomo che non ama pur di scampare allo sfruttamento e alla miseria) né di imprimere alla loro vita una svolta positiva: un destino che li vede legati insieme nell’indecisione, e nel male – l’inizio di una storia clandestina, l’uccisione del marito di lei – anticamera della rovina.
Il neorealismo fa quindi il suo ingresso sulla scena ben prima della Resistenza, presentandosi fin da subito come un “cinema di dolore ed espiazione, un cinema del presente inseguito dal passato; non la guerra, o le rovine del dopoguerra, ma piuttosto il lungo ventennio fascista”. Sette anni dopo, un giovane Michelangelo Antonioni avrebbe girato Cronaca di un amore. Apparentemente, un dichiarato omaggio a Ossessione, quasi una variazione sul tema: i due film hanno in comune la stessa ossatura (una storia di passione e tradimento che comporta un delitto e un finale tragico) e l’appartenenza ad un genere ben codificato (il giallo all’italiana, che trasforma dall’interno alcuni stilemi del noir hollywoodiano e ha delle radici letterarie pure americane).

Attraverso acuti esempi – non limitati all’immagine, ma anche alle tecniche cinematografiche e all’uso delle musiche – Minghelli mostra invece come Antonioni abbia guardato al capolavoro di Visconti per metterne in discussione, rovesciandole dall’interno, tanto il genere quanto le premesse estetiche: mentre il suo predecessore raccontava d’un delitto passionale e voluto dai protagonisti, Cronaca di un amore riannoda i fili di due “non-delitti” avvenuti quasi contro la volontà dei due amanti, o soltanto per la loro incapacità ad agire. In entrambi i casi il neorealismo rappresenta comunque un “sostituto etico d’un esplicito atto commemorativo”, ovvero “la scena che segue il crimine, la scena del dopo” (p.16). Non potendo affrontare (dunque raccontare) il passato in modo diretto, il regista dovrà – suggerisce Minghelli rimandando esplicitamente al paradigma indiziario di Carlo Ginzburg – farsi detective, essere in grado di raccogliere indizi, gli scarti di una storia non rappresentabile.

È in quest’ottica che l’autrice lega Cronaca di un amore ai primi scritti e ai primi documentari di Antonioni (Gente del fiume Po, Sette canne un vestito, N.U.), finora poco studiati. Ne emerge un realismo legato alla materialità del mondo, eppure venato d’immaginazione”, e un’interpretazione affatto nuova della prima produzione di Antonioni: che, se analizzata nella sua interezza, si dimostra sede di una “storicità troncata” raccontata attraverso le percezioni ma mai scevra di componenti sociali.
Questi ed altri casi (su tutti quello della complessa genesi di Paisà) materializzano la teoria di Deleuze per cui col neorealismo ci troveremmo non più di fronte a un cinema d’azione, ma piuttosto davanti a uno “svolgimento onirico attraverso la mediazione dei sensi” (G. Deleuze, Cinema 2: l’immagine-tempo, 1989, 4). È curioso scoprire che già nel 1940 Cesare Zavattini stava andando nella stessa direzione interpretativa, immaginando un cinema fatto di “sogni nitidi e feroci” (C. Zavattini, I sogni migliori, «Cinema», 1940): “i sogni migliori” scriveva “sono quelli fuori nebbia, si vedono come le nervature delle foglie”. Zavattini non avrebbe mai smesso di inseguire quest’ideale di realismo insieme materiale e visionario, unica via di interrogare un passato indicibile. Lo dimostra il capitolo conclusivo (Epilogue as Prologue), dedicato agli esperimenti tra parola e immagine condotti da lui e Paul Strand per il libro fotografico Un paese (1952), poi preso a modello da Gianni Celati: ben lontani dall’evocare un senso di continuità, il testo e le immagini chiamano il lettore-osservatore ad una partecipazione attiva al difficile, faticoso processo di “diventare italiano”, non semplicemente esserlo.
Il libro: Giuliana Minghelli, Cinema Year Zero. Landscape and Memory in Post-Fascist Italian Film, Routledge, 2013, pp. 241, 140 $.