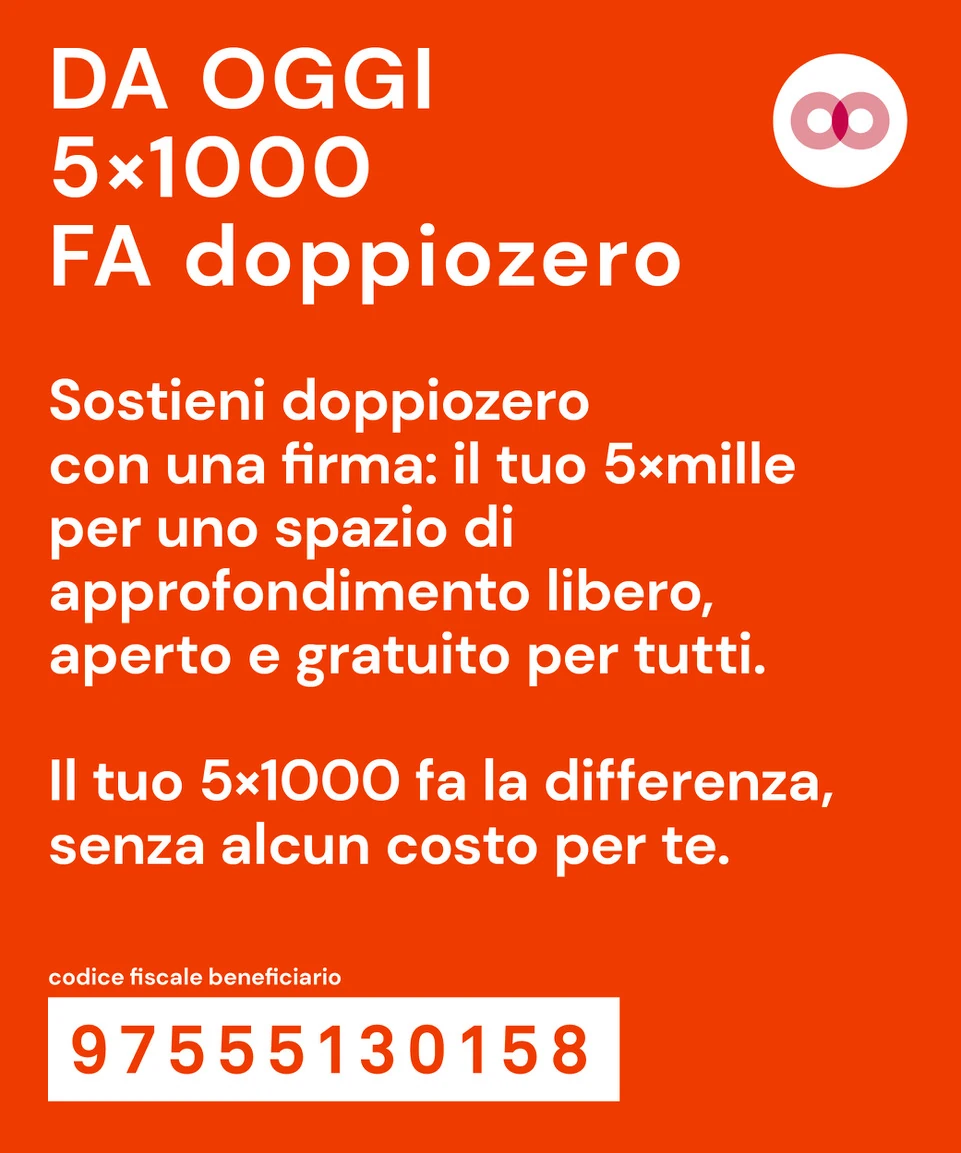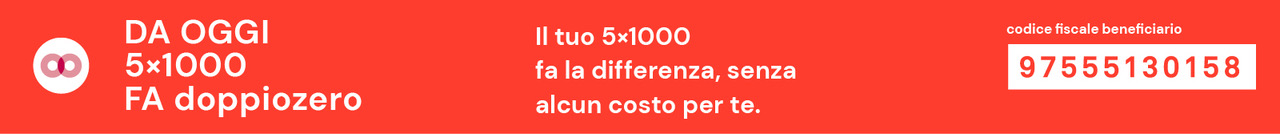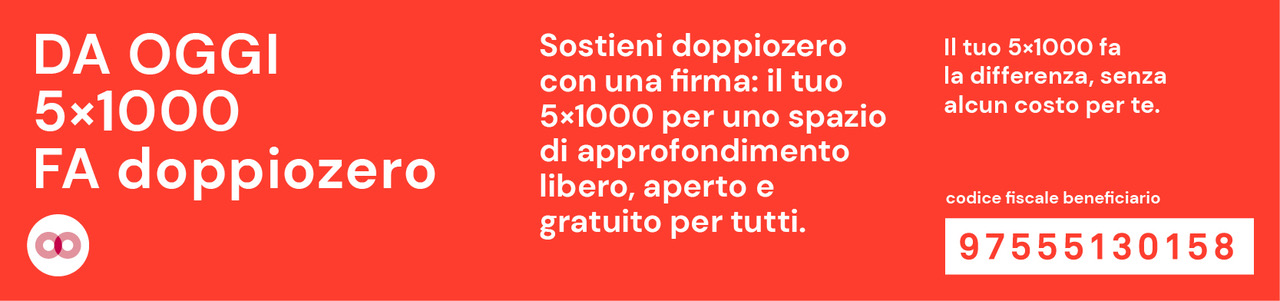Speciale
Wallace Stevens, Il cielo sembrava così piccolo
Wallace Stevens, The sky seemed so small that winter day (Il cielo sembrava così piccolo quel giorno d’inverno)
È il primo verso di una poesia di Wallace Stevens dal titolo The Constant Disquisition of the Wind (La disquisizione costante del vento), prima parte di un dittico intitolato Two illustrations that the world is what you make of it (Due illustrazioni che il mondo è quel che se ne fa). Dittico che è nella raccolta delle poesie scritte tra il 1950 e il 1955, cioè le ultime della sua vita, uscite postume (una traduzione italiana, a cura di Massimo Bacigalupo, col titolo Il mondo come meditazione, uscì nel 1986 per la collezione “Poeti italiani e stranieri” diretta da Giovanni Raboni presso le edizioni di Acquario e Guanda).
Sono stato a lungo incerto se scegliere per questa rubrica uno dei versi più noti di Stevens, cioè – da Angel surrounded by paysans – il verso I am the angel of reality (“Sono l’angelo della realtà”), oppure, dalla stessa poesia, il verso Yet I am the necessary angel of earth (“Eppure sono l’angelo necessario della terra”). Questo avrebbe permesso di indugiare intorno ai luoghi più propri di una poetica come quella di Stevens, sempre tesa a congiungere conoscenza e immaginazione, pensiero e visione, e intenta a cercare nella presenza delle cose e del visibile il punto di sconfinamento verso un altrove che sebbene fatto di parvenze è fonte, ancora, di sapere. Quella poesia dell’“angelo necessario”, che dà anche il titolo a una raccolta di scritti di Stevens stesso sulla poesia (titolo che a sua volta Massimo Cacciari prenderà per un suo bel saggio di angelologia e politica), chiude la splendida raccolta Aurore d’autunno (di essa molti anni fa volli pubblicare nel terzo numero della rivista “il gallo silvestre”, 1991, un anteprima di traduzione italiana, quella di Nadia Fusini, consistente in dieci sezioni). Oppure avrei potuto sostare intorno a un verso, e a un testo, scelto dalle raccolte poetiche che hanno mostrato con forte evidenza la singolarità di una poesia in cui il movimento ragionativo è tutt’uno con quello lirico, e l’eleganza della rappresentazione coincide con la potenza inventiva, come accade in The Man with the Blue Guitar (L’uomo con la chitarra blu), del 1937, o nel poema del 1942 Notes toward a supreme fiction (Note intorno alla suprema finzione). Invece ho deciso di soffermarmi su un verso di una poesia meno nota, La disquisizione costante del vento, perché mi sembra che esemplifichi bene un movimento consueto nella scrittura poetica di Stevens: l’andirivieni tra presenza narrativa di una figura – umana o animale, o tratta dal mito – e presenza di un paesaggio naturale: presenze, l’una e l’altra, immerse nella quiete distesa e interrogativa di un ragionare che mentre si svolge costruisce un mondo di assoluta alterità, insieme fisico e metafisico, concretamente prossimo e immerso in un’aria sospesa, lontanissima, irreale. Infine, un'altra ragione – che dirò alla fine di queste considerazioni – mi ha fatto scegliere questa poesia.
Ecco, nella traduzione italiana di Massimo Bacigalupo, le prime tre terzine:
Il cielo sembrava così piccolo quel giorno d’inverno,
Una luce sporca su un mondo smorto,
Contratto come uno stecco raggrinzito.
Non era l’ombra di nube e freddo,
Ma un senso della distanza del sole:
L’ombra di un senso suo proprio.
Una consapevolezza che il giorno concreto
Era tanto meno. Solo il vento
Sembrava grande, sonoro, alto, forte.

C’è, dunque, uno sguardo, un punto di osservazione verso l’aperto, in un certo giorno invernale (Stevens situa ogni rappresentazione poetica in un tempo, in un luogo, spesso in un’ora). Il cielo ha perso la sua profondità, è come contratto, chiuso in sé, e la luce che dilaga è opaca, sporca, fascia un mondo che pare privo di vita, un mondo che non è più circondato dallo spazio e animato dal tempo, un mondo inaridito. Lo sguardo sul cielo è uno sguardo che coinvolge i sensi, i quali avvertono che l’ombra che grava sul mondo non è un’ombra di nube né una cappa di freddo, ma un’ombra che di colpo porta con sé la percezione della distanza del sole. Il sole è davvero in un altro mondo, non appartiene a questo mondo, e in questa estrema lontananza del sole, il giorno appare anch’esso, come il cielo, contratto in sé, piccolo, non tempo-spazio del vedere e del sentire, ma margine insignificante. In questa fredda separazione dello sguardo e del sentire dal visibile della natura, ecco di colpo una presenza che prende la scena: il vento, con il suo impeto, con la sua potenza, con il suo suono che riempie i sensi. La riduzione visiva e percettiva del visibile è di colpo sovrastata dal vento. Un’irruzione che prende nel suo vortice ogni altra presenza, anche quella di chi sta guardando. Lo sguardo stesso e il soggetto dello sguardo sono come travolti dal sopravvenire di questa nuova forte presenza.
E mentre pensava dentro il pensiero
Del vento, ignorando che quel pensiero
Non era né suo né di un altro qualunque,
L’immagine appropriata di sé,
Così formata, divenne lui: respirò
Il respiro di un’altra natura come suo,
Solo un respiro momentaneo,
Fuori e oltre la luce sporca
Che mai avrebbe potuto essere animale,
Una natura ancora priva di forma,
Fuorché quella di lui – forse quella di lui
Nell’ozio violento della domenica.
I versi da narrativi si fanno drammaturgici. Una metamorfosi è sopravvenuta: non il movimento che portava il poeta della Romantik a dimenticare sé stesso per dislocarsi nel ritmo sensibile della natura, pulsazione di un vivente nel vivente della natura, ma un movimento insieme fisico e concettuale: pensare il vento dal cuore stesso del vento, dal suo pensiero, stare nel vento che pensa, nel suo respiro. Non più sé stesso ma neppure l’altro: una sospensione che tuttavia mette in moto una nuova singolare percezione, quella che avverte un sé divenuto vento. Per un istante il proprio respiro coincide con il respiro del vento, con il respiro di un'altra natura. Si tratta di una natura che non è la propria natura, e tuttavia è in grado di restituire la percezione di stare in un punto che è oltre la luce sporca del mondo, oltre quel piccolo cielo che sovrasta un giorno vuoto, inerte. Una natura che è al di qua di una forma, o forse ha già una forma che è la forma di lui che sta pensando il vento, dislocato nel respiro del vento. Ed è questa sensazione di un sé stesso altro da sé e allo stesso tempo di nuovo sé stesso che porta il soggetto dello sguardo, e del pensiero, nell'esser qui temporale e spaziale, e persino in una condizione, che forse è all'origine di tutto il pensare-immaginare: lo stare in un luogo e in un tempo preciso, nella domenica, nell'ozio violento della domenica.

La realtà è fantasia (ecco l'"angelo della realtà"), il pensiero è finzione, il sapere è sensibile, i confini si scavalcano: la parola della poesia è questo sommovimento che considera d'aria i confini. E nel caso concreto di questi versi Stevens sembra dare una sua particolare declinazione, fisica e immaginativa insieme, del famoso passaggio di Rimbaud: "Je est un autre". La percezione di sé, nella situazione di un qui e ora domenicale, di ozio domenicale, passa attraverso l'avventura – insieme sensoriale e fantastica – di una espansione dell'io. Siamo in quel movimento che Baudelaire indicava ad apertura del suo Cahier intitolato Mon coeur mis à nu: "De la vaporisation et centralisation du Moi. Tout est là" ("Vaporizzazione e centralizzazione dell'io. Tutto consiste in questo"). Del resto la presenza di Baudelaire giunge a Stevens sia direttamente sia attraverso i suoi forti e costanti riferimenti a una triade rilevantissima per il definirsi dei suoi registri poetici, cioè Whitman, Eliot, Pound. Inoltre Stevens ha sempre coltivato le relazioni con la poesia e la prosa di Paul Valéry (sarebbe interessante vedere quanto è presente in Stevens Monsieur Teste) e con la poesia di René Char. Da Hartford, Connecticut, il poeta americano corrispondeva con un filosofo come Jean Wahl, e aveva nella libraia parigina Paule Vidal un riferimento per farsi rifornire di particolari edizioni – tra le altre, una volta, un'edizione degli scritti di Heidegger su Hölderlin – e anche di opere d'arte (all'origine della poesia sull'"angelo necessario" c'è una natura morta di Tal Coat acquistata per Stevens dalla libraia Paule Vidal).
Accennavo all'inizio a una seconda ragione che mi ha spinto a scegliere i versi sopra riportati. Qualche mese fa, mentre rileggevo la poesia di Stevens, mi ero soffermato proprio sui versi di The Constant Disquisition of the Wind, e a un certo punto ho provato a tradurli. Ma la traduzione, come altre volte mi è accaduto con altri poeti, si è piano piano dislocata verso quella soglia che diciamo "imitazione": il primo testo riaffiora nel secondo ma trasformato, in qualche modo spostato non solo in un'altra lingua ma anche in altre forme, in altri ritmi. Una presenza, ancora, alla quale si replica stando, certo, sul suo terreno, ma nella propria lingua. E nei propri modi: del pensare, dell'immaginare.
Variazione da Wallace Stevens
Una striscia grigia, quel cielo d’inverno.
Una luce sporca su un mondo assonnato.
Nessuna ombra di nuvola correva sull’erba.
La distanza dal sole, infinita. C’era soltanto
un vento, un grande vento, con le sue grida,
con la sua furia che cresceva nel vento.
Quel vento, quella sua furia. Pensava a quel vento,
pensava dentro il pensiero del vento,
non sapeva che quello non era il suo pensiero,
ma il pensiero del vento, e all’improvviso,
intimo a quel vento, a quel pensiero del vento,
gli parve di respirare con il respiro
del vento, immenso, impetuoso, privo di una forma,
privo di un corpo. Respirava con il vento,
nell’impeto del vento. C’era ora qualcosa,
sotto quel cielo d’inverno, in quella luce
sporca che copriva un mondo assonnato.
C’era lui, con quel respiro di vento.
Lui, nell’ozio violento della domenica.