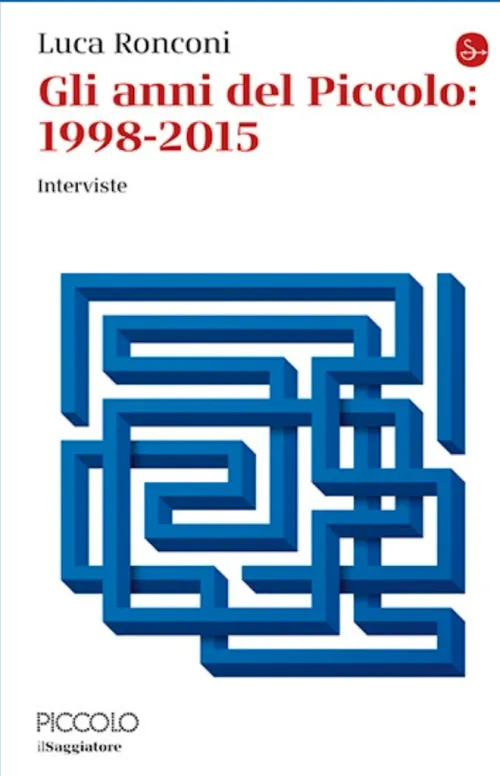Il Piccolo Teatro di Luca Ronconi
Inizio dalla fine, dall’ultima risposta data dal regista per il programma di sala di Lehman Trilogy (2015, l’anno della sua scomparsa). Eleonora Vasta chiudeva la sua intervista per lo spettacolo sul testo di Stefano Massini chiedendo. “Che tipo di fruizione consiglia al pubblico?” e Ronconi rispondeva: “È un testo che ti lascia libero di distrarti, di ritornare all’attenzione, non ha dialoghi serrati, non pretende un contatto continuo con lo spettatore: suggerisce un approccio nel segno della libertà”.

A ripercorrere le trentaquattro interviste per altrettanti programmi di sala che costituiscono l’ultimo libro dedicato al regista, Gli anni del Piccolo 1998-2015, a cura della stessa Vasta, pubblicato nella collana Piccolo – il Saggiatore, quell’idea di libertà emerge come portante. Libertà nella scelta dei testi, che possono essere romanzi o classici della drammaturgia, opere del primo Novecento o scritture d’oggi, oppure incursioni nella fisica contemporanea, nell’economia o in altre discipline sociali o scientifiche. È una libertà che poi diventa aderenza al dettato delle parole (salvo qualche necessario taglio), ma senza preconcetti, senza un “metodo” prefissato, lasciandosi guidare dalla natura concentrata o esplosa del testo stesso.
Così avviene da La vita è sogno di Calderón de la Barca, prima regia al Piccolo da direttore, nel 1999, in dittico con Sogno di Strindberg, a Lehman Trilogy, passando per la sceneggiatura di Lolita di Nabokov, per il Candelaio di Giordano Bruno e per Quel che sapeva Maisie di Henry James, per Infinities del fisico John D. Barrow, un viaggio per piccoli gruppi di spettatori lanciati in situazioni di paradosso spazio-temporale. Come pure per un paio di Goldoni, per tre classici greci (Prometeo, Baccanti, Rane), per Professor Bernhardi di Arthur Schnitzler, per Lo specchio del diavolo di Giorgio Ruffolo sui meccanismi dell’economia e così via, fino ai labirinti dell’argentino Rafael Spregelburd, a un classico romanzo teatrale scritto alle soglie del Rinascimento, la livida Celestina di Fernando de Rojas, fino a Pornografia di Gombrowicz e alla pièce di Massini.

Il libro è un altro tassello di quel grande incompiuto che è il racconto del teatro di Ronconi. Possediamo vari spezzoni che analizzano un’attività molteplice, polimorfa, diffusa tra teatro privato (il sogno anni sessanta-settanta delle cooperative), scena pubblica (gli stabili di Torino, Roma e Milano), la pedagogia della scuola di Santacristina, tra le colline umbre, dal 2002, fondata con Roberta Carlotto, un luogo di nutrimento per gli spettacoli ‘maggiori’ e di sondaggio, insieme alla scuola del Piccolo, delle nuove generazioni di attrici e attori.
Manca un’opera unica, uno studio che analizzi il complesso dell’attività di uno degli artisti più significativi, complessi e produttivi del dopoguerra. E allora dobbiamo, per ora, accontentarci di approcci parziali: gli studi sulla prima fase del suo lavoro di Cesare Milanese (Luca Ronconi e la realtà del teatro, 1973) e Franco Quadri (Il rito perduto, 1973), la conversazione con Gianfranco Capitta del 2012 (Teatro della conoscenza), i postumi Prove di autobiografia – raccolte da Maria Grazia Gregori, a cura di Giovanni Agosti (2019) – sulla sua carriera fino a Torino, vari volumi su convegni a lui dedicati come Regia Parola Utopia (2021), resoconti di progetti speciali come quello per le Olimpiadi invernali di Torino. Per concludere con questo nuovo volume.

Gli anni del Piccolo è fatto di interviste per i programmi di sala del teatro milanese. Gli intervistatori sono diversi, e quindi differente è la portata dei discorsi. Inoltre degli spettacoli si fornisce la locandina, ma non una scheda che ne racconti, almeno brevemente, il testo e la messinscena. Per questo i materiali rimandano molto alla memoria di chi quegli spettacoli li ha visti.
Al volume ci sono alcune introduzioni. Scrivono Sergio Escobar, che è stato direttore generale del teatro negli anni in cui Ronconi era direttore artistico, Roberta Carlotto, sodale dell’impresa di Santacristina, Giovanni Agosti, ottimo conoscitore dell’opera del regista, Claudio Longhi, che firma alcune interviste e che nei primi anni di Ronconi al Piccolo fu regista assistente del maestro. Escobar sottolinea la continua, inappagata ricerca di Ronconi: “Il mio spettacolo ideale – cita – non l’ho ancora fatto, perché il mio ideale di spettacolo è uno spettacolo infinito. È uno spettacolo che abbia le sue regole, la sua struttura, che vada per conto suo. In somma, uno spettacolo in fuga, che scappi. Quello sarebbe uno spettacolo in cui mi riconosco, perché anche a me piace scappare”.
Si definisce così un regista che non si accontenta delle proprie soluzioni precedenti, che mette alla prova ogni volta i testi, rispettandoli e forzandoli nello stesso tempo. Giovanni Agosti ricorda un’altra frase: “Per abitudine, non prendo in esame il testo per com’è stato recepito e rappresentato in passato, ma per quello che è. Lo prendo alla lettera”. E la lettera non vuol dire, scopriremo leggendo, supino adeguamento alla sua forma esteriore, ma scavo nella sua struttura, nella lingua, innanzitutto, una lingua sempre da verificare in scena, nei personaggi, figure che spesso il regista duplica, triplica, per andare più a fondo nei segreti della pièce. In cerca di un punto di gravità che si riverberi sulla scena, si traduca in azione.
Claudio Longhi esplicita il “metodo non-metodo” di Ronconi citando dalla lectio magistralis Il mio teatro, in occasione della laurea ad honorem all’Università di Bologna: “In oltre trent’anni di attività mi è capitato in più di una circostanza di dichiarare di non essere […] un ‘regista teorico’: come spesso mi sono trovato a osservare […], il mio lavoro non nasce dall’applicazione di una teoria e nemmeno amo teorizzare ‘a posteriori’ su di esso o sul teatro – ho come l’impressione, infatti, che se lo facessi non sarei più in grado di cimentarmi in quella operazione sempre nuova che è la messa in scena di un testo”.
Però, con il suo sguardo acuto, la sua capacità di anatomizzare le opere e di reinventarle per la scena, con il suo spirito didattico (narrato nel saggio di Roberta Carlotto a proposito dei corsi estivi a Santacristina), Ronconi si presenta come un “regista filosofo”, sempre Longhi, che segue il motto di Wittgenstein, “Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere”; eppure non rinuncia mai a sperimentare, anche modi di convivenza diversi, con i suoi testi sul potere, sull’economia, sulla violenza.

È sperimentatore di lingue, innanzitutto. Quella del sogno nei primi spettacoli milanesi, alla ricerca di identità insidiate dal reale. Viaggiatore in spaesamenti in lingue straniere, che impongono cambi alle nostre ‘maschere’ abituali, come in Lolita, visto come un viaggio di un vecchio europeo (Humbert Humbert ma anche Nabokov) nell’inglese americano. Nel fascino del paese giovane. Lingue multiple, strati di società differenti, svelati nella loro retorica, in una teatralità che è “affondare nel reale più primitivo e brutale”, troviamo nel Candelaio di Giordano Bruno, testo monstre che rompe i canoni rinascimentali e riscrive una pagina della ricerca di verità naturale propria della filosofia del Nolano.
Si potrebbe continuare con la simultaneità di Infinities, negli spazi non teatrali del deposito di scenografie della Scala alla Bovisa, viaggio in uno spazio-tempo simultaneo debitore delle scoperte della nuova fisica, alla ricerca di una drammaturgia capace di sfidare i nostri tempi, oltre i canoni del dialogo e del personaggio.

Questa è la grande invenzione di Ronconi: estendere il dominio del teatrabile, evitando divulgazione e didascalismo, cercando di interrogare i tempi in cui viviamo. E quando un intervistatore gli chiede se un teatro sottratto “alla dittatura della forma e del personaggio” sia una sfida possibile, risponde: “Perché dobbiamo parlare di sfida? Una sfida presuppone una vittoria o una sconfitta. Questo progetto (Lo specchio del diavolo, il testo sull’economia di Ruffolo, nda) si propone invece di saggiare delle possibilità… Durante le prove abbiamo vissuto in un clima di gioco e di libertà. A me piace prendere la vita come un gioco. Questo testo ha liberato gli attori da alcuni fantasmi: ‘Chi sarà il mio Andreev?’ oppure ‘ Che cosa penserebbe zio Vanja […]. Questa è un’opera provocatoria che possiede l’intelligenza e la finezza di accennare senza voler convincere”.
Gioco. Libertà. Ascolto. Attenzione agli attori. Spostamento dei canoni conosciuti. Analisi che parte dal linguaggio per diventare azione scenica. Provo a sintetizzare quel “non metodo” che in questo volume possiamo ricostruire per frammenti. Insieme all’amore per il repertorio e alla assoluta distanza dall’attualizzazione e dalla monumentalizzazione. Cos’è contemporaneo in Celestina? chiede Carlo Antonelli. E lui risponde: “Alla lettera, contemporaneo è tutto quello che accade, che è attuale, ma, insieme a questo, tutto ciò che non è crepato nel frattempo. Contemporaneo non è una simultaneità tra due cose”.
Il teatro è ricerca, conoscenza e anche qualcosa di più: “qui (Professor Bernhardi, nda) ci troviamo di fronte a quel tipo di teatro che sta un gradino più su rispetto alla possibilità di conoscenza; un teatro in cui non è la consapevolezza del conoscere a mano a mano che ti dà l’arricchimento, ma il fatto che, quando finisce, ne sai di più di quando sei entrato: fra conoscere e sapere c’è differenza”.
Luca Ronconi, Gli anni del Piccolo: 1998-2015. Interviste, Milano, Piccolo – il Saggiatore, 2025, pp. 544, euro 30.