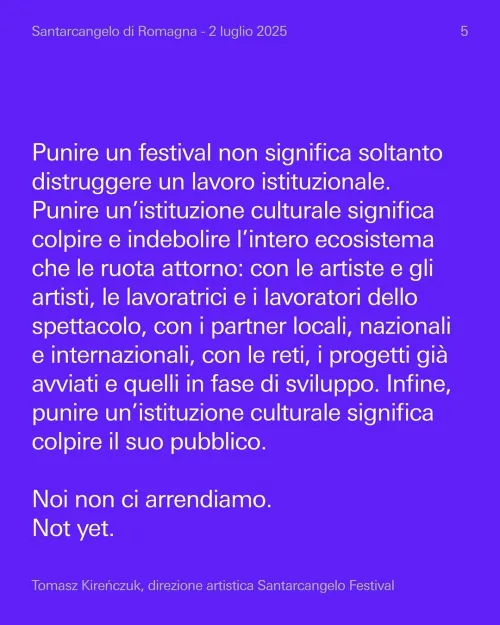Santarcangelo e gli altri: NOT YET
Ciò di cui il mondo ha bisogno
“What the world needs now is love sweet love / No not just for some but for everyone”. Comincia così This Resting, Patience di Ewa Dziarnowska, in scena insieme a Leah Marojević: con una canzone sull’amore scritta ai tempi della guerra in Vietnam, una danza già in atto, alcune sedie intorno a un tappeto blu. E, ancora prima dell’ingresso, una serie di istruzioni: ci si può muovere, entrare e uscire, ma – indicazione misteriosa quanto anticipatrice della logica coreografica – non spostare alcune sedie impilate qua e là. In ogni caso, lo spettacolo è già cominciato, anche per chi l’osserverà.
Nelle tre ore successive, la canzone dell’incipit continuerà a tornare nelle gradazioni live di Krzysztof Bagiński, così come frammenti di coreografia sempre un po’ simili e diversi, mentre la minuziosa drammaturgia di luce curata da Jacqueline Sobiszewski si relaziona, delicata e potente, alle infinite sfumature del crepuscolo. Si genera, così, nella visione, una qualche forma d’incanto molto concreta, che costruisce un luogo comune, altro, in cui stare. Più di tutto, lo indicano le azioni stesse di Dziarnowska e Marojević, mentre trascorrono lungo direttrici che conducono la danza in tanti sensi altrove: progressivamente, sono via via più impegnate nella continua, paziente ricostruzione della presenza nello spazio performativo. Questo accade attraverso sia una scrittura della relazione che si sviluppa verso una crescente prossimità ideale e concreta, sia tramite delicati inviti allo spostamento di chi guarda, talora molto diretti. La coreografia si sposta ovunque, anche alle nostre spalle o sotto le sedute, e, volendo, ci si può muovere per seguirla; le sedie vengono ricollocate creando nuclei di visione possibili, pure in mezzo allo spazio; il contatto si fa sempre più palpabile.

La libertà, però, non è assoluta, perché da subito viene indirizzata verso un senso di rispetto per l’alterità, di ascolto reciproco e di cura della situazione che verrà co-determinata da artiste e pubblico. Allora, forse, si tratta più che altro di una domanda su come sia possibile gestire la libertà individualmente e collettivamente. Riflettendo sul senso del lavoro delle persone in scena e al contempo interrogando chi si trova a osservarle, This Resting, Patience è uno spettacolo che ti fa spostare – non solo letteralmente. Mostra, nel suo snodarsi, come si possa costruire una relazione, con spettatori e spettatrici, fra le danzatrici, e fra loro e il pubblico; anzi, più che mostrarlo, invita a farne esperienza diretta. Si scrive, così, una coreografia aperta che congiunge o, meglio, sfuma le consuete posizioni e responsabilità, a livello di gestione dello spazio-tempo scenico come dello sguardo.
Alla fine, sembra che si torni all’inizio o quasi: di nuovo la canzone di Burt Bacharach e Hal David e una sinuosa danza in blu. Però, ora, le danzatrici sono due e la loro originaria autonomia lascia il posto a un rapporto diretto, frontale, che s’irradia da un intreccio di sguardi che prima non c’era; e anche il nostro guardare non è lo stesso, ma si rivela di una intensità completamente altra, dopo svariate ore condivise in una esperienza di mutazione sviluppata su più livelli drammaturgici.
Arte, storia e futuro
Quest’anno Santarcangelo Festival si chiama NOT YET, formula distillata come di consueto dal direttore Tomasz Kireńczuk a partire da una considerazione complessiva dei percorsi e lavori coinvolti. This Resting, Patience – come vari altri lavori in programma che ragionano sulla spettatorialità – dona al titolo (e alla manifestazione) una decisa sfumatura di potenzialità, concependo lo spazio della scena come luogo per elaborare pratiche di lavoro, di vita, di relazione, di presenza differenti da quelle che cadenzano la quotidianità e lasciando la sensazione che queste possano magari innervarsi oltre la scena, nella realtà.

Su un principio di scrittura delle energie attraverso la relazione fra corpi diversi, sulla gestione di uno spazio-tempo comune da abitare secondo il proprio stare e sulla creazione di una singolare prossimità si fonda anche Cinema Impero di Muna Mussie, sostenuto dal progetto blOOm dedicato alle creazioni one-to-one. Una sola spettatrice viene accompagnata nel silenzio di una platea vuota; nel buio, si avverte qualche movimento, forse fruscii, poi passi leggeri che generano un senso d’inquietudine e d’incertezza. Infine, arriva una figura, che si siede proprio nella poltroncina accanto. Parte un film: mostra il Cinema impero di Asmara, costruito in età fascista, ora in stato di abbandono e di recente esplorato da Mussie; in seguito, si susseguiranno clip di quel viaggio e filmati dell’Istituto Luce risalenti al colonialismo italiano, mentre la voce dell’artista alterna – su quelle immagini d’archivio – slogan della propaganda fascista con racconti, approfondimenti e riflessioni personali in coincidenza per l’altro tipo di video.
In un primo momento, sembra che la scrittura audiovisiva e quella orale si rapportino fra loro in termini di contrappunto: da una parte la propaganda di regime su cui si fonda una certa Storia, dall’altra l’esperienza individuale, carica di umanità, delle piccole storie. Ma i confini fra i due versanti non sono così netti e, soprattutto, i piani non sono soltanto due: la performance si sviluppa attraverso molteplici livelli drammaturgici che si contaminano continuamente l’uno con l’altro, manifestando quando meno ce lo si aspetta inneschi di alterazione dei fatti presentati e generando ulteriori livelli di senso. Tanto più che, sul piano dell’oralità, si innesta inoltre la voce di una intelligenza artificiale impiegata per descrivere le immagini d’epoca. Scopriamo presto che tale forma di ostensione visivo-auditiva è carica di errori lampanti: addirittura un cammello viene scambiato per “probabilmente un leone”; e le descrizioni dell’AI, in apparenza molto precise quanto apertamente inaffidabili, si manifestano anche quando lo schermo ritorna nel buio iniziale – raccontano, insomma, un mondo che oggettivamente non c’è (e spingono, di conseguenza, a figurarselo).
Pian piano, molto delicatamente, il corpo dell’artista si approssima, con le spalle che in certi momenti si sfiorano: condividiamo, fra persone estranee ma sempre più concretamente vicine, un processo di riscrittura del reale attraverso prospettive molto diverse fra loro. Anche Cinema Impero lavora sulle dinamiche dell’avvicinamento, sulla costruzione di una sintonia scenica in parte condivisa, forse per certi versi paritaria, e sulla possibilità di fare esperienza dei modi in cui si può creare una relazione – fisica come concettuale – fra persone, mondi e visioni diverse. Ma in questa condizione di singolare prossimità sorge anche una possibilità di immaginazione: per ripensare, da sole e insieme, una storia (e perciò forse anche un avvenire) differente, attraverso il contatto con l’alterità di una presenza sottile quanto forte, fortissima.

I festival nel nuovo triennio FNSV 2025-27
Muna Mussie ha preso parte al talk Sharing Landscapes. Performing Arts in Emilia-Romagna, con altre artiste che lavorano in Regione attraverso reti più o meno formali e, da approcci diversi – come suggerisce la moderatrice, Chiara Organtini –, si confrontano con il portare a visibilità aspetti decisivi, profondi quanto spesso rimossi, remoti o prossimi che siano. Com’era inevitabile, in questo incontro, è tornato spesso il riferimento alle violente iniziative delle Commissioni ministeriali del FNSV-Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (ex FUS) che – nel contesto delle ammissioni al triennio 2025-27 – hanno colpito, fra gli altri, anche Santarcangelo dei Teatri. C’è chi è stato escluso, chi è stato ricollocato o retrocesso, chi fortemente ridimensionato nei punteggi qualità e anche chi ha resistito, ma avverte, perciò, una sorta di ‘senso di colpa’ che in questa occasione condivide pubblicamente, mentre su entrambi i versanti si sfiora il rischio della pratica autocritica (“perché io?”).
Le ragioni alla base delle scelte ministeriali possono essere molteplici. Si evidenzia, anzitutto, che in determinati contesti – soprattutto Danza e Multidisciplinare – esclusioni e ridimensionamenti risultino molto mirati: può emergere, qui, una esplicita presa di distanze rispetto a progetti e/o soggetti che investono su temi, forme e approcci specifici, quali quelli in parte richiamati in questo articolo, dalle drammaturgie della relazione alla decentralizzazione delle pratiche non solo estetiche, fino al ripensamento individuale e collettivo in rapporto a temi di interesse artistico come sociale. Se così fosse, però, si sarebbe trascurato che – pur tenendo conto ovviamente delle proprie soggettività – una commissione consultiva ministeriale ha il dovere di analizzare e tutelare nel suo complesso il sistema che è chiamata a valutare, sostenendo, al di là dei propri gusti e indirizzi, anche le zone meno predilette e anzi, forse, appunto, soprattutto queste; e che in ogni caso, tali organi sono ‘solo’ consultivi e, dunque, in casi estremi, sta – come accaduto in passato – alla mediazione istituzionale garantire la tutela del settore che comunque rappresenta, se non alla gestione amministrativa evitare danni eccessivi.
In questo tipo di contesti, c’è sempre da considerare poi il livello più materialmente politico: dal fronteggiarsi di partiti avversi agli accordi interni ai medesimi schieramenti, che comunque, qui e là, in tutta evidenza non si sono granché curati dell’impatto sulle centinaia di persone che rimarranno espulse da un settore in cui operano, magari da decenni; si va anche dal lascito di pratiche che – come suggerisce la riflessione condivisa dal Teatro delle Moire – per anni hanno infragilito le aree più delicate del comparto, fino all’avvento di una nuova governance autoritaria ora impegnata a imporre la propria monocultura, fra l’altro rideclinando in chiave ideologica aberranti strumenti amministrativi appunto predisposti in passato da altri. Nell’ultima conferenza stampa di presentazione del Festival, Tomasz Kireńczuk – che ha dovuto lasciare la Polonia vari anni fa – ha raccontato come, nel suo Paese, si sia proceduto in maniera analoga: prima cambiando sensibilmente le norme, poi posizionando figure allineate nei ruoli decisionali e, infine, intimidendo chi non si adegua alla visione tracciata.

Santarcangelo e gli altri: not yet
Non si tratta, dunque, solo di Santarcangelo, dell’Italia e, in realtà, nemmeno esclusivamente di spettacolo dal vivo. Basti pensare dal più volte denunciato mancato confronto con la gran parte dei soggetti FNSV e con alcune delle loro rappresentanze, ben prima di questi esiti ministeriali; alla “leggerezza” – chiamiamola così – che traspare dai modi in cui alcune Commissioni paiono bypassare i limiti del proprio mandato (per esempio considerando anche la dimensione quantitativa), delle norme che lo governano (andrebbero valutati tutti i progetti, al di là dei caratteri con cui sono scritti), nonché più ampiamente e istintivamente del buon senso (quando su di una barca si aprono delle falle, rischia di affondare per intero, anche le parti che più ci piacciono!). E non può rassicurare, anzi, che questi verbali passino ovviamente per numerosi livelli di verifica interna prima di venire divulgati.
A pochi giorni dalla pubblicazione dei decreti FNSV per il triennio 2025-27 più parti del settore sono entrate in agitazione, nonostante i report Siae e Federculture – condivisi all’evento per gli 80 anni di Agis – festeggino, come ogni anno, la crescita esponenziale del comparto, quest’anno consentendo al Presidente della Commissione Cultura di “smentire” la “falsa propaganda e mistificazione” portata avanti sulla crisi in atto dai “gufi del pessimismo”, cioè dalle “opposizioni”. “Vogliamo tutt’altro” fin da inizio luglio ha convocato un’assemblea nazionale, che nel frattempo si è riorganizzata sui territori e il cui ultimo incontro risale al 21 in vista delle prossime azioni; alcune Regioni si sono coordinate per esprimere pubblicamente il loro dissenso, non solo per il – democraticamente delicatissimo – punto riguardante le dimissioni dei rappresentanti degli enti locali dalla Commissione teatro, che ha continuato nel frattempo comunque a operare; e Cresco ha appena presentato alla Camera un’analisi dei dati, evidenziando alcune criticità trasversali, dalle aberrazioni contenute nell’ultimo D.M. fino ai disequilibri espressi nei riconoscimenti FNSV. Altre iniziative, incontri, analisi arriveranno nelle prossime settimane, anche in coincidenza alla pubblicazione delle assegnazioni finanziarie, che consentiranno di misurare in concreto l’impatto di questo “Anno zero” nel settore spettacolo.
Intanto, in una forma di stranissima, amara veggenza, il titolo del Festival di Santarcangelo ha assunto un significato ancora più chiaro e, senza troppo forzare, arriva a estendersi oltre: NOT YET da un lato ora evoca la catastrofe in atto fuori e dentro i teatri, dall’altro suggerisce l’urgenza di affrontarla finché è ancora possibile. A breve comprenderemo quali risposte riuscirà a dare il sistema e, in particolare, se stavolta, nonostante la grande frammentazione interna, sarà in grado di trovare dei punti trasversali di convergenza che possano riunire realtà fra loro diversissime (comprese quelle che avranno di più) per invitarle ad agire in maniera coordinata. Sarebbe decisivo perché la posta in gioco è davvero molto, molto alta. Per chiunque.
Il pluralismo – in diversa misura, più o meno finora sempre tutelato anche in contesto (ex) Fus – non è ‘solo’ un principio costituzionale e democratico di base, ma corrisponde al tratto distintivo della cultura scenica italiana, perciò, a maggior ragione adesso, potrebbe rappresentare la sua forza. Quello che forse le scelte attuate dalle Commissioni FNSV non hanno compreso è che qualcosa di simile a un sistema esiste – e continuerà a esistere –, anche a vantaggio delle parti di volta in volta predilette, proprio soltanto in un contesto di pluralità e confronto: è questo il tipo di ambiente che di frequente viene creato nei contesti della creazione contemporanea così duramente colpiti, affinché soggetti diversi fra loro siano a loro agio nello stare secondo le proprie specificità, nel relazionarsi insieme e, in special modo, nell’entrare in contatto con l’alterità, di qualunque forma essa sia – non per qualcuno, ma per tutte e tutti, come si canta in What the world needs now. È questo il genere di spazi che sta venendo limitato, se non sottratto, nella culturale e nella società contemporanee, perciò è forse quello che, in risposta – a ciascun livello, da ogni parte – si potrebbe continuare a difendere come valore, nella speranza che non ci sia più pericolo per nessuno, né ora né in futuro.