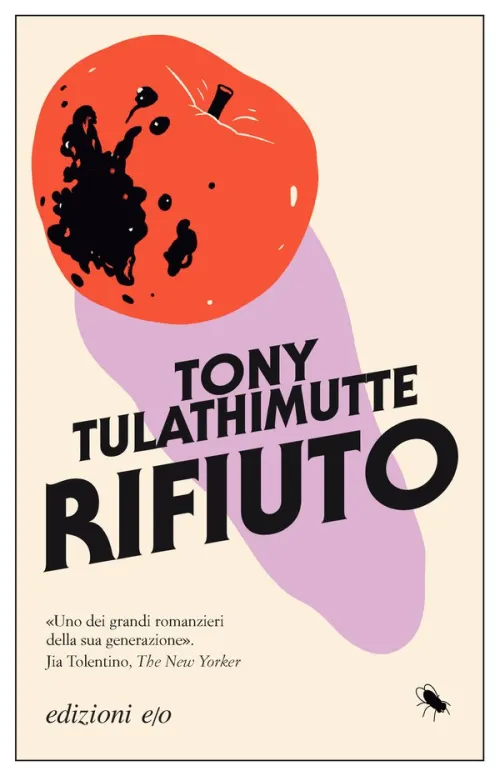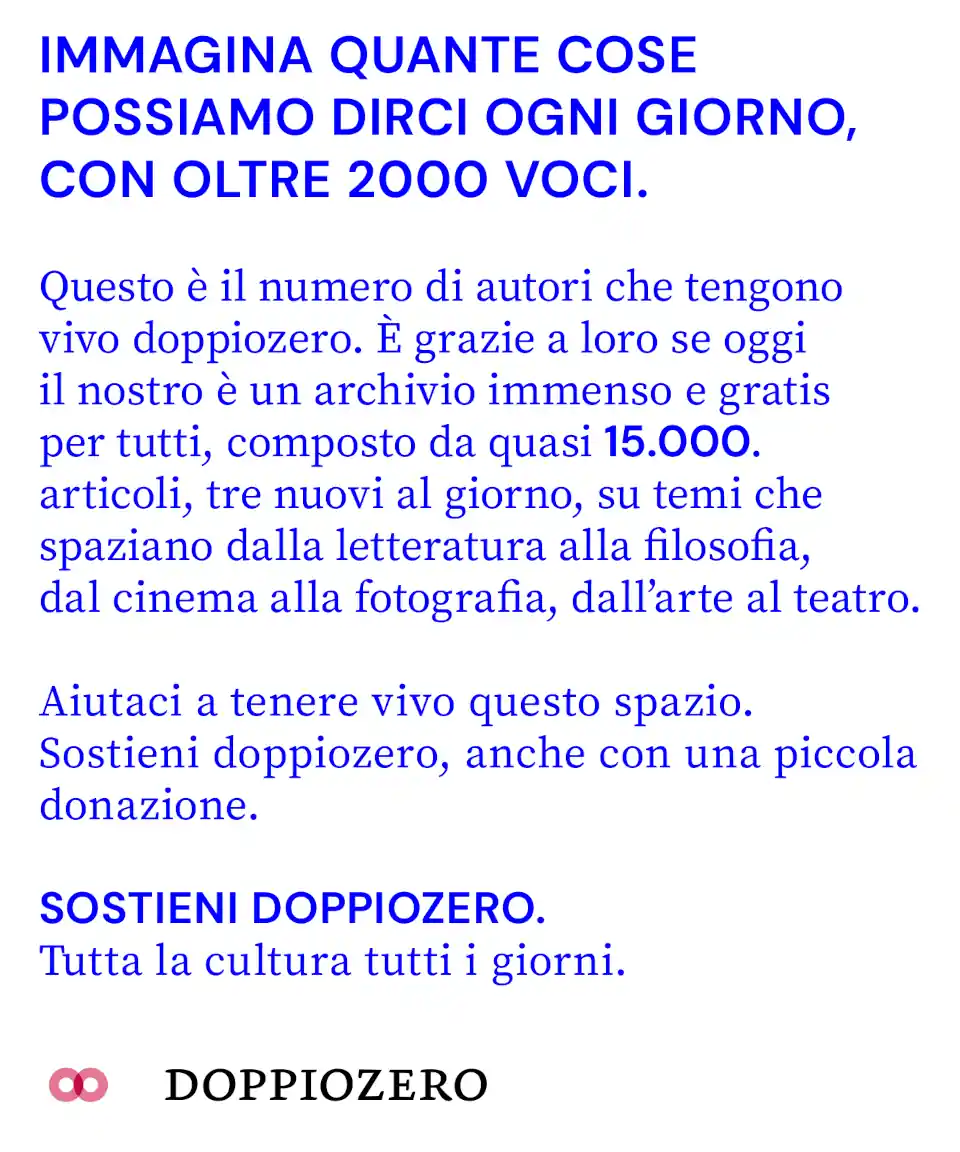Il personaggi social di Tony Tulathimutte
Rifiuto di Tony Tulathimutte (traduzione di Vincenzo Latronico, e/o 2025) è un romanzo sul linguaggio dei social network. Sono sei racconti – "Il femminista", "Pics", "Ahegao o la ballata della repressione sessuale", "Un futuro da sballo", "Main Character" e "re: Rifiuto" – che Tulathimutte inserisce in una concatenazione tematica coesa. Pur potendo essere letti singolarmente, nei racconti alcuni personaggi ricorrono, si incrociano e appartengono allo stesso universo narrativo. Tutte le storie esplorano temi simili: rifiuto, alienazione, identità digitale, solitudine generazionale, sessualità e potere nei rapporti di coppia, legati come se fossero un unico discorso. La sequenza genera un flusso emotivo unitario: dall’osservazione dell'esclusione e della frustrazione ("Il femminista"), all’introspezione sulla propria identità e alienazione ("Main Character"), fino alla meta-riflessione sul rifiuto e sulla scrittura stessa del testo, dove l'autore immagina la risposta negativa di un ipotetico editore alla pubblicazione di questo stesso libro. In questo senso si può parlare di un "romanzo" unitario, che indaga una "storia generazionale" frammentata. Nel racconto "Il femminista", un uomo che si definisce alleato delle donne, si sente respinto da tutte le sue amicizie femminili, incapace com'è di trasformarle in relazioni romantiche o sessuali. Le accusa di superficialità e ipocrisia, il risentimento verso di loro cresce e lo spinge verso ambienti online misogini, fino a culminare in un atto di violenza simbolica, che riduce il femminismo a un concetto astratto e distaccato dalla realtà. In "Pics", Alison, una donna sulla trentina, ha una relazione occasionale con un amico, Neil. Quando lui le comunica che non vuole che il sesso influenzi la loro amicizia, Alison reagisce con rabbia e umiliazione, cercando di sabotare la nuova relazione di Neil con un’altra, si isola emotivamente e precipita in una spirale di autocommiserazione. "Ahegao o la ballata della repressione sessuale" racconta la storia di Kant, un giovane gay di origini thailandesi che si è appena dichiarato alla sua famiglia e sta esplorando l'incognita della propria sessualità. Nonostante un legame con Julien, un uomo bianco, Kant sembra incapace di impegnarsi emotivamente e sessualmente, si rimprovera di aver sbagliato nel comunicare le proprie preferenze e finisce vittima di una crisi d’identità e dell'isolamento. In "Un futuro da sballo", Max, un uomo ricco, scrive un post su Reddit lamentandosi della fine di una relazione con Alison, la protagonista di "Pics", che riappare in questo racconto. La sua manipolazione emerge dai commenti degli utenti sotto i suoi post e rivela la sua incapacità di riconoscere le proprie colpe, nelle dinamiche di potere e controllo che avvelenano le unioni affettive. Il protagonista di "Main Character" è Bee, una persona non-binaria di origini thailandesi, che vive gran parte della propria vita online, creando identità false e truffando gli altri. Anche Bee riflette sulla propria solitudine e sul bisogno di approvazione virtuale. L’ultimo racconto è la simulazione della lettera di rifiuto da parte di un editore, che critica apertamente l’autore per la scrittura eccessivamente introspettiva e autoindulgente di questo libro: un affondo meta-narrativo che sfida le convenzioni del romanzo tradizionale e riflette sul processo creativo e sul rapporto tra autore e lettore.
Dicevamo che Tulathimutte trasforma il linguaggio in fulcro ontologico dell’esperienza narrativa, e lo fa mettendo al centro il gergo contemporaneo di certe élite giovanilistiche americane. LOL, Tbh, creepy, ghostare, cringe, weird, incel, meme, thread, gaslight, mansplain, catcalling, dating, inbox, ecc.: in questo romanzo non sono tic verbali, ma strumenti (alcuni già passati di moda, come la parola "cringe" che ha avuto fortuna pochi anni fa ma che oggi nessuno pronuncia più) per definire l’accesso a uno spazio sociale, la legittimità dei desideri e l’autorità morale dei parlanti. Lo sottolinea anche il traduttore Vincenzo Latronico nella postfazione: parole che fanno parte della lingua inglese ma che sono state adottate dal linguaggio internazionale abbreviato dei social, dove un singolo termine racchiude atteggiamenti, giudizi e riferimenti culturali e, per questo, si ritrovano nel libro nella loro lingua originale. I personaggi – Alison, Kant, Julien, il femminista – annegati in questi fronzoli linguistici, smarriscono progressivamente la loro corporeità psicologica, riducendosi a figure astratte, immaginette funzionali a illustrare dinamiche di esclusione e autoaffermazione verbali. La loro soggettività latita; ciò che resta impresso nel lettore è il modo in cui parlano, la frequenza con cui adottano abbreviazioni e idiomi di moda, la loro adesione a un lessico conformista e disciplinante.
Tulathimutte ci invita a riconoscere il carattere rituale e performativo della comunicazione digitale: ogni interazione è un atto simbolico di accettazione o rifiuto, e il gergo stesso diventa agente morale, capace di giudicare e segregare. In tal senso, il romanzo si configura come un’indagine sociolinguistica in forma letteraria: non ricordiamo i tratti individuali dei protagonisti, ma la texture linguistica che li plasma. Il lettore sperimenta la condizione della generazione iperconnessa, ossessionata dall’apparenza verbale e dall’approvazione digitale, in cui la parola sostituisce l’azione e la soggettività si dissolve nel flusso di questo modo di parlare a pappagallo.

Tuttavia, sebbene il romanzo ponga al centro il linguaggio digitale, la riproduzione del gergo social appare forzata e didascalica. Rifare abbreviazioni, chat simulate, meme e reazioni tipiche delle piattaforme non equivale a restituire l’anima di una lingua vivente: anche fingendo di "copiare" conversazioni autentiche, l’autore finisce per cristallizzare un linguaggio che esiste solo in nicchie ristrette, rendendolo simultaneamente evidente e artificiale. L’operazione sembra perciò un tentativo di aggiornare la lingua letteraria secondo le mode del momento, e l’ambizione del romanzo si arena nella cronaca puntigliosa di un contesto storico preciso, quello che stiamo vivendo. Ci si deve allora chiedere: tutto ciò ha davvero a che fare con la letteratura? La tensione tra cronaca sociolinguistica e invenzione narrativa mette in luce un paradosso della scrittura contemporanea: la fedeltà al gergo digitale può generare autenticità superficiale, ma non sempre produce profondità letteraria; il testo rischia di diventare un esercizio di stile più che un’esperienza emotiva o esistenziale, un inseguimento delle mode retoriche leziose che oscura la materia umana dei protagonisti, già di per sé dissolta nella loro astrattezza archetipica.
Guardato alla luce della storia della letteratura americana, Rifiuto si inscrive in una lunga tradizione di sperimentazioni linguistiche: Joyce frammentava la lingua con il flusso di coscienza per catturare le infinite sfaccettature della psicologia; Pynchon ibridava linguaggio tecnico, burocratico e slang popolare per descrivere la cultura postindustriale. Ma, a differenza di queste operazioni, Tulathimutte lavora su un gergo codificato, socialmente limitato e temporaneamente contingente, destinato a mutare rapidamente con le mode o addirittura a morire. Nessuno dice più "matusa", oggi si dice "boomer", domani chissà. La tensione tra aspirazione letteraria e documentazione linguistica rivela uno strappo evidente: ciò che Joyce e Pynchon costruivano come linguaggio universale o densamente simbolico, qui appare istantaneo e locale, utile più a segnalare appartenenza generazionale che a generare esperienza estetica. L’analogia con i grandi sperimentatori mostra che l’ambizione di cogliere la lingua viva è nobile, ma l’aggiornamento alle forme dei social comporta un rischio: predominano gli stereotipi, i personaggi si dissolvono e la letteratura è costretta a confrontarsi con il limite della propria temporalità.
Sebbene Tulathimutte dimostri acume sociologico e sensibilità per i tic verbali della generazione digitale, non è allo stesso livello dei grandi contemporanei americani come Jonathan Franzen, Don DeLillo o Bret Easton Ellis, in primo luogo per il modo in cui tratta la lingua. Questi autori, più vecchi di Tulathimutte, non si limitano a riprodurre il gergo di un gruppo sociale, quando lo fanno lo trasformano in strumento letterario. Franzen combina precisione psicologica, costruzione sociale e stilizzazione linguistica: le sue frasi non informano, sono strumenti per sondare la coscienza e la crisi della famiglia americana, dando corpo e spessore ai personaggi. DeLillo fa della lingua un organo sensibile al rumore della società: il linguaggio dei media, dello spettacolo e del consumismo diventa il tessuto simbolico in cui le idee di potere, alienazione e apocalisse culturale si intrecciano. Bret Easton Ellis, pur in chiave più cinica, usa slang e cultura pop non come fine a sé stessi, ma per creare un effetto estetico, una tensione tra superficialità e violenza narrativa che rende la lingua parte integrante del mondo narrato. Tulathimutte, al contrario, concentra l’attenzione sul gergo digitale in modo documentaristico, cristallizzandolo e riproducendolo senza trasformarlo in strumento di meditazione estetica o simbolica. In Rifiuto, il linguaggio domina sui personaggi: il loro spessore psicologico e morale si dissolve e si perde nel gergo, che diventa specchio riflesso del presente più che mediazione letteraria. L'autore scafato non insegue le mode linguistiche, le trascende, trasforma la lingua in materia viva, capace di unire riflessione universale, dramma morale e invenzione stilistica. Tulathimutte, pur intelligente e acuto nell’osservazione, resta in questo romanzo intrappolato nel ruolo di cronista linguistico e sociologico: ha intuito generazionale, ma senza il respiro epico o la densità simbolica dei suoi colleghi. La differenza non sta nell’intelligenza o nell’ironia, ma nella capacità di far evolvere la lingua in strumento letterario universale, non solo documentativo o immediatamente riconoscibile come "trend generazionale".