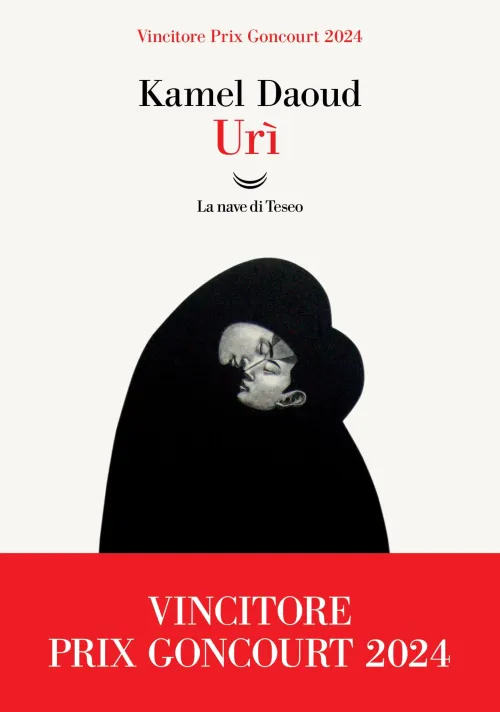L'Algeria senza voce di Kamel Daoud
Nel romanzo di Kamel Daoud Urì (La Nave di Teseo, 2025, traduzione di Simona Mambrini), la protagonista, Alba, è una sopravvissuta alla guerra civile algerina. Sfuggita a uno sgozzamento, porta nel corpo le ferite della storia, simboleggiate da un foro nella gola – lasciato per inserire una sonda che le consente di respirare, ma che l’ha resa afasica. Il tentativo di sgozzamento ha lasciato sul suo volto sfigurato una sorta di maschera permanente, simile a quella del Joker: "da ventun anni mi porto dietro questo ghigno che fa ammutolire. Un sorriso beota (...) che va da un orecchio all'altro, un arabesco sotto il mento, netto e muto; taglia la lingua in due; riproduce la gioia quando non è più gioia". Il titolo Urì (nell’originale Houris) richiama le ḥuri della tradizione islamica: vergini celestiali, incarnazioni ideali di purezza e desiderio eterno. Daoud costruisce su questo riferimento il contrasto tra l’immagine idealizzata del Paradiso opponendola a quella deformata della vita terrena di una donna sfregiata, che ha perso la voce. L’ideale delle huri, promesso come ricompensa postuma, si infrange contro la realtà dei corpi femminili disprezzati, feriti e negati in vita. Il romanzo riflette così sul rapporto tra fede e condizione esistenziale, mostrando come l’illusione di felicità ultraterrena finisca per svalutare la realtà concreta e la dignità della vita.
Attraverso Alba, Daoud compone il ritratto struggente di un’Algeria lacerata da ferite ancora aperte e da un passato che si vorrebbe seppellire nel silenzio. Alba non è una vittima passiva: ha ricostruito un'apparente normalità in un contesto sociale che la vorrebbe muta e invisibile. È proprietaria di un salone di bellezza a Orano, si veste in modo moderno, mostra fieramente i suoi sette tatuaggi, fuma in pubblico. Rappresenta una femminilità ostinata e libera. Eppure, il suo corpo racconta un'altra storia: quella di una sopravvissuta a un massacro familiare durante la guerra civile degli anni ’90. La sua fisicità, segnata dalla distruzione delle corde vocali, ne fa la testimonianza scomoda di un passato che la società preferisce dimenticare. In questo contrasto tra un corpo esposto e una voce negata si gioca la trama. Alba è muta, ma parla. Il romanzo si regge su questa apparente contraddizione: l’impossibilità di comunicare si trasforma in un nuovo linguaggio interiore che diventa racconto, confessione, necessità. Daoud adotta un espediente narrativo per far emergere la sua voce intima: Alba è incinta, e l’essere che cresce dentro di lei è l’unico in grado di "ascoltarla". A lui – o a lei – affida il racconto della paura, del trauma, della fuga, della perdita, ma anche della resistenza e del desiderio di giustizia.
Questo monologo rivolto a un interlocutore invisibile diventa il cuore del romanzo: un dialogo con il futuro, con ciò che potrebbe essere ma anche non essere mai, dato che Alba ha già deciso di abortire, lo dice nelle prime pagine. Eppure, quella creatura rappresenta l’ultima testimone possibile di una verità altrimenti destinata ad essere dimenticata. Urì affronta un tema ancora tabù in Algeria: la guerra civile degli anni ’90. Lo Stato ha scelto di non fare i conti con quel periodo sanguinoso, approvando leggi che puniscono chi ne parla pubblicamente. Daoud – che si definisce "orgogliosamente algerino" – ne è stato vittima: non ha potuto recentemente recarsi in Italia, invitato da Elisabetta Sgarbi, sua editrice, a causa del rischio di estradizione; pendono su di lui due mandati d’arresto da parte del governo algerino, con accuse di attentato all’unità nazionale, oltraggio alla memoria dei martiri della rivoluzione e diffamazione dello Stato. Le accuse sono legate proprio a Urì, vincitore del Premio Goncourt 2024 e che non fa sconti alla narrazione ufficiale della guerra civile, soffermandosi in particolare sul ruolo delle donne nelle società postcoloniali. Le autorità hanno interpretato l'opera come un attacco politico, nonostante Daoud abbia rivendicato più volte la natura strettamente letteraria del testo. È in questo clima di censura e negazione collettiva che, nel romanzo, il ritorno di Alba nel suo villaggio natale assume un valore fortemente simbolico: un ritorno alla fonte del trauma, ma anche un tentativo di riconquista della memoria. Lì dove tutto è cominciato, Alba spera di trovare risposte, se non dai vivi, almeno dai morti.

A distanza di decenni da La battaglia di Algeri (1966) di Gillo Pontecorvo, il film che raccontava con forza il trauma coloniale e la lotta per l’indipendenza, Urì si muove in un campo altrettanto carico di tensione: quello della memoria rimossa della guerra civile. Se Pontecorvo mostrava le strade di Algeri invase da bombe e ribellioni, Daoud ci porta tra i corpi sgozzati, le teste mozzate, le rovine interiori di una donna sopravvissuta non solo alla violenza, ma alla sua cancellazione. Come nel film, anche qui il corpo femminile è territorio di conflitto e simbolo politico: nella città di Pontecorvo le donne nascondevano bombe sotto il velo; in Urì, Alba nasconde con una sciarpa che copre la sua ferita e nel grembo una verità taciuta. In entrambi i casi, la battaglia più feroce è quella per il diritto a raccontare e a ricordare. All’inizio del romanzo, Alba si rivolge al figlio non ancora nato: “In pochi ricordano la guerra civile degli anni '90, e io sono la prova vivente che quella guerra durata dieci anni è esistita davvero, che è stata cruenta. Io sono l'ultima prova, ti dico. Capisci perché sono combattuta tra il desiderio di ucciderti e quello di parlarti all'infinito?”. Anche La peste (1947) di Albert Camus offre una chiave di lettura per Urì.
Anch’esso ambientato a Orano, La peste metteva in scena una città assediata dal male e immersa nel silenzio, dove la malattia diventava metafora della resistenza morale contro il dolore collettivo. In Urì, la “peste” non è un’epidemia ma il silenzio imposto, la verità che non può essere detta. Alba, come il dottor Rieux, è testimone di una tragedia che altri vorrebbero dimenticare. E come lui, sceglie di resistere, di raccontare, anche se solo a un interlocutore invisibile. Se Camus interrogava la coscienza civile sul dovere di testimoniare, Daoud lo fa attraverso una voce che emerge da dentro il corpo, da una ferita mai rimarginata. Alba e Rieux, pur così diversi, condividono una funzione simbolica: sono testimoni morali di un mondo devastato. La loro resistenza etica di fronte alla distruzione solleva la domanda su cosa resti dell’umano dopo la guerra, la tortura, il silenzio. Eppure, Urì non offre risposte ideologiche: è un romanzo profondamente morale, ma lontano da ogni dogma religioso, patriarcale o politico. Nessuna predica: solo la trasfigurazione letteraria del dolore e della dignità silenziosa.
La letteratura, qui, prende il sopravvento: non giudica, non consola. Accusare Daoud di oltraggio alla memoria nazionale perché non aderisce alla narrazione ufficiale significa temere ciò che la letteratura fa per sua natura e che l'autore ha più volte rivendicato: Urì trasfigura i fatti, che è l’opposto di tradirli. Non diffama lo Stato, ma mostra ciò che la sua retorica rimuove: i corpi, il non detto, le voci escluse dal monumento e dal discorso celebrativo, la storia nazionale eroica e maschile che ignora i traumi, le identità marginali, le contraddizioni. Nei mesi successivi alla pubblicazione, Urì ha suscitato nuove polemiche. Una donna francese ha accusato Daoud di aver incluso nel romanzo, senza consenso, elementi tratti dalla sua esperienza personale, legata a una conversione all’Islam e a una radicalizzazione familiare. Il tribunale ha accolto la denuncia per violazione del segreto medico, ritenendo sufficienti le somiglianze tra la sua storia e quella di Alba per avviare un procedimento. Anche se sarà la giustizia a stabilire eventuali responsabilità, la questione letteraria è già aperta: Urì si muove lungo il confine sottile tra ispirazione e appropriazione, tra immaginazione e testimonianza e interroga, senza retorica, la responsabilità dello scrittore di fronte al dolore degli altri. Daoud scrive con una prosa densa, lirica, a tratti poetica.
Ogni frase è cesellata con cura, a volte con un sospetto di artificio: “le conchiglie che il mare perdeva dalle tasche lungo la spiaggia deserta”, “mi entrano i cani nel petto”, “ci annodavano lo stomaco come a marinai”, “ti sembra che tutta la legna secca della tua vita ti arda nei polmoni”, “la vita è un sacco di iuta cucito addosso a me”. Ogni immagine porta con sé il peso del silenzio e della sofferenza. Ma il lirismo della scrittura di Daoud non è gratuito: è una lingua che si fa carico di ciò che è stato rimosso, che dà corpo a una verità invisibile e scomoda. La scelta di affidare la narrazione a una donna – muta, per giunta – è insieme un gesto di pietà e di sovversione. In un mondo che silenzia le donne e censura la memoria, Daoud restituisce voce a entrambe. Urì è un romanzo che intreccia cronaca, confessione e poesia, mosso da un’urgenza civile: capire cosa significhi davvero sopravvivere, non solo fisicamente, ma emotivamente e politicamente, a una tragedia collettiva. In questo senso ferisce, interroga, impone di non distogliere lo sguardo. E restituisce voce a chi non può più parlare.