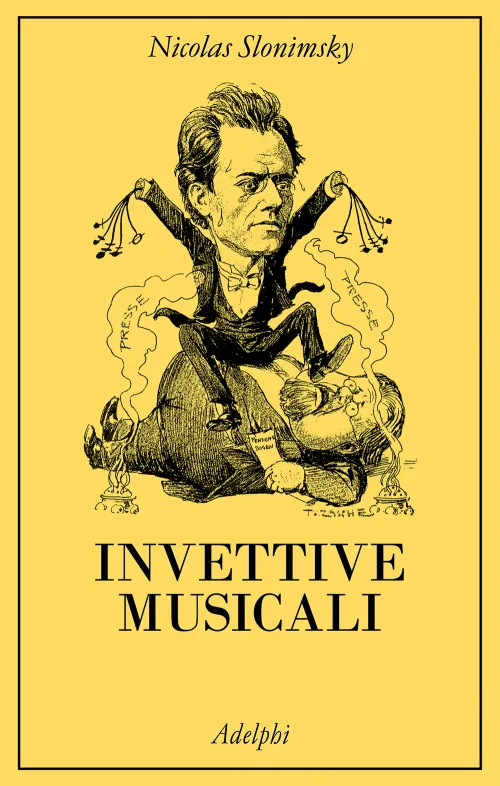Invettive musicali
Il cane Droopy, ossessionato dalla musica dixie, che riproduce incessantemente il suo prezioso vinile accompagnando i suoni con una bacchetta da maestro, irritando il suo vicino di casa, infilando il disco in un jukebox, in una giostra del circo, dentro all’organetto a manovella di un suonatore di strada, provocando convulsioni e spasmi ritmici alla sua scimmietta (Dixieland Droopy). Oppure Mr. Twiddle, suonatore di congas in un ensemble jazz, tramortito dai fiati, i tromboni che sparano note nelle sue orecchie a tal punto da procurargli convulsioni. Il medico consiglia riposo assoluto sui monti delle Alpi, con risultati catastrofici (Sh-h-h-h-h-h).
E noi, come questi cartoons di Tex Avery, che reazioni mostriamo nei confronti di una musica che ci appare disturbante, assai poco familiare? Di intolleranza, il più delle volte. Quando metto sul piatto gli Streichquartett di Heinz Holliger (1973), Dziga, la gatta di casa, drizza il pelo, inclina le orecchie. Appare infastidita e se ne va. Quel magnifico stridìo acuto e discontinuo di corde è qualcosa di inaudito, tale da colpirci non solo acusticamente, ma fisicamente. E viene da pensare che le reazioni dei critici musicali che ritroviamo compliate qui, all’interno del libro di Nicolas Slonimsky, Invettive musicali (a cura di Carlo Boccadoro), da poco edito da Adelphi, devono essere state simili alle sue.
Ciò che noi oggi consideriamo imprescindibili capolavori della musica classica, sinfonica, hanno in verità conosciuto tempi difficili. Da Beethoven, fino a Schönberg, Webern, Berg, Varèse, passando per Stravinskij, Mahler, Wagner, non facciamo altro che incrociare ire, giudizi furenti, sarcastici, sprezzanti. Il salto temporale che separa la recensione dai giorni nostri ha reso armonico ciò che sembrava un tempo caotico, dissonante e inaudito. Per questo motivo, il libro somiglia a un excursus nella storia del gusto capace di strappare più di una risata. Invettive musicali è, da questo punto di vista, un libro di comicità sopraffina.
Prendete questa recensione della “prima” americana di Le sacre du printemps: «Lo strisciare del Paleozoico, trasformato in suoni con tutte le risorse dell’orchestra moderna, ha richiamato l’attenzione al concerto della Philadelphia Orchestra in cui Le sacre du printemps di Igo’ Stravinskij ha avuto la sua prima esecuzione da questa parte del vasto Atlantico. Era un primitivismo impazzito, quasi senza forma né tonalità definita, eccezion fatta per dei ritmi che picchiavano insistenti e al confronto facevano sembrare supersofsticate le melodie eseguite sul tam-tam dalle gentili tribù del Congo... Senza alcuna descrizione o programma di sala, il lavoro avrebbe potuto far pensare a un raduno di alcolizzati per Capodanno e ai passatempi naturali di giovanotti e fanciulle, prudentemente abbigliati con una foglia di fico a testa», riporta The North American, Philadelphia, 4 marzo 1922.
La prima della Sagra, è noto, fu un disastro. Uno scandalo di cui Stravinskij sembrava non essersi accorto. Nei sui Ricordi e commenti, raccolti da Robert Craft, egli sottolinea come gli amici musicisti, che avevano ascoltato le prove, sembrassero affascinati dalla composizione. «Debussy, nonostante il suo successivo atteggiamento ambiguo (“C’est une musique nègre”), alle prove era entusiasta», ricorda. Lavoro complicato, esasperante. Soprattutto per i danzatori. «Dopo mesi di prove i ballerini sapevano cosa fare, anche se spesso questo non aveva niente a che vedere con la musica. “Conto fino a quaranta mentre suoni,” mi diceva Nižinskij “vedremo dove ci troviamo”. Non capiva che se anche a un certo punto ci trovavamo insieme, questo non voleva dire che fossimo stati insieme fin lì. I ballerini seguivano il tempo di Nižinskij anziché quello della musica. Nižinskij naturalmente contava in russo, e dato che i numeri russi sopra il dieci sono polisillabici – diciotto, per esempio, è vosemnadcat’ – nei tempi svelti né lui né loro riuscivano a stare al passo con la musica».
La lettura del libro è una scoppiettante navigazione tra numerosi termini che diventano occorrenze: shock, mal di testa, ululare, rumore, anarchico, confusione, convulsione, perverso, balbettante, miagolio, atrocità, singhiozzare, caos, spazzatura. Il lungo inventario terminologico lo trovate nell’indice, in coda al libro. Apoteosi. «Ho sofferto più che in qualsiasi altra occasione in vita mia, con l’eccezione di un paio di incidenti connessi all’odontoiatria “indolore”», scrive Percy A. Scholes a proposito del tocco pianistico di Bartók. («The Observer», Londra, 13 maggio 1923)

Potremmo considerare Invettive musicali una magnifica cavalcata nel charivari, termine il cui enigma etimologico è stato studiato e approfondito da Karl Meuli nel suo Gli dèi incatenati. Di cosa si tratta? Cosa cela? «Secondo Mörland e Svennung l’etimo va ricercato nella parola caribaria (tramandata dal latino Oribasio), greco καρηβαρα, “mal di testa”». Meuli, prima di deviare e proporre una nuova interpretazione etimologica, segnala come W. von Wartburg, rifacendosi a Svennung, spieghi il suo significato «a partire dall’effetto che un’assordante musica stonata esercita sulla testa dell’uomo». Evoluzione semantica: “mal di testa” > “baccano”. Rumore confuso. Un caos.
Prendete Wagner: «La musica del Tannhäuser è tumultuosa, assordante, infernale. Ci sono acuti esasperati, piatti inferociti, cappelli cinesi in delirio. Produce lo stesso effetto, e lo stesso dolore, di cento aghi che vi trafiggano l’orecchio contemporaneamente. Gli ascoltatori più gentili, che volevano mantenere un comportamento dignitoso, hanno sofferto senza muoversi; altri si torcevano sulle loro sedie cambiando posizione, come san Lorenzo sulla sua graticola», ci informa Pier Angelo Fiorentino, nel Boston Musical Times, 20 aprile 1861. E ancora: «Il Preludio del Tristan è un caos selvaggio di note. È stato come se una bomba fosse caduta dentro una grande fabbrica di musica e avesse gettato tutte le note in disordine», nota J. Stettenheim, sulle pagine di «Tribüne», Berlin, 6 febbraio 1873.
Gli anni passano, nuovi compositori si impongono e ciò che appariva perverso, degenerato, viene recuperato, se comparato ai nuovi suoni. Lo segnala anche Charles Rosen, nelle prime pagine della sua magnifica biografia su Schönberg: «Il wagnerismo del Sestetto per orchestra d’archi Verklärte Nacht (Notte trasfigurata), composto quando Schönberg aveva ventisei anni, causò qualche difficoltà. “È come se qualcuno avesse imbrattato la partitura del Tristano ancora fresca d’inchiostro”, osservò un contemporaneo». Un’associazione viennese rifiutò l’opera in cartellone perché conteneva una dissonanza, «allora inclassificata nei trattati». Un sibilo. Da qui ha inizio la radicale rottura con l’Ottocento. Fischi, tumulti, boati. Come ben coglie Rosen: «La resistenza alla radicale rottura di Schönberg con la tradizione dell’Ottocento fu inevitabile quanto la rottura stessa, e questa resistenza, come vedremo, si riflette nella musica medesima».
Charivari. L’idea del mal di testa ci affascina. Emicrania. Questo baccano avvicina a uno stato auratico? Qualcosa ci tocca. L’aura ha un effetto simile sul senso del tatto. In Emicrania, Oliver Sachs ricorda come, a partire dai greci, la definizione medica di aura unisca tatto e vista, grazie all’incontro con la sostanza dell’aria, del respiro, del vapore – o dei suoni, potremmo aggiungere. L’aura è quello stato che anticipa le crisi epilettiche. Un tocco che dal corpo arriva fino alla testa. Un po’ come la reazione degli spettatori al Tannhäuser di Wagner: San Lorenzo sulla graticola.
Ma torna alla mente anche un’altra figura. La segnala Ramón Andrés nelle prime pagine del suo libro, Il mondo nell’orecchio. I musicisti afflitti da sordità cadono nella malinconia, indole saturnina di cui soffrono uomini di genio e probabilmente anche i critici. Una dolce melodia può mitigare il ronzio di sibili e acufene – chiari riferimenti alla bile nera (dal greco mélas e cholḗ). Non è un caso che la figura del malinconico, in ascolto con la testa reclinata sulla mano, ritorni copiosamente nell’iconografia tra Quattrocento e Seicento. Dolore dell’anima. Melancolia I di Dürer, certo. Ma non solo. «Sempre Dürer, in riferimento ai sibili o ronzii acustici ricorrenti, inserisce nel Sogno del dottore (1497-1498) una figura demoniaca che aziona un mantice direttamente nell’orecchio del vecchio, ignaro nel suo sopore». Urge dunque una melodia per placare i mal di testa dei critici musicali? «Dopo il Lohengrin ho avuto un terribile mal di testa, e per tutta la notte ho sognato un’oca», scrive Milij Balakirev, in una lettera a Vladimir Stasov, datata San Pietroburgo, 3 novembre 1868.
Slonimsky, nel suo saggio conclusivo, parla di “rifiuto dell’insolito”. È ciò che nell’Ottocento accadeva, per esempio, davanti alla musica che arrivava dall’Oriente. Berlioz nel 1851 la considerava, con i suoi «miagolii, grida di sciacalli, di cani, di tacchini, di agonizzanti, di vampiri appena nati, sibili di serpenti, fracasso d’inferno, come le parrucche stile 1830 o esattamente come i caricaturisti potevano giudicare la sua stessa musica – o come si giudicava, nel 1954, Déserts di Edgar Varèse, che una parte del pubblico degli Champs-Élysées accompagnava a volte con grida d’animali», sottolinea Jean-Claude Lebensztejn nel suo Miaulique. I miagolii dei gatti hanno offerto ai critici vivido materiale per nuove invettive musicali.
Dietro a questi improperi, dietro all’oltraggio morale, c’è lo scandalo che nello stesso periodo colpiva la pittura, le altre arti. Sono i movimenti d’avanguardia che si fanno strada, e non vengono accettati. Eppure, come ricorda Rosen, quello che questi musicisti e le avanguardie stavano ricercando, non era certamente volontà di insolentire, turbare, o sconvolgere. Non solo. «Gli artisti, Schönberg incluso, erano soprattutto consapevoli di muovere l’immediato fra i passi logici e ragionevoli, di eseguire un compito che era già a portata di mano, e che aveva da essere compiuto. In un certo senso, le rivoluzioni stilistiche di quegli anni erano soltanto la realizzazione di possibilità già presenti nei linguaggi artistici, il delinearsi di non più evitabili conclusioni. Cionondimeno, il senso di ribellione non può essere con facilità eliminato. Vi è nella musica e nell’arte di quel periodo molto di deliberatamente provocatorio, ch’esprime uno sprezzo, perfino un profondo orrore, per la società nella quale l’artista viveva». Charivari significa anche ingiuria verso qualcuno.
Ma c’è altro. Invettive musicali è un libro ingegnoso, con una parte nascosta, come una figura nel tappeto. Leggendo tra le righe, questo catalogo, le insolenze, le critiche che a cascata riempiono le pagine, ci dicono qualcosa di più del disprezzo, della trivialità, della facile risata. Spesso, queste ingiurie colgono più precisamente la novità delle opere. Vogliamo dire che, pur nella stroncatura, giungono al vero nocciolo della loro natura compositiva.
Si prenda Mahler. «Ein Heldenleben e Also sprach Zarathustra di Richard Strauss sono chiari come acqua in confronto alla Quarta sinfonia di Gustav Mahler ... L’Adagio all’inizio è abbastanza inoffensivo, a parte un abuso dell’effetto di pedale, ma improvvisamente ci troviamo dentro una scena circense: per qualcuno sarà magari una digressione benvenuta, ma, senza voler essere pedanti o tradizionalisti, non possiamo tacere che per noi, al momento, è stato uno shock, e uno shock sgradevole», riporta il «Musical Courier» di New York, il 29 gennaio 1902. Come non vedere che, pur nello sprezzo, nella boutade, ritroviamo qui esattamente le illuminanti riflessioni che anni dopo proporrà T.W. Adorno nel suo saggio sul compositore boemo? «Tutta la Quarta sinfonia rimescola a caso inesistenti canzoni infantili: per lei il libro d’oro della musica è anche il libro della vita. Lo strepito di tamburi battuti da fanciulli non ancora settenni, è simile a quello che fa la grancassa in questa sinfonia: essa è il tentativo solitario di comunicare musicalmente col déjà vu, è un tentativo di colore sincero come l'imago di un carrozzone di zingari o di una cabina marinaresca».