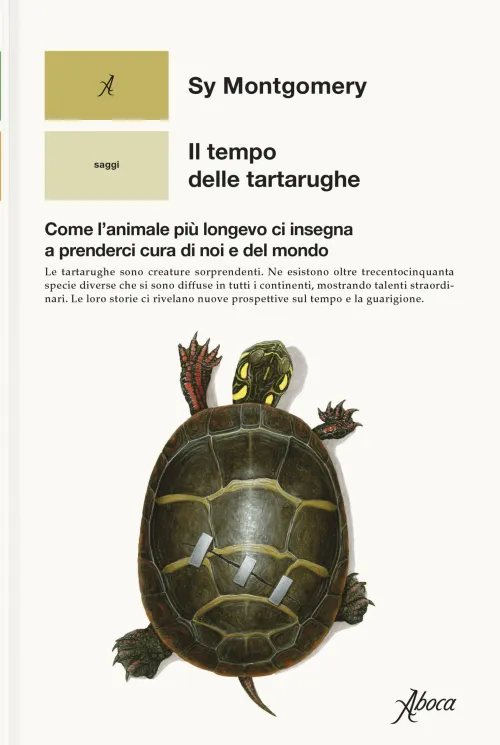La saggezza delle tartarughe
Come si evidenzia dal titolo, sia quello originale che quello in italiano, a stare al centro del libro della naturalista e scrittrice americana Sy Montgomery, c’è Il tempo delle tartarughe (edito da Aboca e tradotto da Teresa Albanese). La parola tempo, nel testo, possiede sensi stratificati: il più immediato rimanda alla cura verso le tartarughe, al tempo che dedica loro chi si occupa dei corpi degli animali menomati da incidenti, malattie, negligenza dei proprietari; il più articolato si riferisce al rapporto della tartaruga con il tempo, alla lentezza e alla longevità, ma anche alla profondità della storia delle numerose specie (oltre 360), le cui origini sono parallele a quelle dei dinosauri, rimontando a più di 250 milioni di anni fa. Le due accezioni peraltro si sovrappongono, perché il tempo della cura si spiega anche con la vertigine della durata: salvare una tartaruga vuol dire assicurare una discendenza di più generazioni: si configura quindi come un dono (o un risarcimento) al futuro, un andare oltre gli immediati confini dell’umanità contemporanea. Ma non è tutto. C’è un altro tempo – il periodo in cui i fatti avvengono – che fa da cornice e da propulsore alla narrazione ed è quello sospeso degli anni del Covid, durante il quale l’autrice, liberandosi “dalla trappola della propria disperazione”, è entrata in relazione con il mondo delle tartarughe, a cui ha aperto la strada anche la restrizione della libertà di movimento e l’alterato rapporto con il tempo imposti dal lockdown. Il libro di Montgomery è dunque più cose, tutte assieme. È la descrizione di un periodo trascorso a contatto con le operatrici del TRL (Turtle Rescue League); è la storia di amicizie umane e tra umani e animali; è una riflessione su cosa siano la saggezza, l’equilibrio e il rispetto verso chi è anziano o malato con relativa accettazione dell’imperfezione; è un’indagine sui motivi per cui una specie – la nostra – comprende assassini (spesso ignari, colpevoli prima di tutto di indifferenza) e buoni samaritani, disposti a sacrificare se stessi, le proprie finanze e il proprio tempo per salvare altre forme viventi.
Proprio quest’ultimo è il principale innesco di Il tempo delle tartarughe e, senza dubbio, anche il suo tessuto connettivo. Perché vivere con gli animali? Perché dedicare a loro una parte consistente della propria esistenza? Perché cercare di salvare le loro vite? Perché scriverne? Sicuramente non per fuggire dai propri “conspecifici”, nessuno dei protagonisti del libro è sociopatico, anzi. Forse per empatia, magari perché si è misurata su di sé la sofferenza, fisica e morale (Alexxia e Natasha, responsabili del TRL, sono transgender), provocata dall’esclusione sociale. Oppure perché, messe da parte le remore dell’antropomorfismo con i timori di inventarsi quello che non c’è, si avverte la possibilità di stabilire una relazione anche con chi viene ritenuto estraneo e di imparare qualcosa da come lui sta nella vita. Con certezza, comunque, dedicarsi agli altri non è mai percepito come un sacrificio, semmai come un continuo travaso di energia e di fiducia verso la vita. Così, se per uno dei volontari, l’insensibilità verso gli animali è “un segno di povertà intellettuale” e di “ingenuità o ignoranza”, Montgomery, da naturalista, è dell’idea che “dal punto di vista evolutivo, ha senso che una cosa complessa come la personalità non si evolva dal niente negli esseri umani”. Siamo fatti di altri animali, come siamo fatti di altre persone, insomma.

La relazione uomo-animale descritta da Montgomery sembra fatta apposta per sollecitare queste domande. Perché le destinatarie delle opere di soccorso del TRL sono tartarughe (stiamo usando la parola in modo generico, ma propriamente il termine tartaruga va applicato alle tartarughe di mare e testuggini alle tartarughe d’acqua dolce e di terra) che arrivano al loro centro in condizioni disperate, talvolta col carapace e gli organi interni schiacciati dalle auto, talvolta con gravi forme di infezione o di malnutrizione. Animali che hanno bisogno non solo di un intervento per risanare la ferita ma anche di lunghi periodi di degenza, di estenuanti sedute di fisioterapia, o, come nel caso di Fire Chief, una maestosa “azzannatrice” con le zampe posteriori paralizzate, di mettere a punto addirittura delle apparecchiature per consentirne la deambulazione sulla terraferma. Di fronte a tutto questo è inevitabile chiedersi perché. Lo fa l’autrice, spiegandoci che il suo interesse di naturalista l’ha portata quasi per caso a individuare l’attività del centro di soccorso insieme all’amico Matt, un artista della fauna selvatica. Lo fanno, continuamente, Alexxia e Natasha, che hanno scoperto la loro vocazione dopo aver investito una tartaruga ed aver messo in atto quello che non avrebbero mai più ripetuto, ovvero farla smettere di soffrire schiacciandola con la ruota dell’auto. Le risposte, potremmo dire, si trovano per strada, facendo quello che il caso ogni giorno ti porta ad incrociare, nella consapevolezza che qualsiasi successo – una vita salvata – sia significativo, ma debba anche fare i conti con il dolore del fallimento. Le risposte d’altra parte non possono fare a meno di soffermarsi su un fatto che per tutti coloro che Montgomery descrive corrisponde a una granitica certezza: le tartarughe sono speciali. Vivendo con loro non si può non subirne il fascino, ma è vero anche che le tartarughe piacciono a tutti, e sono gli unici rettili che producano su Sapiens questo effetto. Certo, l’impressione comune è dettata dall’incrocio di percezioni di superficie: ne ammiriamo la forma originale, la bellezza geometrica del guscio, la primordialità delle parti di corpo che riusciamo a intravedere; e poi le tartarughe non ci spaventano, “non mordono quasi mai, non strisciano e non si muovono troppo in fretta”; in compenso, siamo convinti che non abbiano grande intelligenza e che la lentezza le privi della possibilità di conoscere davvero il mondo e di stabilire un rapporto profondo con noi. Quindi animali iconici – regalo perfetto per un bambino – ma freddi compagni di vita. Ebbene, ogni pagina, diremmo quasi ogni riga di Il tempo delle tartarughe, serve ad aggiustare la percezione che noi abbiamo delle tartarughe, a capirle meglio.
Cosa veniamo a sapere? In primo luogo che la lentezza e l’immobilità non hanno nulla da spartire con la scarsa intelligenza o con una limitata comprensione del mondo. Tutt’altro. Alla domanda, in verità sempre piuttosto inconcludente, se le tartarughe siano intelligenti, si deve rispondere che sì, ciascuna di loro lo è, in rapporto alle esigenze della specie e dell’ambiente in cui vivono. Ma non si può negare che alcune di loro, le “testuggini scolpite”, abbiano straordinaria intelligenza: “Negli esperimenti capiscono al volo come funzionano i labirinti, e hanno capacità di mappatura simili a quelli dei ratti”. Non è nemmeno vero che le tartarughe siano “esseri silenziosi”. Pur prediligendo “una comunicazione muta”, diverse “sono piuttosto loquaci, e alcune specie gracchiano, squittiscono, ruttano, uggiolano e fischiano”. I piccoli di certe specie d’acqua dolce di Australia e Sudamerica “comunicano oralmente tra loro e con le madri quando sono ancora dentro nell’uovo”. Se tendiamo a fraintenderle è perché le tartarughe “non possono contare sulle espressioni facciali dei mammiferi”: questo ci porta a non capire che “hanno personalità distinte e vivono emozioni forti”. A dividerci, è soprattutto la loro lentezza. Le tartarughe “vivono lentamente. Respirano lentamente. I loro cuori battono lentamente (le tartarughe dalle orecchie rosse possono arrivare a un battito al minuto)”. Con lentezza reagiscono ai farmaci, rendendo spesso inutile l’uso di antidolorifici, che potrebbero aver bisogno di ore o giorni per essere efficaci. Se guariscono lentamente sono però in grado di rigenerare il tessuto nervoso, anche quando, è stato il caso di Fire Chief, “il midollo spinale è tagliato in due”. La lentezza è strettamente correlata alla longevità, probabilmente uno degli elementi che più ci porta a guardarle con sacrale ammirazione: ci sono tartarughe che sfiorano i 300 anni o che riescono a partorire ben oltre i 100. Del resto, anche la loro morte è lenta e talvolta si fatica a capire se davvero sono scomparse. I loro “superpoteri” lasciano a bocca aperta: possono percepire la presenza di un lago o di uno stagno a un chilometro e mezzo di distanza; alcune migrano attraverso gli oceani per ritornare esattamente nella spiaggia dove erano uscite dall’uovo molti anni prima; alcune respirano dal posteriore, altre fanno pipì con la bocca; alcune rimangono attive sotto uno strato di ghiaccio, “altre si arrampicano su alberi o staccionate”. I loro corpi hanno colori e forme diverse: “Alcune sono rosse, alcune sono gialle, e altre cambiano drasticamente il colore una volta l’anno”. Alcune hanno il guscio morbido, altre il guscio che splende al buio. Alcune hanno il collo più lungo del corpo, altre la testa così grossa che non può essere ritirata nel carapace.

Se a tutto questo si abbina la scoperta del loro sguardo, col quale stabiliscono un contatto profondo con noi; la meraviglia della nidificazione e della nascita di nuovi esemplari; la conoscenza ancestrale del pianeta (sono “scienziate del suolo”); la straordinarietà della brumazione invernale, che permette loro “di ingannare la morte, emulandola”, ci si sorprende meno se c’è chi arriva ad attribuire alle tartarughe un’anima. O che, in molti miti fondativi, all’inizio dei tempi ci sia una tartaruga.
Ebbene, per tanti motivi – il commercio, il nutrimento con i loro corpi o le loro uova, il traffico delle auto, la cementificazione delle coste, il riscaldamento climatico – le tartarughe sono tra le specie più a rischio di estinzione. In pratica chi era riuscito a resistere alla caduta dell’asteroide che ha annientato i dinosauri ora vede il proprio futuro compromesso dall’azione della specie umana. E allora forse si comprende quale molla stia dietro all’azione di chi cerca di salvare il maggior numero possibile di tartarughe da quella morte che la loro specie terrebbe così lontana da sé. È forse la “vergogna” (o il disonore) di cui parla lo scrittore sudafricano Coetzee nel romanzo eponimo, quella che porta il protagonista a dare degna sepoltura ai cani soppressi dal veterinario? È, detto altrimenti, il bisogno di riparare il danno profondo che abbiamo provocato assecondando il desiderio di sottomettere la natura alla nostra volontà? Forse, come scrisse Konrad Lorenz in Gli otto peccati capitali della nostra civiltà è solo ritornando ad ammirare la natura, riposizionandoci là dove noi stiamo realmente, che possiamo interrompere il cammino verso l’autodistruzione. Due gesti descritti da Montgomery sembrano suggerire questa direzione. Il primo è il rilascio delle tartarughe guarite, il momento in cui finalmente vengono restituite al loro habitat: “Un atto di devozione definitivo per un riabilitatore”. Il secondo è la sepoltura delle tartarughe che non ce l’hanno fatta. Una cerimonia, breve ed essenziale, in cui i presenti ricordano qualcosa dell’animale che stanno per inumare, con la certezza che, in qualche modo, superato il cordoglio, lui rimarrà per sempre con loro.