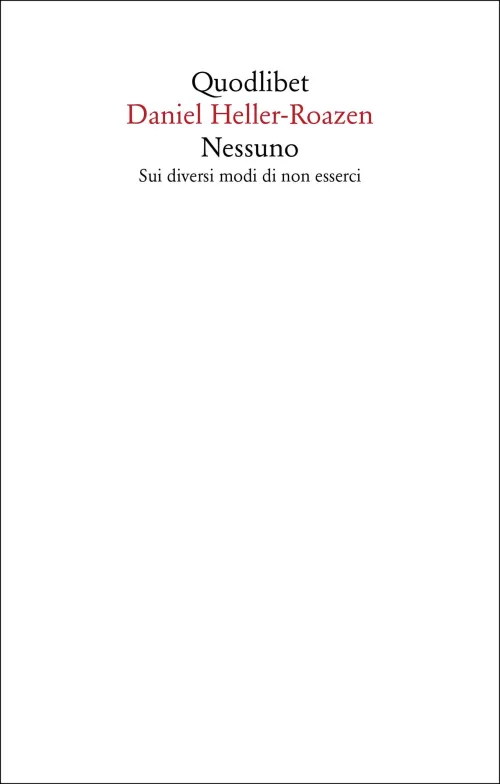Scomparsi, diminuiti e deceduti
Il vivente ribolle di “inumane esistenze”, dalle piante agli animali. Infinite modalità sono offerte anche dagli oggetti inanimati, dai minerali alle macchine. Tutte possibilità di “non essere qualcuno”, cioè di stare qui senza fare parte dell’umanità. A Daniel Heller-Roazen, docente di letterature comparate a Princeton, interessano però i modi solo umani per slegarsi dall’appartenenza alla nostra “classe” e, di conseguenza, acquisire lo status di non-persona. Qual è la strada da seguire? È sufficiente entrare nella categoria di chi, come è spiegato in Nessuno (edito da Quodlibet con la traduzione di Giuseppe Lucchesini), possiede una caratteristica comune: è assente. Servendosi della letteratura, del mito, dell’antropologia, del folclore, del diritto, Heller-Roazen individua tre ordini di non-persone: chi è scomparso per fare poi spesso inopinati ritorni; chi è stato diminuito nelle sue prerogative; chi ha abbandonato la vita terrena. Di fatto le non-persone sono “legione” e, soprattutto, sono un insieme dal quale nessuno può ritenersi escluso. Come rivelano le “conte” dei bambini, “essere qualcuno” (quello che “sta sotto”) significa essere esposti – regolarmente e ripetutamente – “ai molti modi di essere it”.
Iniziamo dagli scomparsi, tra cui si trovano quanti hanno deciso di andarsene per scelta, come il Wakefield di Hawthorne che, senza motivo, lascia la moglie per vent’anni pur abitandole a fianco; o quelli che si sono allontanati per necessità, la guerra in particolare. Durante l’assenza, la “prassi giuridica, sociale, rituale e religiosa ricorre a un comune espediente. Si realizza un doppio”. Il corpo giuridico, che sussiste in assenza del corpo fisico, è letteralmente una persona, una “maschera, attraverso la quale una voce diviene udibile, per-sonat”. Se, successivamente, alla legge interessa stabilire quando chi è scomparso possa essere dichiarato morto, il mito e la letteratura si occupano dei modi e dei motivi per cui si scompare. Coloro che agli occhi del diritto sono esclusivamente assenti, nel racconto possono prendere la parola, descrivere la loro esperienza e riferire “le inquietanti circostanze del loro ritorno”. Il modello è Odisseo, che, transitando da un’assenza all’altra, solo alla fine dei viaggi offre un resoconto completo di come abbia fatto rientro a Itaca. Perché ritornare comporta rischi. Lo dimostra un caso storico: quando, nel XVI secolo, il vero Martin Guerre fa ritorno alla sua residenza, smaschera l’impostore che si è impossessato della sua abitazione e della moglie. Nasce, nella realtà, uno schema narrativo ricorrente: non a caso, “i mariti che si ostinano a tornare infestano la letteratura francese del XIX secolo”. In Il colonnello Chabert di Balzac, il militare che si credeva caduto durante la battaglia di Eylau, nella Prussia orientale, riappare e desidera riacquisire i diritti di cui disponeva quando era in vita. Ma ormai le sue proprietà appartengono alla moglie. Capendo di non avere più possibilità alcuna, Chabert va a vivere in una casa di riposo, dove il suo nome è sostituito da due numeri: diventa il centosessantaquattro della settima camerata. Maupassant in Il ritorno descrive un marinaio che dopo dodici anni torna a casa dalla moglie trovandola risposata. Non vuole sconvolgerle la vita, per sé desidera solo la casa paterna dove è nato e, nella scena finale, si mette in cammino insieme al nuovo marito per andare dal prete a “mettersi in regola”. Zola in La morte d’Olivier Bècaille racconta la storia di un uomo sepolto vivo. Dopo aver fatto ritorno alla sua abitazione, il protagonista apprende che la moglie è andata a Parigi insieme a “un gradevole conoscente”. Olivier, consapevole di essere stato per lei niente più che un “fratello”, decide di scomparire dalla scena, evitando di commettere la “crudele stupidaggine di resuscitare”. Sempre Zola in Jacques Damour racconta come il protagonista eponimo, un comunardo, ritorni in Francia dopo un periodo di deportazione e, trovando la moglie risposata, decida di vivere “da morto”. È la stessa condizione in cui Pirandello colloca Mattia Pascal, che rifiuta la “resurrezione legale” per evitare di rendere nullo il nuovo matrimonio della moglie e illegittimo il bambino della coppia. Fuori dallo schema omerico è Karl Rossmann di Kafka che “vagabonda senza posa, e senza sembrare il soggetto di un singolo caso di sparizione”. Per il protagonista di America (ma il titolo pensato da Kafka era più centrato: Il disperso) non c’è né partenza né ritorno.
L’assente viene sostituito da immagini. Talvolta possono essere la inevitabile traccia della sua vita: come scrive Eschilo nell’Agamennone, Elena, rapita da Paride, ne ha lasciate ovunque nel palazzo di Menelao, che però le detesta. Frequentemente l’immagine è costruita apposta e ha almeno tre funzioni specifiche: stabilire rapporti corretti tra i vivi e i morti, attirando “un doppio che si trova in condizioni anormali” (come il “kolossòs” greco); per amore: all’origine della scultura e della pittura – scrive Plinio il Vecchio – c’è il gesto del vasaio Butade che modella con la creta il profilo del giovane, ormai distante, amato dalla figlia. E poi ci sono le immagini realizzate per infamia, ovvero per deprivare di onore e di rispetto chi è andato contro le regole. A Roma, dove il diritto stabilisce “moltissimi gradi di infamia”, le immagini di chi ha cattiva reputazione sono ovunque; nelle città italiane del Medioevo è praticata la “pittura infamante”: è l’esito dell’esecuzione di una sentenza civile che, anche se ha lasciato rari esempi, ha coinvolto, spesso obbligati, artisti come Botticelli, Andrea del Sarto e Andrea del Castagno. Nel XVI secolo è ancora viva l’“executio in effigie”, la punizione iconica degli assenti.
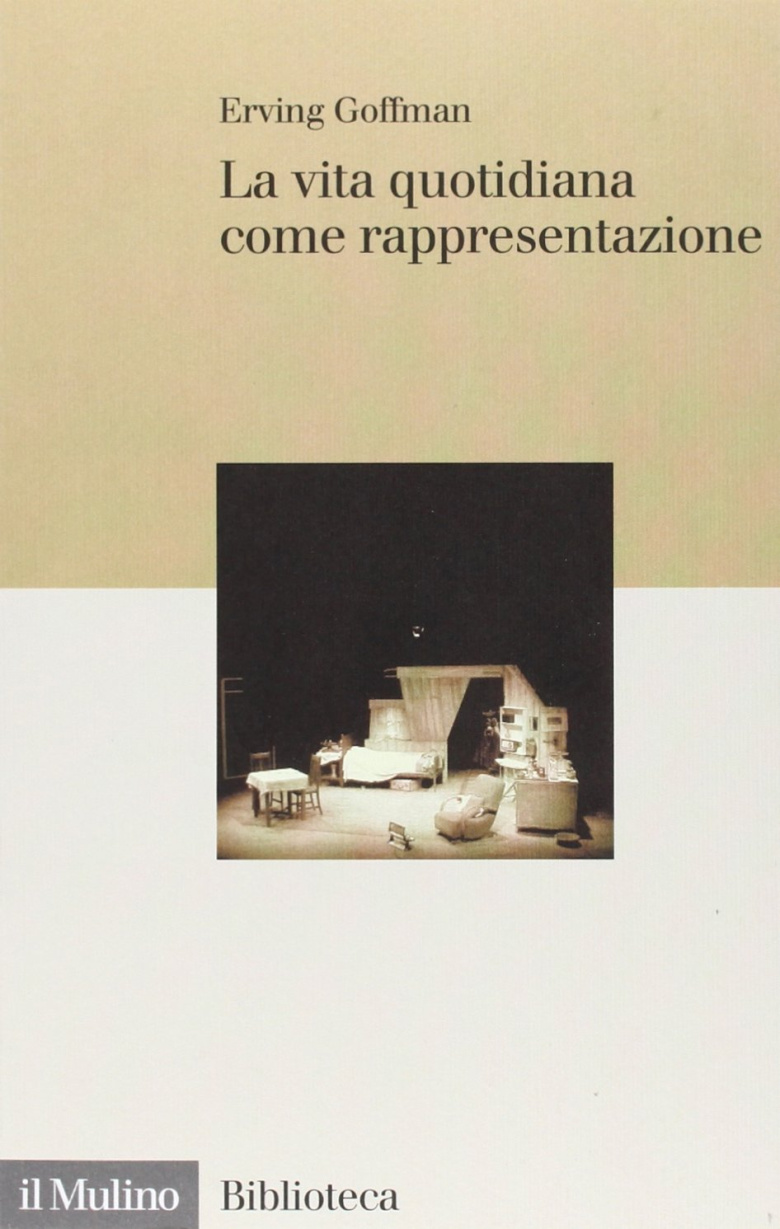
I “diminuiti” sono invece vivi e presenti, ma hanno perso, almeno in parte, il loro “diritto alla rappresentazione”. Detto altrimenti: sono non-persone perché non considerate alla pari di chi possiede lo statuto di persona. Nella Roma antica la “capitis deminutio” è più una regola che un’eccezione. Si verificava in tre modi: con l’adozione, la perdita della cittadinanza, la schiavitù (lo schiavo è una cosa). Ma anche gli stranieri, le donne e i minorenni erano “carenti d’umanità”. La casistica è ampia: chi era dichiarato “Homo sacer”, per esempio, poteva essere ucciso da chiunque o diventava schiavo. Nel medioevo i canonisti delineano la condizione di “morte civile”, estesa a esiliati, fuorilegge, schiavi e, piuttosto sorprendentemente, ai monaci. Una diminuzione che non viene cancellata nemmeno dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino nel 1789 e che, con l’interdizione legale, sopravvive fino ad oggi. Spesso alla diminuzione corrisponde l’ignominia, la privazione del nome, considerato elemento sostanziale della persona. La prassi ha origini nella Roma repubblicana, dove la nota censoria poteva comminare una “sanzione scritta”, che determinava l’acquisizione del “cattivo nome”. Le pratiche che determinano la privazione del nome possono essere tanto reali quanto quotidiane. Goffmann in La vita quotidiana come rappresentazione ha spiegato che una persona può essere esclusa dalla considerazione in modo automatico, “a causa del suo basso rango cerimoniale”. Si tratta dei domestici, dei pazienti psichiatrici e del personale tecnico. Tuttavia, anche “i giovanissimi, i vecchi e i malati” sono esempi comuni di questa condizione. Ma la mancata cura – l’annullamento dell’altro – è ingannevole perché risponde anche a un principio di buona educazione. Non è bene fissare l’attenzione su chi incrociamo per strada.
La letteratura ha trattato l’argomento del marchio infamante: in La lettera scarlatta di Hawthorne, Hester Prynne deve esibire la lettera A in pubblico per aver avuto un figlio fuori dal matrimonio. In 1984 Orwell definisce “unperson” le persone inesistenti. Un particolare stigma è stato impresso sul capitano Gulliver. Per il protagonista del romanzo di Swift “l’umanità fa parte della specie degli Yahoo, con la quale egli non si riconcilierà”. Tra i paradossali effetti dell’ignominia, in letteratura, c’è la sopravvivenza di chi ne è stato vittima. La letteratura francese medievale presenta una lunga serie di “eroi stolti”: Chrètien de Troyes, Perceval, Lancillotto, Yvain, Tristano. Nella parallela letteratura norrena le “saghe dei fuorilegge” propongono personaggi che subiscono una diminuzione civile. Nella letteratura araba pre-islamica ci sono i “poeti banditi” che parlano delle proprie imprese in prima persona. All’inizio del XIX secolo Adelbert von Chamisso in Storia straordinaria di Peter Schlemil fa del suo personaggio un escluso dalla società per aver scambiato la propria ombra con la “borsa di Fortunatus”, da cui viene estratto l’oro. Messo ai margini, Schlemil rinuncia alla ricchezza e diventa un “filosofo naturale”. Ma, a causa di un incidente, picchia la testa, perde conoscenza e si risveglia in ospedale dove viene identificato dal numero dodici. Schlemil diventa lui stesso un’ombra, riconosciuto solo dal suo vecchio cane Figaro. Come evidenzia Heine nel Romanzero (e Chamisso non lo ignorava) il nome Schlemil ha ascendenze bibliche e indica un uomo “imbranato e infelice”, uno a cui va tutto storto. Heine ne fa il capostipite della “schiatta dei poeti”. La sua permanenza è la dimostrazione che “il nome è ciò che rimane dell’ignominia”.
Il cacciatore Gracco di Kafka – personaggio più volte ricorrente in testi diversi del grande scrittore boemo – non è uno scomparso, né un diminuito, ma una non-persona che “solleva la questione di cosa sopravviva alla morte”. Qual è la vera natura dei resti di un corpo umano? Il cadavere è una non-persona. Ma con quali caratteristiche? Per i greci dell’età arcaica solo il cadavere è un corpo e non le molteplici membra, parti o aspetti di una persona viva. La distinzione rimane nella lingua inglese, in cui il cadavere è definito “corpse”. Per cercare di definire chi o cosa è un cadavere, Heller-Roazen chiama in causa il rapporto di somiglianza. Il morto è colui che assomiglia al vivo. Nell’antichità l’idea è espressa dall’“imago”, il ritratto cereo del defunto, letteralmente un inganno, ma nello stesso tempo una sua rappresentazione, una copia, una somiglianza. Nelle lingue germaniche le espressioni che indicano il corpo umano sono formate da termini che evocano la somiglianza: il termine alto-tedesco “Leiche” (cadavere) è affine all’inglese “like”. Aristotele precisa che un cadavere non può essere definito come un uomo, anche se ha la stessa forma della sua struttura. Cadavere e uomo sono omonimi, ma l’identità fra vivo e morto è “pura apparenza”. Se Tommaso d’Aquino afferma che il cadavere è distinto dal corpo vivente, il morto e il vivo, secondo Duns Scoto (fine XIII secolo) hanno in comune una forma di corporeità che deriva dai genitori. Ma il corpo morto è privo di anima. Secondo Blanchot, il cadavere deve essere sottratto alla vista perché “con questo mondo ha la relazione di un’immagine”, è il doppio.
Con la non-persona del cadavere c’è un’ulteriore questione. Quando fa apparizione? La scienza medica contemporanea ha scelto come criterio la morte cerebrale, ma nel passato la fine della vita è stata fissata secondo le regole più differenti. La legge rabbinica considera il cadavere come “un’entità in graduale transizione dall’umano al non umano”. Da qui deriva l’idea della sua impurità. Nelle società indonesiane studiate da Robert Hertz all’inizio del Novecento, per gli stessi motivi, il corpo viene lasciato decomporsi all’aperto. La morte può fare proliferare le non-persone. Se il rito funebre non è stato eseguito correttamente, i morti diventano gli spettri, i “revenants”, che si manifestano – soprattutto come epifanie acustiche nell’antichità – per portare un messaggio ai vivi. Henry James in L’angolo prediletto racconta la storia di Spencer Brydon che, tornato nel suo appartamento di New York, convive con uno spettro davvero unico, quello di se stesso. Il passato controfattuale – dove il fantasma è colui che Brydon avrebbe potuto essere se fosse vissuto lì – dà vita al corpo apparente. Ma Brydon non riconosce il suo volto, lo spettro gli appare mostruoso. Il problema è che se “ha uno spettro, ciò significa che lui stesso, oppure qualcosa in lui, dev’esser morto”. La situazione potrebbe essere allora rovesciata: Brydon è il non-uomo, mentre “lo straniero”, lo spettro, è “l’uomo reale per quanto irreparabilmente danneggiato”. È un capovolgimento con un precedente nelle Metamorfosi di Apuleio, dove l’uomo vivo e l’uomo morto, che condividono lo stesso nome di Telifrone, si scambiano le parti. I rapporti tra i vivi e i morti sono turbati anche dai censimenti. Quando si devono contare le persone, le non-persone si affollano attorno a loro, perché i vivi e i morti entrano in rapporti inattesi e spesso inquietanti. Non casualmente, i censimenti si associano a fatti tragici. I conteggi conducono all’incontro con non-persone di parecchie categorie, come racconta Gogol in Le anime morte, dove compaiono le tre categorie degli scomparsi, dei diminuiti (i servi della gleba) e dei deceduti. Una funzione simile ai censimenti è propria delle conte che, evidenziando il rapporto tra persone e non-persone, mettono in chiaro un aspetto decisivo e immanente alla vita stessa: la “minimale necessità” che vi sia “una persona che è meno di uno”.