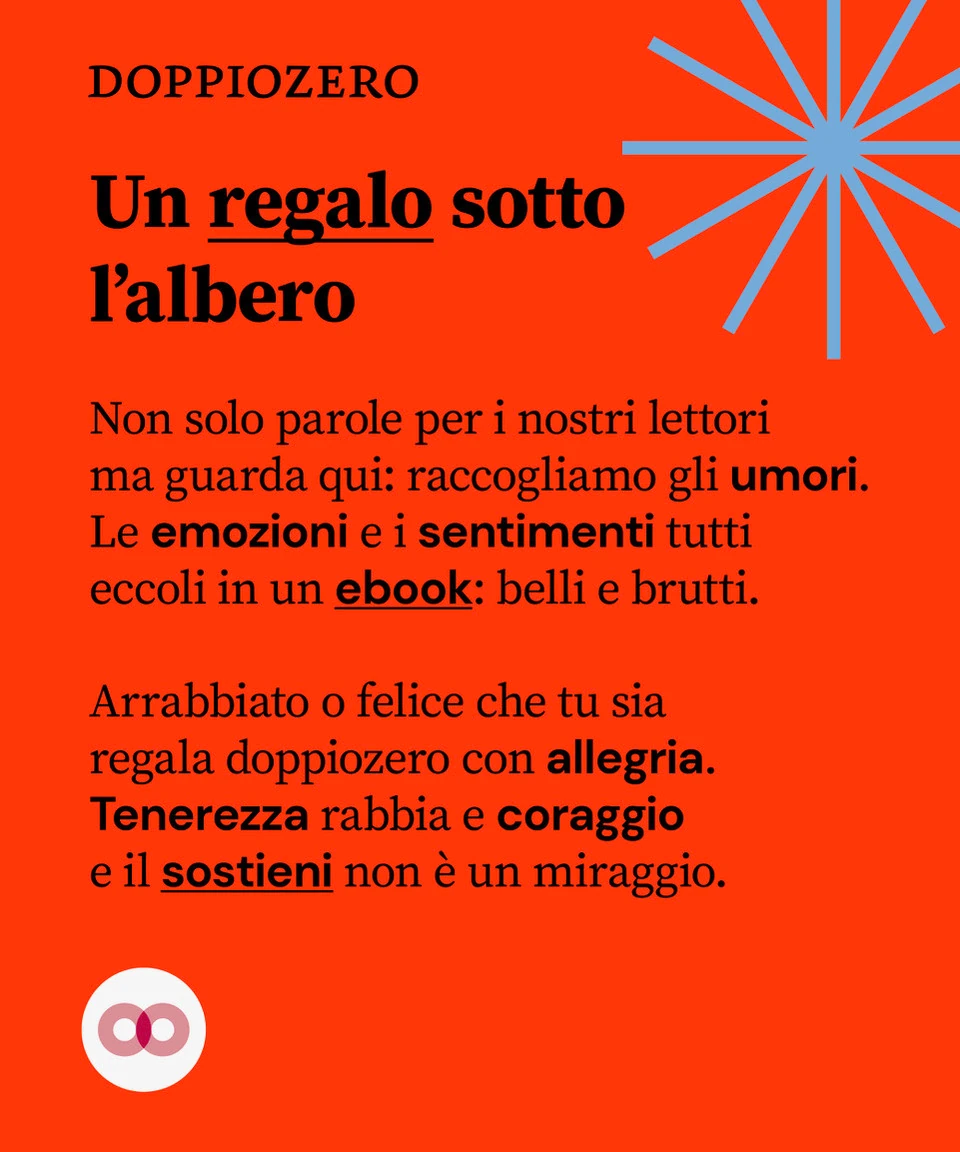Le immagini possibili / L'inimmaginabile della Shoah
Un’illusione serpeggia nel mondo delle immagini riprodotte tecnicamente: la possibilità di esprimere la realtà nella sua totalità in maniera puntuale e asettica. Ben lontane da questa completezza, le immagini si offrono allo sguardo evocando un mondo. La relazione di sguardi generata al cospetto delle immagini, moltiplicando i punti di vista, determina che tra il soggetto che guarda e l’oggetto della sua visione ci sia reciprocità, e le immagini, dal loro limite, rispondano al nostro sguardo, osservandoci a loro volta.
Nel suo ultimo libro, Il limite dello sguardo, edito da Raffaello Cortina Editore, Michele Guerra espone il tema della visibilità di ciò che rientra, per gravità assoluta, nei termini dell’Inimmaginabile: l’Orrore della Shoah. Come si può delineare un canone che faccia da controcanto all’esigenza narrativa del racconto, portando una serie di opere letterarie, fotografiche, e filmiche come elemento argomentativo? La tentazione potrebbe essere di adoperare l’immaginario della realtà concentrazionaria per teorizzare l’irrappresentabilità dell’Orrore. Ma, estendendo la questione alla rappresentatività delle immagini, Guerra ci dimostra come l’immaginazione sia alleata della conoscenza.

Sergej Loznitsa, Austerlitz.
Affrontare l’Inimmaginabile della Shoah vuol dire rapportarsi a immagini frammentate, precarie, clandestine, eppure resistenti, che ci giungono come testimonianza di un evento che lascia attoniti. Quelle immagini rivelano un grande potere evocativo proprio in virtù della loro incompletezza. Ci dicono di più, però, se ne accettiamo il limite, su cui converge anche il limite dello sguardo. Si tratta di cogliere in esse ciò che non è dato vedere. Là dove non è più sufficiente un’analisi formale delle immagini, si impone la capacità del nostro sguardo di connettersi a un controcampo immaginario, invisibile e irrappresentabile. Su questo vuoto si fonda una più attuale esperienza della visione.

Nell’immagine di copertina una figura seminascosta tra i prismi marmorei del Memoriale per gli Ebrei assassinati d’Europa, realizzato da Peter Eisenman a Berlino nel 2007, scatta un selfie. Anche nel minimalismo iconoclasta del Memoriale emerge la tendenza contemporanea alla proliferazione delle immagini, che ha l’Inimmaginabile come suo sostrato. Le immagini malgrado tutto, direbbe Didi-Huberman, perché è con esse che una realtà inimmaginabile prende forma. Resta a noi orientarci in un mondo costellato dall’ipertrofico meccanismo di produzione e riproduzione di immagini feticizzate e mercificate. In questo contesto, Guerra ci fa capire come le condizioni di visibilità della Shoah, il suo continuo parlare dentro un orizzonte della comunicazione sempre più vocato al visivo, abbiano messo a dura prova i media che ne hanno veicolato la storia, il racconto e la testimonianza (p. 117).
Il tema dell’Inimmaginabile diventa un lavoro di ricerca sull’immagine e la Shoah, che pone la riflessione sulle modalità espressive di ciò che immagine non può avere. È l’Inimmaginabile che conduce la visione su un crinale fragilissimo, dove convergono il limite delle immagini e degli sguardi ad esse rivolti. Sguardi che contemplano l’apparizione di una scomparsa dentro tutte le immagini, cioè il punto di arsura in cui l’immagine, bruciante, testimonia l’Inconcepibile.
Se all’iperproduzione iconografica contemporanea corrisponde un diffuso oblio per la Storia, d’altra parte l’immagine-testimonianza costringe a un’“acrobazia intellettuale”, secondo l’espressione di Didi-Huberman: l’immagine-lacuna implica la consapevolezza di quel limite. Le opere scelte da Guerra indicano la difficoltà di dare immagine a ciò che visibile non è più. Eppure da questo impedimento si produce un’esperienza visiva che in quel vuoto coglie la pressione fortissima di un fuoricampo nascosto. L’immagine non può essere evitata affinché qualcosa di inconcepibile si possa fissare nella memoria, come sostiene il regista Harun Farocki.

Quattro fotografie scattate da alcuni elementi del Sonderkommando all’interno di Auschwitz nel ’44 testimoniano l’Orrore: scatti precari determinati dalla situazione di pericolo a cui gli autori si erano esposti nel realizzarli e farli uscire rocambolescamente dal campo. Sono inquadrature veloci che dicono dell’Inimmaginabile. Alcune sono più ferme, altre sghembe, fuori fuoco, sovraesposte. Mostrano come perfino le cime ondeggianti delle betulle del campo riescano a far parte dell’Indicibile. Operando sul concetto dell’estrema vicinanza di una lontananza, caro a Walter Benjamin, Guerra ci dice che sono immagini che conservano il terrore della vicinanza, l’affermazione dell’umano, l’impossibilità di dire tutto, il potere […] di fotografare solo una piccola parte della tragedia e fotografarla in modo impreciso, sfuocato, con linee e volumi e corpi che sfuggono al controllo, alla misurazione. […] interrogano il nostro vedere a partire da ciò che lo eccede per troppa vicinanza o per troppa lontananza (p. 133).
Ciò che rimane dell’esperienza dell’Indicibile è ridotto al solo sguardo superstite delle vittime, su cui si concentrano gli autori che Guerra include nel suo libro. Così Eli Wiesel, nei suoi testi sull’esperienza del lager nazista, pone il confine della visione all’interno dei suoi occhi che hanno visto, privandoci del “cedimento alla ragionevolezza della narrazione”, cioè del controcampo cinematografico che aiuterebbe a rendere “sopportabile” l’Indicibile, dando un sembiante — umano? — a ciò che osserva. Ma i suoi occhi non rivelano l’oggetto del proprio sguardo. Sono occhi sbarrati nel buio di una notte senza pause che sono incapaci di riconoscersi negli occhi di quel se stesso-fantasma che lo osserva dallo specchio del sanatorio, dopo essere stato liberato. Come una Gorgone pietrificante, la testimonianza è “l’impossibilità di vedere”. Wiesel la sutura sul suo corpo martoriato, definendo la lacuna dello sguardo, consentendo, se l’etica lo permette, di trarre dalla Shoah una decisiva lezione di teoria dello sguardo. Per W.J.T. Mitchell, se è vera quest’impossibilità di mostrare, l’attenzione si sposta allora sul “mostrare il vedere”. Nulla da dire, solo da mostrare, come sosteneva Benjamin.

Così la fotografia dei fratelli Jacob dall’Album Auschwitz, secondo Guerra, è la conferma dell’immagine-lacuna che non offre alcun controcampo allo sguardo di Zelig Jacob perché quel controcampo è il suo assassino. Quel controcampo siamo ora noi che siamo osservati dai suoi occhi che campeggiano sul logo del Memoriale Auschwitz-Birkenau. Gli stessi occhi sbarrati sul buio sono quelli di Josepha che viene soccorsa dagli operatori di Open Arms, in uno dei silenti genocidi del Mediterraneo, oppure quelli di Gutete Emerita che l’artista cileno Alfredo Jaar dedica al genocidio ruandese del 1994.
All’opposto dell’impresa cinematografica che, nell’illusione di realizzare la completezza del racconto, spettacolarizza le immagini dell’Orrore, in Notte e nebbia, film del 1955 di Alain Resnais, l’alternanza dialettica di immagini d’epoca in bianco e nero e a colori di ciò che resta dei lager, esclude ogni pretesa di rifacimento mimetico, creando cortocircuiti temporali tra Storia e realtà attuale.
Tra le opere più recenti, nel testo sono presenti Stelen di Marc Adelman, Yolocaust di Shahak Shapira e Austerlitz di Sergei Loznitsa nelle quali si evidenzia come il tema della Shoah ponga delle resistenze anche nell’epoca dei social network e del turismo voyeuristico di massa.
In Stelen, Adelman raccoglie circa 150 fotografie da siti di incontri omosessuali scattate nel Memoriale di Eisenman a Berlino. Cancellati i testi, i ritratti e le pose vagamente più ammiccanti, ponendo il problema sull’uso degli spazi della Memoria e della loro risemantizzazione, confermano che lo spazio queer rientra nell’ambito della cultura visuale. Anche se l’operazione sembrerebbe inappropriata, è lo stesso Eisenman a chiarire che il Memoriale da lui progettato deve essere vissuto dai visitatori. Il Memoriale è una sfida per l’imprevedibilità delle reazioni di coloro che lo attraversano. L’etica dello sguardo è affidata loro senza imporre alcun intento moralistico: la memoria di quel passato imponente diventa una memoria vivente nell’esperienza di ognuno.

Mark Adelman, Stelen, 2009-2011.
In Yolocaust, Shapira contrappone la pratica dei selfie ad alcune fotografie di repertorio relative all’Orrore, in un’operazione che mira ad una reazione prevedibile. L’intervento, realizzato sul web nel 2017, avendo ottenuto il suo scopo —- le scuse ufficiali degli autori dei selfie — non è più visibile. Erano dodici immagini pubblicate in rete da alcuni visitatori del Memoriale di Eisenman: autoritratti disinvolti, sorrisi e pose ginniche tra le stele, accompagnati da commenti sarcastici. L’autore fa in modo che ad uno scivolamento di mouse, appaiano, dietro i fotografati, strazianti immagini d’epoca che suscitano inesorabilmente indignazione.
In Austerlitz, Loznitsa posiziona le videocamere nei campi di concentramento fissando, come in un’operazione venatoria, le espressioni goffe, imbarazzate o assenti dei visitatori contemporanei: soggetti smarriti che documentano la perdita della consapevolezza dello sguardo e della produzione tecnica di una dimenticanza.
Quei luoghi carichi di passato fanno emergere la funzione presente dello sguardo rivolto alla Memoria. Nell’ambito della figurazione si percepisce la pressione esterna di quell’Invisibile di cui mai si avrà contezza assoluta. Da quella tensione si delinea l’increspatura del racconto di un’esperienza lontana e ancora viva tratteggiata appena sul limite di un controcampo assente per necessità. Oltre i limiti, sguardo e immagine rifondano la visione.
In linea con le recenti teorie visuali, Guerra costruisce un percorso che radicalizza la questione del guardare. Interrogarsi su ciò che è possibile vedere al limite delle immagini vuol dire assumere la conoscenza proveniente dallo scarto esistente tra un reale sfuggente e un’opera che ne restituisca un sembiante possibile.