16 febbraio 1922 - 16 febbraio 2022 / Meneghello, apprendista italiano
Luigi Meneghello racconta di aver cominciato a scrivere nel primo dopoguerra con “brevi attacchi che poi restavano sospesi in aria”, a cui seguirono negli anni Cinquanta tentativi più strutturati anche in lingua inglese o in dialetto vicentino. Questa scrittura a tutti nascosta e portata avanti “con l'animo contratto”, faticosa forse perché troppo autobiografica, si sblocca nell'estate del 1960 e darà il suo folgorante esordio di due anni dopo con Libera nos a malo. Seguirà nell'inverno del 1962, sull'Altipiano di Asiago, la scrittura ugualmente sciolta e liberatoria di I piccoli maestri, destinato a rinnovare profondamente “in chiave anti-retorica e anti-eroica” la letteratura della Resistenza. Restano questi i suoi libri più noti, anche se non andrebbe dimenticata la notevole produzione saggistica (tra gli altri Jura 1987, La materia di Reading 1997) e gli ultimi libri come Il dispatrio che ne hanno rinverdito la vena memoriale. Ma Meneghello è stato forse lo scrittore che con più passione ha riflettuto per via narrativa sull'Italia; su questo vorremmo soffermarci attraverso una sorta di trilogia costituita dai già citati Piccoli maestri, riveduti e corretti nel 1976, Fiori italiani dello stesso anno e Bau-sète! (1988).
Il secondo è, e non a caso quando si voglia parlare di nazione, tutto incentrato sulla scuola, a partire dai lontani discorsi degli insegnanti al liceo durante il periodo fascista (“pura retorica”), a cui si collega la riflessione di un brillante studioso italiano a Londra che anch'esso, anni dopo, scivola nel finale sul “tono oratorio” in merito alla poesia di Petrarca. Ecco allora la bruciante necessità di una ri-formazione: “disporsi a distruggere ciò che si era creduto fosse l'impianto naturale della propria mente”, ed era invece il prodotto, tutto astrazioni e idolatria per la parola sonora, di un'educazione secolare solo accentuata dal fascismo. Per esempio con l'esercizio narcisistico dei migliori studenti ai Littoriali: “non aveva nessuna idea su nessuna politica da farsi o da non farsi in nessun posto: aveva solo l'idea di cercare parole che gli sembravano insolite e di proferirle con particolare icasticità”.
Qui entra in scena un educatore del tutto diverso, Antonio Giuriolo, ben presente nei tre testi, per il quale gli aggettivi “libero”, “vero” e “reale” risultavano indistinguibili. Lettore dei classici del liberalismo e del Risorgimento, di poeti e romanzieri francesi dell'Ottocento, colpisce Meneghello e gli altri giovani per il “rapporto vivo” con ciò che studiava fuori da ogni canone del tempo, pensava ed insegnava senza la tessera fascista in tasca. Questo in fondo il messaggio eternamente valido: nessuna burocrazia del programma da svolgere, nessun atteggiamento pedagogico e persuasivo esplicito, men che meno un tono didascalico o oracolare. Al contrario “il punto di partenza era spesso un nucleo di commozione della fantasia: dei versi, un personaggio in un libro, un dettaglio illuminante in un racconto, una concezione espressa in un detto esaltante o conturbante”, letti con profondità e contrapposti magari a ciò che era detestato soprattutto per ragioni di stile e di morale. Per cui anche la screditatissima parola patria, appunto una parola, ora sanguinosa ora grottescamente associata a una stella e a un camino nella canzone Monte Grappa, si redime in “ambiente culturale, cioè conoscere e capire le cose.”
Di qui in avanti Meneghello ed i suoi amici diventano gli “apprendisti italiani” che resteranno in fondo per tutta la vita. Con i loro studi personali (“Non ci passava nemmeno per la testa, si capisce, di studiare roba di scuola, esami”) e l'idea fissa di formarsi per diventare classe dirigente trasformatrice: “Studiavamo letteralmente per l'Italia”. In mezzo l'appuntamento esistenziale decisivo dove li attende come punto di riferimento sempre Giuriolo.
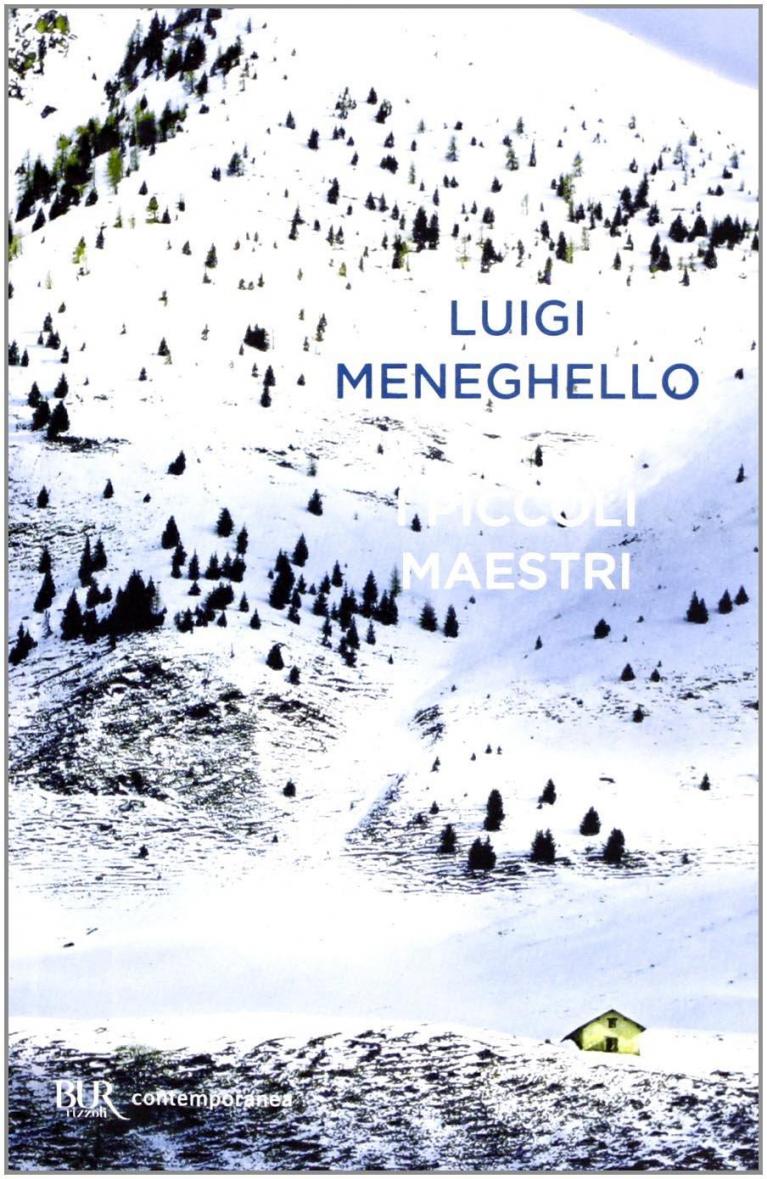
E infatti in nessun racconto partigiano si parla tanto di Italia e di italiani come nei Piccoli maestri, a partire dal loro incerto statuto, verificato nel viaggio di ritorno dal centro verso il Veneto dopo l'8 settembre: “Ripetevo a Lelio: – Sono italiani questi?. Lelio diceva: E noi? –.” Un problema di definizione che dall'ironia passa all'analisi soprattutto nelle pagine riguardanti la struttura sociale borghese, da cui i popolani sono esclusi al di là di “carceri, la servitù domestica, il bordello, la caserma, il seminario”. E ugualmente “assunti in servizio” lo sono nella letteratura, che in più punti di I piccoli maestri s'identifica in pieno con astrazioni idealistiche, vacue liriche dannunziane o ermetiche, precoci carriere accademiche.
La volontà popolare sembra essersi però finalmente manifestata proprio negli aiuti dei civili ai soldatini sbandati e nelle prime assemblee volte alla difesa dei propri paesi. “Adesso tocca a noi”, pensa il narratore pronto a diventare partigiano per non perdere l'eccezionale occasione di una trasformazione collettiva: “Naturalmente ci avrebbero presto sterminati, almeno la prima infornata, e poi anche la seconda e la terza. Ma almeno l'Italia avrebbe provato il gusto di ciò che deve voler dire rinnovarsi a fondo, e le nostre lapidi sarebbero oggi onorate da una nazione veramente migliore.” Tuttavia questi intellettualini combattenti sembrano a loro volta insidiati da una tentazione di Tebaide sugli alti monti, “il posto migliore per isolarci dall'Italia, dal mondo”, rifiutando il “Fare, fare: verbo osceno.” Inoltre fin dalle prime pagine, quando il protagonista in compagnia di un'amica torna sull'Altipiano dove aveva combattuto, non fa che ritenere di non essere stato all'altezza: “Siamo un po' venuti a mancare a quel disgraziato del popolo italiano. Almeno io gli sono certamente venuto a mancare; si vede che non siamo fatti l'uno per l'altro.” Tale constatazione troverà la sua verifica nel terzo romanzo, che insieme al racconto degli ultimi fuochi della guerra civile e delle imprese commerciali dei Meneghello nel dinamico dopoguerra paesano, s'incentra anche sul tentativo politico operato dal Partito d'Azione.
Antonio Giuriolo, “futuro punto di forza del radicalismo laico […] di quel partito moderno, colto, spregiudicato a cui volevamo affidare il rinnovamento dell'Italia”, era invece caduto il 12 dicembre 1944. L'auspicata guida non c'è più, chiusa nell'eccezionalità della gioventù e del momento storico e, a contraddire quanto scritto poco prima, sembrerebbe quasi una fatale necessità: “Antonio vivo non avrebbe potuto continuare a essere a lungo la fonte d'ispirazione che era stato in passato per le nostre scelte ideologiche e politiche. Quel tipo di suggestione non ha luogo nella vita ordinaria.” Il dopoguerra frettoloso di dimenticare, come rappresentato per esempio in alcune pagine di Bassani, e di riprendere a vivere e ricostruire, appare quanto mai inadatto agli sforzi volontaristici dei piccoli maestri. Resta insoluto il problema di comunicare con le masse. Solo durante un'arringa da balconcino, in un imprecisato paesello di montagna, il narratore di fronte a una decina di persone, scaldato dal tema – il passato e il futuro della patria –, sembra fondersi davvero con gli uditori.
Lui pensa che sia stato l'uso del vicentino, ma proprio l'umile lingua della verità (o “allocuzione colta in dialetto”) risulta ciò che è piaciuto meno al suo pubblico. Da una parte il proposito del PdA di avviare “quasi a calci il paese sulla strada di un rinnovamento radicale” sfuma secondo Meneghello per i contrasti interni, l'elaborazione parziale di pensieri e programma; di nuovo insomma in forme tragicomiche riemerge “in tutta la sua pittoresca complessità la pochezza della nostra nuova classe dirigente”, cioè di loro stessi. L'impazienza e le aspettative in primis verso di sé furono forse eccessive, certo gli esiti delle prime libere votazioni politiche degli italiani diedero un risultato inequivocabile e impietoso.
L'amico Franco si rassegna all'opposizione, presumibilmente eterna, secondo i dettami della riconquistata democrazia; Meneghello scelse l'esilio britannico, sperando di attingere alle fonti del liberalismo e del pragmatismo: “Partivo col vago intento di imparare un po' di civiltà moderna e poi tornare e farne parte ai miei amici e ad altri italiani” (così in Il dispatrio). Da allora non ha cessato di guardare in distanza all'Italia, di riflettere e confrontare senza risparmiare l'ironia anche sulla nuova patria: “Contrapponevo la serietà inglese, le ristrettezze in tempo di guerra, le privazioni condivise e accettate come base della vita comune, alla cultura del privilegio che dominava in Italia.” Ma insomma, dentro l'atteggiamento umoristico e smagato, resta incancellabile, nel narratore e ancora nei lettori che guardano all'oggi, la sensazione amara di un accesso alla modernità sociale e politica ancora una volta ritardato e imperfetto.







