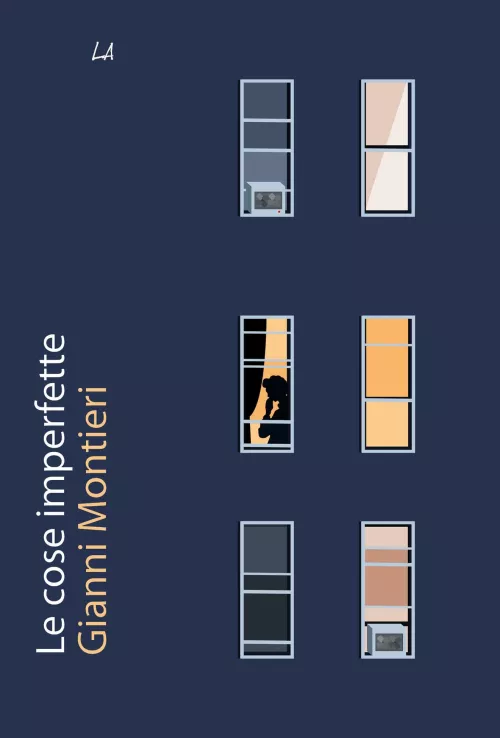Salabé, Ostuni, Montieri / Tre poeti
Leggendo Il bel niente (La nave di Teseo, 2019), il felice esordio poetico di Piero Salabé, sono andato a riprendere un libro del filosofo Massimo Baldini sulla mistica medievale, alla pagina dove dice che «al mistico il linguaggio spesso si impunta, talora egli non fa altro che ripetere a singhiozzi un alfabeto, la parola è sempre una barriera che gli riesce difficile superare».
E in effetti il filo conduttore di questo libro è proprio il continuo riproporre e variare una situazione di scacco del linguaggio di fronte a un “nocciolo” o “essenza” delle cose; in primo luogo l’esperienza dell’amore, che del libro è uno dei temi principali.
Certo, per i mistici l’oggetto ineffabile è Dio, mentre per l’autore è l’esperienza amorosa o una supposta autenticità delle cose, ma forse cambia poco. Di fronte a questo “quid” a volte la parola – che pure si vorrebbe dire – si inceppa e si fa balbettìo:
«che e non / che non // m’ami / mi preoccupa // che l’altro / è quel che / si sa // mentre l’altro / ora ancora // io e tu / un e una // fine fino // alla fine // chiusi / in quell’unico / bacio.» (p. 79)
Abbiamo scelto un caso estremo, ma esemplare di una situazione che Claudio Magris, che della raccolta firma il risvolto, così sintetizza: «una lirica che si inserisce nella grande tradizione della poesia metaforica e della poesia in guerra con le parole»; una «poesia che come un fiume scorre verso il silenzio».
Ma lo scacco non genera mai il silenzio, perché le parole sono l’unica cosa che abbiamo per dare forma alle cose e a noi stessi, a volte anche per difenderci («mi difendo scrivendo» si dice a un certo punto).
Salabé gioca così la sua scommessa poetica; forse, da germanista qual è, memore dell’aforisma per cui «Nessuna cosa sia dove la parola manca» (Stefan George) e quindi della riflessione di Heidegger secondo cui solo in virtù della parola gli “enti” possono aprirsi e rivelarsi. E perciò, con contraddittoria consapevolezza, “parla”, intessendo i suoi scolpiti e a volte folgoranti e struggenti referti dell’esperienza d’amore in versi brevi (per lo più non oltre la misura del settenario), in dialogo con un “tu” di volta in volta sfuggente, crudele, disponibile, presente o assente.
Questo “tu” si copre letteralmente di baci oppure si avvolge di parole, con una singolare possibilità di sovrapposizione metaforica o letterale tra il campo semantico della “lingua” come discorso e quello dell’eros o della fisicità:
«ti piace quella lingua / baciata o parlata / finché non la capisci» (p.40)
«e parlo / contro il silenzio / delle tue labbra» (p. 17)
«e mi difendo / con parole straniere / […] dalla pelle troppo sottile / del primo suono» (p.18)
«mi baci per chiudermi / la bocca // mi ammutisci / per guadagnare il tempo / della fuga // allunghi il bacio / per sciogliere / il nodo nella / lingua //» (p. 66);
al punto che amore e poesia d’amore tendono a identificarsi:
«m’ero proposto / un amore // o una poesia d’amore / fa lo stesso» (p. 28)
Ma l’amore non è l’unica dimensione del “canzoniere” di Salabé.
Vi è un’altra situazione ricorrente e molto rivelativa. L’io si pone di fronte al paesaggio, che quasi sempre è immobile, illuminato (o meglio: raggelato) da una luce fredda, difficile da sostenere, e soprattutto privo di parole:
«punge la luce / del lago precluso / dietro gli alberi / scuri // cielo in terra / caduto / proibita la delizia / verde festante / a noi perduto //»; (p. 113).
«il silenzio puro / è pieno / di suoni luci colori» (p 125)
«tutte le cose sono ferme / lucenti di tempo proprio» (p. 20)
«c’è il maggio / più freddo e spesso / scuro / ma la luce è quella // (p. 186)
«tutto è chiaro / in questo mattino // niente resta / nascosto nella luce / invernale // tersi e spogli e alti / / si stagliano gli alberi / e senza domande // (p. 184)
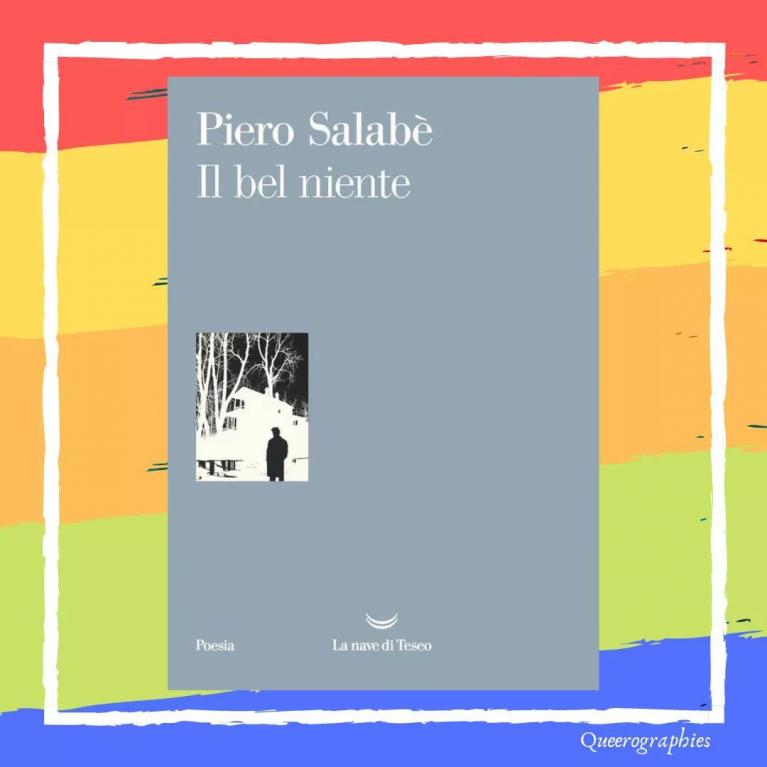
Questi realia sono sempre immersi un silenzio “disumano” (nel senso di non abitato dal linguaggio). Questi istanti sottratti al flusso del tempo e del linguaggio potrebbero assomigliare ai moments of being di Virginia Woolf, o al timeless moment di Eliot (Little Gidding, I). Eppure essi non rivelano, una volta di più, che la necessità di “essere detti” per esistere, perché senza la parola, non vi è esistenza («manca / la sentenza / e viene meno / la foresta //»; p. 187, che potrebbe essere un’ironica parafrasi heideggeriana: «Là dove non ha luogo linguaggio di sorta, come nell'essere della pietra, della pianta e dell'animale, non ha neppure luogo alcun aprimento dell'ente»). Senza la parola, e finché non diventi in qualche modo “nostro” («il suo unico mondo»), il reale potrebbe assomigliare a un artificio, a un fondale di teatro:
lo vedi
quell’albero
illuminato
pare disegnato
cartone steso
dal cielo
fra l’era ancora accesa
e il palazzo serale
sei stata tu
a mandarmi
quel verde saluto
luminoso?
Vedi quel povero
burattino
di legno vivo
non può camminare
dall’alto viene
e lì scompare
solo i suoi rami
può alzare
solo arrendersi
e ancora abbracciare
il vento
vedi come splende
nel saluto
a noi rivolto
suo unico mondo
perché quell’albero triste
non esiste
noi senza sapere
l’abbiamo fatto fiorire
e senza sapere
molto prima del buio stellato
l’abbiamo lasciato
scomparire
Probabilmente questi momenti sono tra i migliori del libro di Salabé.
*
Con Il libro di G. (Il Saggiatore, 2019) di Vincenzo Ostuni siamo, in un certo senso, agli antipodi. Tanto i versi di Salabé sono brevi e concentrati, tanto quelli di Ostuni si dilatano in orizzontale – anche tipograficamente – e sono in un certo senso “inesauribili” e “interminabili”. Se quello di Salabé è un esordio, il libro di Ostuni è solo il più recente passo di un lungo percorso.
L’opera di Ostuni è senza dubbio uno dei più interessanti esperimenti di poesia italiana di questi anni. Da molto tempo Ostuni pubbica in un sito (www.faldone.it) le sue poesie inserendole in contenitori modulari e in costante aggiornamento, numerati progressivamente, appuno i “faldoni”, giunti, ad oggi, al numero di serie 99.
Parti di questi “faldoni” sono state riorganizzate e pubblicate a stampa (Oèdipus 2004, Ponte Sisto 2012, Aragno 2014, Tic 2019). Il testo del Saggiatore che abbiamo davanti ospita estratti dei faldoni settantasette, novantasette e novantanove, alcuni già pubbicati nell’edizione di Ponte Sisto.
Sulla poesia di Ostuni la bibliografia critica è ormai ampia e approfondita ed è disponibile sul sito prima citato. Hanno scritto di lui, tra gli altri Andrea Cortellessa, Gilda Policastro, Paolo Giovannetti, Luigi Severi, che ha dedicato ai Faldoni uno ottimo studio critico sistematico pubblicato su “Linguistica e letteratura”, e Andrea Inglese, il cui denso contributo è la postfazione all’edizione di Ponte Sisto 2012.
Dell’opera di Ostuni sono state messe in rilievo le affinità con l’archetipo “canzoniere” (da Petrarca in avanti, l’opera-vita) e al tempo stesso la dimensione totalmente antipetrarchesca del suo linguaggio (Cortellessa), che è invece aperto come un grandangolo ai lessici della filosofia, della scienza, della psicologia, dell’attualità, a bizzarre “neoconiazioni” (Giovannetti) e ai registri alto e basso, al comico e al quotidiano.

I critici si sono interrogati sulla natura dell’”io” che parla in questi versi, sempre posti tra parentesi e virgolette, in una sorta di continuo dialogo con altri interlocutori, fatto di a parte teatrali, commenti di una recita che sarebbe la vita. È un “io” che, come quello di Montaigne, sembra essere l’unico soggetto-oggetto del discorso, ma che si rivela invece molto più complesso: «Si dice io per essere esattamente io, anche se poi è io quel tu, quel lui, quel lei, oppure non lo è nessuno, io, perché siamo tutti nel Faldone, ed è impossibile distinguerci come individui» (Policastro).
Sulla natura “sociale” di questo “io” ha scritto osservazioni acute Inglese, che parla di soggetto “spettrale”, coscienza di una classe culturalmente medio-alta dal punto di vista dei saperi – non del potere effettivo – ma al tempo stesso sommersa dal flusso dei messaggi, sempre sul discrimine tra la loro accettazione incondizionata (la resa a quello che Calvino chiamava “il mare dell’oggettività”) e il loro rigetto.
Ma al tempo stesso, nota Inglese, la scommessa sta nel reinserire nel “flusso” il volto individuale, nel ripristinare porzioni di significato e di autenticità.
Ed è proprio quello che avviene in questo Libro di G.
Qui Ostuni ha scelto una selezione tematica di testi, costruendo una sorta di diario poetico che segue passo dopo passo l’esistenza di un figlio (“G.”), dall’ecografia all’adolescenza problematica e vitale, attraverso le prime parole, i disturbi dell’infanzia, le prime conquiste, la prima scoperte - anche quella della morte: «(«”Io quando muoio?”, hai chiesto oggi, per la prima volta, a 3 anni 1 mese 11 giorni 21 ore circa.» p. 47) –, i momenti di vita che un genitore (“V.”) trascorre accanto a un figlio e le emozioni che entrambi ne traggono.
A questo filo conduttore principale si intrecciano momenti collaterali, per esempio dialoghi – non frequenti – con un tu materno; un inserto struggente sulla scomparsa del padre di V.
Il figlio, dunque, come alterità, continuità e specchio; la speranza e la disperazione di esseri umani (di essere umani). Un tema “antico” ma che Ostuni è capace di riprendere con coraggio e con risultati spesso straordinari. Come questo:
(«A scuola ti dicono ogni giorno che sei pazzo – come a me per due decenni almeno / torme unanimi di bambini e adolescenti: / prendono / la mia allegria, o miseria, per la tua, la tua per la loro: per la nostra – di tutti, voglio dire. Pure io / mi inchino senza saperle discutere / al trascorrersi l’una nell’altra, e noi nel loro letto, di equivalenze simili; ribatto senza convincerti o convincermi, / senza lenire il pianto né/ la certezza della propria disperazione. / È appena questo che la mia “pazzia” ci può concedere, ora che da bordo campo osservo il tuo blando / e penultimo allenamento: / i dieci centimetri di troppo, lo spazio lasciato vuoto attorno al tuo leggero sorriso senza meta / li ho scavati io stesso / nei decenni, come un vallo finale nella luce»).
*
Non è la sfida programmatica con il linguaggio, né la sperimentazione la cifra caratterizzante della terza raccolta di Gianni Montieri, Le cose imperfette (LiberAria Editrice, 2019), ma si tratta tuttavia di ottima poesia, che un lettore, anche scaltrito, terrebbe volentieri vicino, e a cui può ritornare come a un oggetto familiare e rassicurante.
Come l’autore scrive in una nota finale al volumetto, «Le cose imperfette è un libro sulle persone e sulle loro storie: note o sconosciute, amici o donne e uomini mai incontrati, sono tutti qui (…) tutti quanti fanno memoria». Una prima sezione del libro prende spunto – almeno in prevalenza – dalla lontananza di una figura cara femminile (la moglie Anna); una sezione centrale si apre a molteplici e diverse “occasioni”: memoriali o dell’istantaneo presente, incontri, paesaggi urbani, scorci domestici, libri e scrittori; una più breve sezione conclusiva è infine dedicata alla città che da ultima, dopo un soggiorno milanese, ospita l’autore, cioè Venezia, colta nei giorni di una recente acqua alta (la “marea” del titolo). Istantanee e occasioni in apparenza molto private, ma capaci di parlare al lettore, cioè a tutti. Credo che ciò dipenda dalla forte vocazione comunicativa e dialogica che anima la scrittura di Montieri il quale – nella nota già ricordata – spiega: «si parte sempre dall’io, da noi stessi, ma nel momento in cui appoggiamo la penna sul foglio (…) siamo già coniugati al plurale, non saremmo mai soli neppure volendolo, c’è sempre un altro».
Ed in effetti si resta colpiti dal numero di occorrenze di alcuni pronomi-aggettivi che la grammatica classifica come indefiniti, ma che in realtà alludono sempre ad una presenza umana, individuale o collettiva, ben presente alla mente di chi scrive e che costituisce l’avvio della scrittura: “qualcuno” o le sue varianti “nessuno”, “ognuno”, “tutti quanti” (pp. 16, 17, 21, 35, 49, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78).
Può trattarsi di “qualcuno” che interroga, che suggerisce, che twitta una notizia, che passa sul pianerottolo e provoca un cortocircuito memoriale il cui sfondo è qualcosa che Montieri definisce “stupore” e forse non è altro che la capacità di accogliere “democraticamente”, nella mente e sulla pagina, esistenze tanto diverse:
«Qualcuno è passato sul pianerottolo. / Rientrava. Ho sentito i passi prima / del rumore della chiave che gira / nella toppa, io ho steso i panni / mentre David Bowie cantava: / “Ground control to Major Tom”/ abbiamo visto il manoscritto / del testo a Bologna, al Mambo./ Sempre mi stupiscono cose come / la gente che entra ed esce da casa / o rockstar che hanno scritto / i loro capolavori su un quadernetto».
Avviata quasi sempre da una sollecitazione al presente (come in certo Montale e in Sereni), questa poesia è poi spesso motivo di riflessione sulla memoria e sullo scorrere del tempo. Tanto da far sospettare che l’aggettivo “imperfette” del titolo non rimandi solo al primo significato letterale (anche se certamente tra le cose letteralmente “imperfette” del nostro mondo ci sono le vittime del Mediterraneo che per essere almeno ricordate hanno scritto nome e telefono sulle braccia; p. 21), ma alluda anche al tempo verbale che indica un passato vicino a noi, che ci sfiora, fa da sfondo, non è ancora compiuto e che magari, come capita, si trasforma repentinamente in un futuro:
«Qualcuno oggi è andato allo stadio / per la prima volta, alle mie spalle / dei ragazzi studiano, spero Lettere / o Storia. Il futuro è ovunque. // Ieri al binario 3 della stazione di Padova / ho contato otto ragazzini sorridenti / ho scattato loro una foto / nel frattempo quei ragazzi / erano già altrove, al passato / restavamo io e l’immagine / perfino il treno ripartiva. // È tardi, alle mie spalle non c’è / più nessuno, la partita sarà finita.»
Montieri dice di non avere nessuna risposta sul futuro, ma pone almeno la domanda, e non è poco.
Piero Salabé, Il bel niente, La nave di Teseo, 2019
Vincenzo Ostuni, Il libro di G., Il Saggiatore, 2019
Gianni Montieri, Le cose imperfette, LiberAria Editrice, 2019