Speciale
La grande scissione

“Come ha potuto ancorarsi così profondamente nella nostra coscienza collettiva la frattura tra nord e sud del continente?” – si chiede la scrittrice, produttrice e documentarista Jihan El-Tahri nell’editoriale pubblicato sul numero di marzo di ART AFRICA, dal titolo “Looking Further North”.
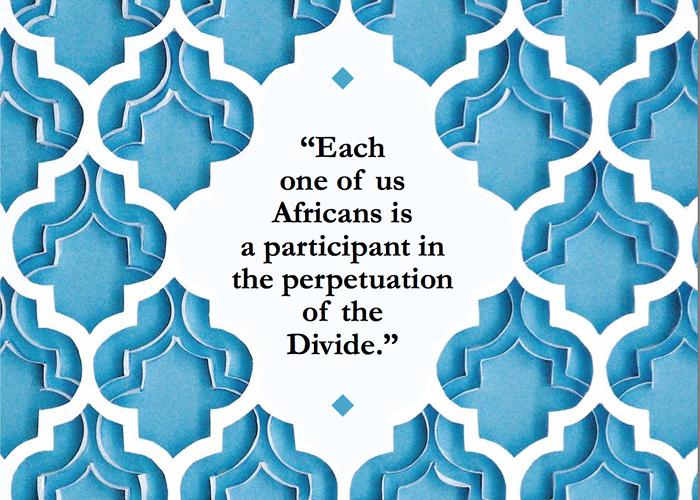 Mishkaah Amien, Shift (2015). Carta, 21 x 29,7 cm. Per gentile concessione dell’artista.
Mishkaah Amien, Shift (2015). Carta, 21 x 29,7 cm. Per gentile concessione dell’artista.
Ricordo di essere rimasta fortemente colpita dal discorso “Sono un africano”, pronunciato nel 1996 da Thabo Mbeki nel presentare la nuova Costituzione sudafricana. Un discorso potente, che rappresentava pienamente un momento storico che un intero continente attendeva da decenni. Le sue parole mi hanno segnato profondamente. Mbeki ha colto la diversità del continente e, in qualche modo, nelle sue parole ho trovato una legittimazione dell’ostinata rivendicazione della mia “africanità”. Mi sono chiesta spesso perché, ogni qual volta mi presento come un’africana d’Egitto, i miei compagni africani più scuri mi guardano come fossi un impostore. Come ha potuto ancorarsi così profondamente nella nostra coscienza collettiva la frattura tra nord e sud del continente?
“Divide et impera” è stato un semplice ma efficace pilastro della nostra eredità coloniale. Le divisioni presenti attualmente nel continente africano sono molteplici, ma nessuna è tanto profonda quanto il divario tra “nord arabo” e “sud bantu”, ovvero tra “nord bianco” e “sud nero”. Non capisco come i miei conterranei nubiani, dalla pelle color carbone, possano essere considerati “bianchi”! Il criterio con cui sono state raggruppate o suddivise le popolazioni non è sempre stato il colore della pelle. Nell’antichità i confini naturali erano costituiti da cultura, tradizione e lingua. Il Sahara non è mai stato una barriera. Ha rappresentato, storicamente, un luogo di rifugio, ospitalità, commercio e, soprattutto, scambio culturale. Quando sono stati tracciati i confini, questo enorme deserto è diventato un grande elemento divisorio. Il Sahara è stato stigmatizzato e identificato come un territorio arido e ostile. E oggi è visto come una zona desolata che separa gli “arabi” dai “veri africani”.
Gli studiosi occidentali hanno coniato il termine “Africa subsahariana” dopo la seconda guerra mondiale e già nel 1966 erano stati investiti all’incirca 300 milioni di dollari in una nuova disciplina accademica denominata “Area Studies”. Gli effetti della decolonizzazione e l’inasprirsi della Guerra Fredda hanno spinto gli Stati Uniti a dividere il mondo in blocchi, oggetto di specifici studi territoriali. Corporazioni come la Ford Foundation hanno finanziato una serie di studi per aiutare l’America a rispondere efficacemente a quelle che erano percepite come minacce esterne. Ironia della sorte, ad oggi, i confini della cosiddetta “Africa subsahariana” non appaiono su nessuna mappa, ma la grande scissione adottata dagli accademici è diventata in qualche modo realtà. Da africani, sappiamo che questo approccio semplicistico è una costruzione artificiale, simile alla costruzione coloniale in base alla quale sono stati eretti confini nazionali che spesso separavano una stessa tribù. Se vogliamo continuare a perpetuare tali divisioni, non possiamo limitarci a dare la colpa alle potenze coloniali che le hanno imposte. Ogni africano contribuisce in prima persona a perpetuare le divisioni. Il nord guarda al resto del continente attraverso la lente del razzismo e i cliché dell’indolenza, della violenza e della povertà. Il sud risponde con disprezzo, considerando gli “arabi” come alleati degli invasori stranieri, trafficanti di schiavi che hanno prosperato vendendo i loro fratelli. Si tratta di generalizzazioni, ma gli atteggiamenti che derivano da questi stereotipi purtroppo continuano a rafforzarsi.
In qualità di artista, mi confronto con questa grande scissione nord/sud, arabi/africani, e mi chiedo spesso se le strutture di finanziamento in ambito artistico non ci abbiano spinto a circoscrivere e ridefinire le nostre stesse identità. A ogni nuovo progetto, mi viene chiesto di completare moduli su cui indicare se sono araba, africana, francofona o anglofona, musulmana o cristiana. Per ottenere i fondi di cui abbiamo estremamente bisogno, dobbiamo per forza rinunciare alla complessità, alla diversità, alle molteplici stratificazioni insite nell’essere africani? Io sono anglofona, francofona e arabofona. Sono musulmana e sono totalmente laica. Sono araba e, senza ombra di dubbio, sono africana. Chi l’ha detto che devo scegliere? Chi l’ha detto che non posso essere entrambe le cose, visto che lo sono?
Il mio Paese, l’Egitto, è sempre stato al centro del dibattito sull’africanità. Nel libro Nations Nègres et Cultures, il fisico, antropologo e storico senegalese Cheikh Anta Diop analizza le origini nere della civiltà egiziana. E afferma che l’esclusione dell’Egitto dalla storia africana è stata parte integrante e cosciente dell’azione che ha posto le basi per le prime imprese coloniali. L’idea su cui si fonda il colonialismo, ovvero la “civilizzazione dei barbari”, non avrebbe attecchito se l’Egitto, con la sua documentata civiltà secolare, fosse rimasto legato alla storia africana. Per fortuna, i padri fondatori dell’indipendenza africana hanno compreso il potenziale distruttivo di tali divisioni. Sapevano che, se non si considera l’Africa come un tutt’uno, la scissione nord/sud sarebbe rimasta il tallone d’Achille del continente. Nonostante le difficoltà, essi hanno scelto di rimanere uniti. Hanno messo a punto una politica panafricana che ponesse le basi per future alleanze economiche, politiche e culturali all’interno del continente. Ma come si fa a riconnettere nazioni traumatizzate e a far sì che esse credano nella forza delle loro idee? Credo che la risposta possa arrivare dall’arte.

Poster del film La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (1966). Immagine pubblicata per gentile concessione di Jihan El-Tahri.
L’arte è sempre stata un linguaggio capace di connettere luoghi e idee. Le speranze riposte nell’unità africana hanno trovato espressione nel primo “Festival culturale panafricano” tenutosi in Algeria nel 1969. Esso raccoglieva tutte le forme artistiche provenienti da nord, sud e dalla diaspora africana, celebrando orgogliosamente il continente in tutta la sua variegata ricchezza artistica. L’evento ha segnato un momento di svolta, prefigurando l’avvio di un’era di grande produzione culturale. Purtroppo, nei decenni successivi, è stato fatto ben poco. La splendida Cinémathèque d’Alger ha chiuso i battenti e sono scomparsi teatri e gallerie d’arte. Ai talenti locali non è rimasto altro che cercare nuove opportunità di espressione artistica al di là del Mediterraneo, tentando di affermarsi in Europa.
Lo scorso mese sono stata invitata al festival “Cinema Engagé” di Algeri. Le proiezioni e il dibattito al quale ho preso parte si sono tenuti alla Cinémathèque, la cui sede è stata rinnovata e ospita la pellicola originale del film cult di Gillo Pontecorvo, La battaglia di Algeri. L’imponente poster in bianco e nero collocato all’ingresso funge da monito, rievocando la sanguinosa lotta per l’indipendenza algerina. Il vecchio poster ci ricorda inoltre come i leader rivoluzionari abbiano lottato per riappropriarsi dell’immagine del Paese, della sua storia e della sua identità, sia araba che africana.
La Cinémathèque e i pochi spazi culturali rimanenti sono stati rinnovati nel 2009 quando l’Algeria ha annunciato che vi si sarebbe tenuta la seconda edizione del “Festival culturale panafricano” di Algeri. Le crescenti risorse provenienti da petrolio e gas hanno consentito la ripresa del festival nel quarantesimo anniversario della prima edizione. Tuttavia, in Africa, è raro che le iniziative sponsorizzate dallo Stato attraggano giovani talenti audaci e ribelli. Durante la mia breve permanenza ad Algeri, ho voluto esplorare la scena artistica locale. Su suggerimento di un amico, mi sono diretta verso una galleria che ospitava una mostra dal titolo “Les Ateliers Sauvages”, ma arrivata sul posto mi sono trovata davanti a un edificio da ristrutturare. Seguendo l’originale idea di Wassyla Tamzali, mecenate molto attiva nella scena artistica locale, “Les Ateliers Sauvages” aveva preso possesso del luogo, trasformando uno spazio da demolire in una mostra estemporanea di prima qualità. Queste mostre temporanee vengono allestite regolarmente in tutta la città. Il motto di Tamzali è semplice: “La cultura è più potente della distruzione”. In questa singolare galleria improvvisata, ho scoperto una vibrante scena artistica contemporanea di cui ignoravo l’esistenza.
Mettendo insieme i lavori di cinque giovani artisti, la mostra comprendeva video, installazioni, performance e arte murale. Mentre girovagavo, ammirando il talento degli artisti, sono stata attratta da un murale di 6 x 3 metri, dal titolo La Ronde, realizzato con tecnica mista da Fella Tamzali Tahari. Esso raffigura dei bambini che giocano, con al centro un bambino che regge la testa insanguinata di un toro: un’immagine al tempo stesso tragica e gioiosa. La ruvida bellezza di questo spazio decadente era esaltata dall’illuminazione. Sono rimasta colpita vedendo come dei giovani artisti contemporanei africani abbiano creato un linguaggio e uno stile capace di unire l’intero continente. Dopo l’ondata rivoluzionaria e le rivolte del 2011, le opere d’arte dipinte sui muri si sono diffuse in tutta l’Africa, soprattutto al nord (dove la street art non esisteva).
Graffiti, street art, stencil e arte pubblica sono utilizzati da un numero crescente di giovani artisti contemporanei, sia come forma di documentazione che come strumento di comunicazione, per lanciare messaggi politici ed esprimere dissenso. Interi dibattiti e confronti politici e artistici si tengono sui muri delle città, da Città del Capo al Cairo. Le autorità dipingono ritratti di martiri rivoluzionari e slogan politici, che poi vengono cancellati e ridipinti dagli artisti.

Stencil sul Tank Wall. Foto: Bahia Shehab (2012).
La storia di un particolare muro del Cairo rappresenta l’essenza di una battaglia tuttora in corso tra artisti e autorità. Tutto ha inizio quando il prolifico artista di strada Mohamed Fahmy, noto con il nome di Ganzeer, dipinge un carro armato a grandezza naturale sul muro che si trova sotto il caotico ponte 6 Ottobre. Sul lato opposto, l’artista raffigura un uomo in bici con un cesto di pane. Qualche settimana dopo esplode la violenza e le forze dell’ordine uccidono dei manifestanti. Altri artisti utilizzano quel muro per dipingere una scia di sangue sotto il carro armato, mentre quest’ultimo travolge i manifestanti. Immediatamente, le autorità dipingono il muro di bianco e coprono l’immagine dei manifestanti, ma lasciano il carro armato. Interviene allora un altro artista, che utilizza quello spazio bianco per disegnare un mostro in divisa militare. Le autorità rispondono coprendo la testa del mostro con una secchiata di vernice nera. Bahia Shehab, storica dell’arte e rivoluzionaria stencil artist, lascia quindi il suo marchio, imprimendo la parola “NO” su tutto il muro.
Come a dire, gli artisti non possono essere ridotti al silenzio.
In numerosi Paesi africani, la censura e la generale restrizione della libertà, insieme alla mancanza di spazi per l’arte, hanno favorito l’esplosione della street art. Ibrahim Humaid si è conquistato il nome di “Banksy di Bengasi” ricoprendo tutti i muri di Tripoli con immagini del colonnello Muammar Gheddafi. Le strade hanno dato voce anche a collettivi come Zoo Project in Tunisia. Sul versante opposto del continente, in Sudafrica, alcuni collettivi di Città del Capo, come Burning Museum, hanno affrontato questioni come gentrification e identità. Nel 2007, Osmic Menoe ha fondato a Johannesburg un festival dedicato ai giovani talenti, mettendo insieme street art, musica hip hop e installazioni. Denominato “Back to the City”, il festival si tiene annualmente in una data simbolica, il 27 aprile (la giornata in cui si celebra la Festa della Libertà in Sudafrica). Ogni anno, parte di Newtown viene chiusa al traffico, gli artisti si esibiscono sul palco e realizzano i loro graffiti sui pilastri sotto il ponte M1.
 Murales di Ibrahim Hamid, Bengasi, Libia (settembre 2011). Foto: Kelvin Brown.
Murales di Ibrahim Hamid, Bengasi, Libia (settembre 2011). Foto: Kelvin Brown.
Un altro artista degno di nota è Breeze Yoko. Per Breeze – cresciuto a Gugulethu, vicino Città del Capo – i graffiti sono una forma d’arte prettamente occidentale. Un giorno, mentre frequenta le superiori, vede su un muro la scritta “Biko vive”. Qualche settimana dopo, la scritta viene cancellata e rimpiazzata con “Biko marcisci all’inferno”. Quell’opera di street art gli fa venire voglia di scoprire chi sia Biko. Attraverso questa esperienza, si avvicina alla politica e al movimento Black Consciousness e inizia a utilizzare i graffiti per mettere in discussione “chi è che scrive la storia”. Il suo debutto nella street art nel 1998 è simile a quello di molti altri giovani artisti africani: una forma di ribellione contro il sistema. Breeze si confronta successivamente con questioni politiche controverse, come la distribuzione delle terre e la difesa dei valori, attraverso elaborate rappresentazioni di mucche dipinte nei luoghi più improbabili del Sudafrica.
Breeze descrive il suo concetto “Paint It Black” come “un modo per mutare le rappresentazioni e le percezioni negative del ‘nero’, inteso come colore, identità, etichetta razziale o idea. Il nero è tutto fuorché negativo. È accogliente e aperto, simboleggia un inizio, non la morte. L’Africa e gli africani sono stati rappresentati negativamente, e in parte lo sono ancora”. Attraverso la sua arte, Breeze cerca di promuovere una narrazione alternativa dell’Africa.
Oggi, nell’era di internet, assistiamo alla nascita di collaborazioni in tutto il territorio africano. Artisti come Breeze, Ganzeer e molti altri hanno sfruttato le potenzialità delle nuove tecnologie e dei social media per far sentire la loro voce. Internet fornisce uno spazio in cui gli artisti africani possono finalmente competere alla pari. Provenire dall’Africa non è più un ostacolo per accedere a concorsi, partecipare a residenze artistiche e far circolare le proprie opere. Attraverso internet, persone che la pensano allo stesso modo possono incontrarsi e trasformare le loro idee di speranza e unità africana in ambiziosi progetti artistici.
La verità è che ci conosciamo ancora troppo poco. Oggi le divisioni vengono esasperate e alimentate costantemente dalle nostre paure, generando casi di xenofobia ed estremismo religioso. Iniziative come ‘Invisible Borders’, ‘Africa Remix’ o 1:54 Contemporary African Art Fair sono tra le poche che cercano ancora di ricostruire i ponti per i quali i leader dell’indipendenza africana hanno gettato le fondamenta.
Concludo citando, ancora una volta, il discorso di Thabo Mbeki, “Sono africano”: “Per quanto improbabile possa sembrare agli scettici, l’Africa prospererà!”.
Jihan El-Tahri è una filmmaker, autrice e artista francese nata in Egitto. Ha diretto e prodotto decine di documentari, collezionando numerosi premi, e ha scritto tre libri. Lavora da vent’anni per istituzioni cinematografiche africane. Nel 2015, in occasione dell’apertura del FORUM 1:54 a Londra, ha tenuto un discorso sulla scissione nord-sud in Africa.
Questo articolo è stato pubblicato nel numero di marzo 2016 di ART AFRICA. La traduzione è di Laura Giacalone.
Con il supporto di








