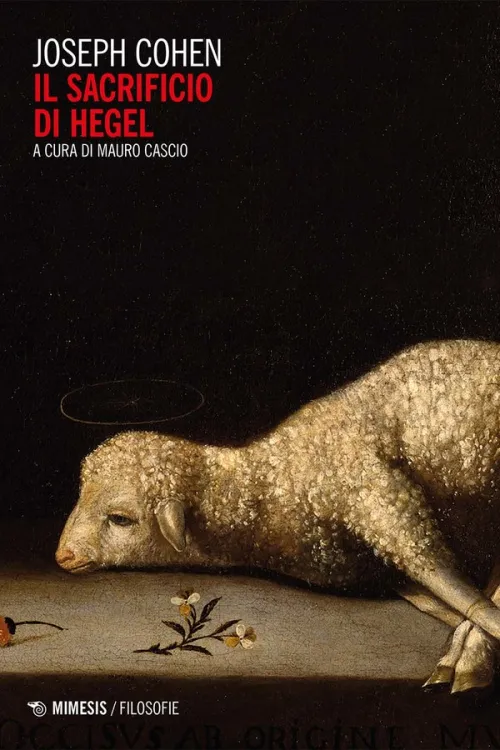L’altro Hegel di Cohen
Tutt’altro che semplice è tornare a confrontarsi con quello che, senza ombra di dubbio, è il più grande pensatore della modernità; il teorico della “dialettica”… il più greco di tutti i Greci, avrebbe detto Heidegger. È noto, infatti, come per quest’ultimo Hegel andasse considerato come il più radicale dei Greci.
D’altronde, come non riconoscere che “pensare” dopo Hegel significa non poter fare a meno di assimilare e digerire l’enormità di un sistema convinto di doversi fare testimonianza non tanto di un semplice punto di vista sul reale, ma del “vero” in quanto tale? Del “vero” in quanto fondamento della totalità del reale.
Lo sa molto bene Joseph Cohen, raffinatissimo filosofo francese che dedica un intero volume – importante anzitutto per la radicalità di un approccio ermeneutico sorprendentemente originale – a un serratissimo corpo a corpo con il pensiero hegeliano. Il volume in questione si intitola Il sacrificio di Hegel ed è uscito nel 2025 per i tipi di Mimesis.
Cohen legge l’autore della Fenomenologia dello Spirito lasciandosi decisamente alle spalle le pur importanti letture che il Novecento aveva proposto della prospettiva dialettica disegnata dal tedesco. Si lascia cioè alle spalle Heidegger e Adorno, ma anche Deleuze e Derrida. Sì, perché, sia per Heidegger che per Adorno (ma poi anche per i due francesi), Hegel rappresenta l’emblema di una “contraddizione” solo apparente – di fatto fungente da sbiadito riflesso di una verità “eterna” semplicemente e solo ‘approssimativamente’ ricordata dal tempo storico. Fermo restando che, indipendentemente da quest’ultimo, nessun ‘vero’ potrà mai guadagnare un compimento definitivo, neppure dopo aver attraversato tutte le contraddizioni e i punti ciechi necessari al palesarsi della sua essenza più propria.
Insomma, Cohen non pensa affatto, sulla scia di Heidegger, che la “cosa” del pensiero sia un semplice “pensato” (concetto assoluto), e neppure che la contraddizione costituisca un semplice “momento” del processo dialettico, destinata, come tale, a risolversi in un concreto “uniforme e vuoto” di reali differenze, come crede ancora Derrida. Ma neppure si mostra insofferente, come Deleuze, nei confronti di un processo che in Hegel sarebbe ancora fondato su ‘identità’ e ‘negazione’.
Cohen è lontano da Deleuze; per lui, infatti, la “negazione” non costituisce il vulnus del sistema hegeliano; ma indica piuttosto il cuore vivente, nonché inestirpabile, della sua “dialettica”; che non si lascia mai ‘superare’ da alcuna astratta positività.
Lo rileva, acutamente, il nostro esegeta: “il dire speculativo (proprio dello Spirito assoluto) si espone e si esplicita nella e attraverso la sua negazione” (p. 26); con buona pace di Adorno, dunque (secondo il quale Hegel non avrebbe saputo pensare, come si deve, la “negazione”). In perfetta conformità con un dire che insiste procedendo sempre da una sorta di ferita originaria; senza mai farsi incantare dalla puerile pretesa di sanarla.
D’altro canto, nello Hegel letto da Cohen, così come non si allude alla provenienza da un luogo diverso dal pensiero medesimo, neppure ci si mostra indifferenti nei confronti di quel che il linguaggio non dice e mai potrà dire. Anzi, proprio a questo ‘impossibile’ a dirsi ci si affida, in ogni momento di un comunque irrisolvibile sviluppo, conformemente a un’assolutezza che invero sempre “si nega da sé” (p. 31), proprio in quanto indistricabilmente connessa a una contraddizione davvero “infinita”.
Ecco perché Cohen può affermare che in Hegel l’enunciato speculativo “si sperimenta sempre come l’infinita contraddizione del suo Sé che diviene e avviene” (p. 30).
Insomma, l’unità che compete all’assoluto hegeliano – ci mostra con grande persuasività il filosofo francese – comprende in sé medesima “il lavoro della sua scissione” (p. 31), consentendo al pensiero di non chiudersi mai in se stesso, e dunque di non perdere mai di vista la resistenza costituita da un essere rigorosamente in-condizionato (proprio come il pensiero, peraltro); destinato, in quanto tale, a farsi contraddizione e sacrificio della coscienza medesima. Cioè, del dire speculativo che in essa sempre si perde e si salva, in-uno, e lo fa proprio sacrificandosi. Cioè, sperimentando, da ultimo, finanche il sacrificio del sacrificio.
Vero sacrificio essendo infatti solo quello in grado di esporsi da ultimo al proprio sacrificio; cioè, al sacrificarsi del sacrificio medesimo.
Per essere più precisi, potremmo dire che Cohen capisce alla perfezione come Hegel “giochi sempre con il ‘sacrificio della contraddizione’ quale unica possibilità della sua dizione” (p. 34). Sì che tutto sia incessantemente sacrificato e salvato, in-uno.
Per questo “il dire speculativo ha da sprofondare all’infinito nell’equivocità della sua contraddizione” (p. 37).

Da tutto ciò la capacità, da parte del sistema hegeliano, di mostrarsi ben più forte delle critiche con cui nel Novecento si sarebbe cercato di superarlo – senza mai riuscirci davvero.
E la lettura di Cohen ci aiuta, con grande merito, a prenderne coscienza; rendendoci consapevoli anche del fatto che, nel dire speculativo, il farsi-altro è l’unico modo praticabile da questo stesso dire; l’unico modo per essere sino in fondo se medesimi. Insomma, per lui Hegel avrebbe anticipato di circa un secolo quel ritmo fatto di “differenza e ripetizione” tematizzato da Deleuze solo nella seconda metà del Ventesimo secolo.
Un ritmo autoproducentesi, precisa Cohen, che “si spinge oltre e ritorna a se stesso” (p. 43). Indicando e sancendo, in-uno, la necessità di una vera e propria nuova “grammatica” e di un novissimo “dire”. Capaci di mettere finalmente in moto la rigida e afona postura del linguaggio ordinario; rendendolo plastico al punto tale da dare luogo a una lingua in grado di farsi “al tempo stesso singolare e universale, umana e divina” (p. 44). Ossia, a quel ‘riconoscimento assoluto’ tra le singolarità che vive sempre e solamente nella radicale equivocità “delle sue espressioni” (p. 46). E non può certo venire espressa da una qualche “scienza”; se con questo termine si intende il sapere definitorio e intellettualistico così ferocemente criticato da Hegel.
Ma solamente da un sapere di ben altro genere; un sapere che sappia essere in-uno anche “amore”.
E che per ciò stesso sappia farsi poema; ovvero, poesia in grado di esprimere la stessa “pura essenza del dire speculativo” (p. 49). Un amore in grado di muoverci verso l’altro senza sottoporlo a un fuoco di fila di domande – anche perché “se facesse domande, non si tratterebbe più di amore” (p. 49).
Un amore che chiede solo ‘vicinanza’, dunque; e non ragione in grado di ‘giustificarlo’. Un amore concepito come forma “vera” del dire speculativo proprio in quanto non bisognosa di giustificarsi, o di rendere ragione di sé medesima.
Per questo capace di esporsi al proprio sacrificio. E quindi alla morte; il che significa poi: alla singolarità della vita.
Ossia, a quella luce divorante al cui cospetto tutto appare destinato a consumarsi; tanto da non lasciare alcuna traccia: e rendere anche possibile, da ultimo, il proiettarsi, da parte di questo stesso dire speculativo, in un futuro senza fine, e quindi costitutivamente impossibile. Anzi, reso possibile – e non è un semplice gioco di parole – proprio dalla sua inguaribile impossibilità.
Cui tutto andrà comunque sacrificato; e anzitutto il “tutto” – come al senso ultimo “della stessa negatività speculativa” (p. 56). Che apre al ‘significato’ assoluto proprio in quanto capace di proiettarsi verso un “avvenire” già da sempre immanente al divenire medesimo; e dunque vivente e operante nelle contraddizioni dei fenomeni in virtù di “un atto infinito, o di un infinito in atto” (p. 59). Espressione, quest’ultima, che ricorda molto da vicino l’attualismo gentiliano e la sua imprescindibile radicalizzazione del dialettismo hegeliano (vocata a trasformare l’idealismo in un vero e proprio “attualismo”). E che, nella lettura di Cohen, dà luogo invece a una non meno originale combinazione di Atene e Gerusalemme. Ossia, di tragedia e redenzione; di tragicità e gioia.
Ossia, ad un vero e proprio “doppio movimento di salvezza e tragedia” (p. 65); in virtù del quale ad ognuno sembra affidato il compito di perpetuare la tensione in virtù di un polemos irrisolvibile proprio perché già da sempre risolto, e già da sempre risolto proprio perché costitutivamente irrisolvibile.
Come quello operante, ad esempio, nella polarità che vede contrapposti Antigone e Creonte; legge umana e legge divina – che non sono semplicemente o astrattamente complementari. Perché la legge della singolarità e quella dell’universalità indicano piuttosto una contraddizione destinata a far esplodere ogni determinazione del kosmos. Dicendo in uno il suo essere sempre sacrificata e salvata insieme; nell’una che si sacrifica e si salva nell’altra e come altra. Nel rendersi sempre “colpevoli” da parte di ognuna delle due; destinate, come sono, ad imporsi annientando la legge opposta; ma anche annunciando “salvezza, nonostante la catastrofe” (p. 81).
Salvando, ogni volta, una differenza che mai si lascerà ‘comporre’ o sintetizzare.
Per questo tutto crolla; è destino. Ma crolla “con un ritmo infinito” (p. 82), precisa Cohen.
Sì, perché, se il “vero” è contraddizione, va anche rilevato che nessun mistero lo nasconde; cioè, nessun fondo senza fondo lo supporta ab alio. Nessuna astratta presupposizione, insomma, ne inficia l’originarietà.
Tale “aporia”, infatti, guida e governa ogni passaggio ed ogni ritmico svolgimento fenomenico; proprio per questo la medesima si trova originariamente affidata a una dimensione costitutivamente ‘politica’. Oscillante, di fatto, tra dovere e azione, tra universalità e singolarità, tra purezza del giudizio e concretezza impura dell’azione.
Perché è proprio qui che può palesarsi un’origine sempre ad-veniente, e mai astrattamente passata. Sempre a venire, dunque; proiettata cioè verso un avvenire alla luce del quale la contraddizione che nega e si nega “non vuole e non può certo rendere ragione” di se medesima; perché non intende giustificarsi… ma solo agire, se agisce, perdonare, se perdona, e ascoltare una eventuale confessione, se la ascolta.
D’altronde, se non fosse così, neppure si tratterebbe di Dio.
Ed è proprio di questo che si tratta, infatti; sì, di Dio. Di qualcosa che rompe l’astratta e illusoria stabilità di ogni discorso aridamente mono-logico. E proprio per questo sa resistere alle tracotanti pretese del “giudizio” (come quelli che tutti noi continuiamo a emettere); mettendo radicalmente in crisi la sua stessa naturale propensione a interrompere il movimento della vita, il suo avvenire, e dunque la sua stessa significanza e ogni possibile riconoscimento, così come ogni reale e vivificante “reciprocità”.