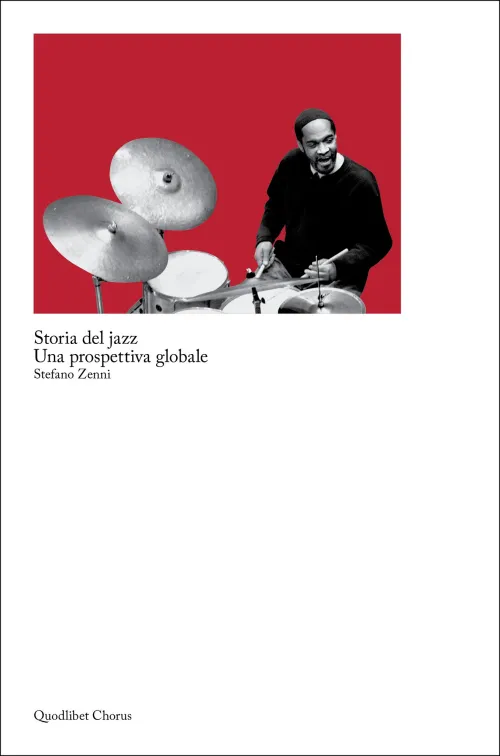Stefano Zenni, ovvero il jazz
Dopo la prima edizione del 2012, esce ora la nuova versione, aggiornata e ampliata, di un importante lavoro firmato da Stefano Zenni e intitolato, assai ‘semplicemente’, Storia del jazz (Quodlibet, Macerata, 2025, p. 1000).
A questo proposito diventa importante (per comprendere appieno la specificità di questo straordinario lavoro di ricognizione) guardare al sottotitolo del nostro volume, impegnativo e denso come pochi altri: “Una prospettiva globale”.
Sì, perché quella di Zenni è anche una storia del jazz, ma è soprattutto una topologia, una geografia del jazz, un’analisi comparata, ma anche un vero e proprio sguardo panoptico (a partire da un occhio che tutto vede), e dunque globale, sul mondo del jazz; messo a fuoco a partire da molteplici, più o meno specifici, punti di vista. Ognuno dei quali sembra venire esplicitamente concepito per illuminare influssi, intrecci culturali, movimenti e trasformazioni, contaminazioni e rimescolamenti che hanno ruotato e continuano a ruotare intorno al mondo del jazz; riuscendo a mostrarne, con grande lucidità, la natura oltremodo complessa. ll fatto è che, per comprendere davvero questa straordinaria tradizione musicale, appare assolutamente necessario dotarsi di competenze sociologiche, musicali, storiche, geografiche, antropologiche etc; ossia, competenze che vanno ben al di là della conoscenza dei generi che hanno caratterizzato la storia del jazz, a partire dal ragtime, dal New Orleans e dal Dixieland, passando attraverso lo Swing, il Be Bop, l’Hard Bop, il Cool Jazz, sino alla rivoluzione operata dal Free Jazz da un lato e dal Jazz-Rock dall’altro.
Il Jazz è molto di più, sembra volerci suggerire il nostro studioso. E per comprenderne davvero il senso è necessario essere dotati – e Zenni lo è al massimo grado – di una preparazione multiforme, conforme cioè alla natura intrinsecamente multiforme della musica in questione.
Convergenze, derive, influssi più o meno sotterranei di tradizioni provenienti da molto lontano (lontano nel tempo e nello spazio), consentono a Zenni di disegnare quindi una fitta trama reticolare in rapporto a cui mostra di sapersi districare con grande agilità, precisione e sorprendente capacità di sintesi. Anche il fenomeno del commercio degli schiavi, solitamente riassunto in poche righe (in molte pur significative Storie del jazz) viene qui analizzato e minuziosamente ricostruito, in tutte le sue molteplici fasi (anche attraverso significative mappe) mostrando quante e quali implicazioni avessero le diverse tradizioni di provenienza e le diverse ritualità che, nel Nuovo Mondo, avrebbero prodotto trasformazioni e sarebbero state a loro volta trasformate, dando vita a interessanti e quasi sempre inediti connubi tra universi linguistici e simbolici anche abissalmente distanti.
Quello che Zenni ci mostra con grande efficacia sono dunque le mille diversificazioni prodotte da tali intrecci; che non si giustificano certo parlando genericamente di Africa e Stati Uniti.
Intrecci che avrebbero reso tutto quanto meno doppio, ossia ambivalente, sul modello della doppiezza incarnata dal dio Legba – “briccone e bifronte” (p. 43), lo definisce il nostro –, rendendo nello stesso tempo possibili le molte traduzioni, spesso ironiche, della cultura con cui ci si sarebbe contaminati. Importante poi, la sottolineatura, operata sempre dal nostro ‘storico’, dell’importanza che ebbe la danza nella tradizione destinata a svilupparsi a New Orleans.
Il jazz è infatti sì musica, ma anche danza, ballo, movimento, scatenamento ‘tribale’ (lo avrebbe capito anche Julius Evola, molto meglio, sicuramente, del progressista ma ‘rigidino’ Adorno) – insomma, musica che non può evitare di far muovere sì i piedi all’ascoltatore, ma anzitutto al musicista.
Danza, e dunque spettacolo, destinati a diventare importantissime componenti di una concezione musicale che, di contro al divieto imposto ai neri africani di prendere posto a teatro, riuscì ad aprire nuovi spazi per schiavi destinati a diventare sempre più clamorosamente protagonisti di una forma di minstrel show proteso a diffondere tutta una serie di importanti stereotipi “tratti dal mondo della schiavitù” (p. 57).
Importante per la nascita del jazz fu poi l’adozione di “modi espressivi della chiesa santificata nel repertorio profano e strumentale” (p. 91).
E, particolarmente interessante, il ruolo rivestito poi da un ambiente molto particolare e specifico (di cui nessuna storia del jazz aveva in realtà ancora scritto): la bottega del barbiere. Sì, non avete letto male!
“La bottega era infatti un luogo fondamentale di ritrovo e intrattenimento – ci spiega Zenni –: in cui, tra le altre cose, gli uomini, in genere quattro, cantavano melodie popolari armonizzandole lì per lì” (p. 91).
Sorprende poi l’ampiezza delle conoscenze di Stefano, anche quando si sofferma sull’analisi delle vicende e delle produzioni dei singoli musicisti; a partire da Duke Ellington, uno dei primi grandi eroi del jazz, esploso nel panorama musicale anche grazie al sodalizio con Irving Mills (uno dei manager più potenti di New York), che lo fece incidere con importanti case discografiche, consentendo la veloce maturazione di uno stile compositivo e orchestrale che avrebbe dato vita a capolavori come In A Sentimental Mood, Take the “A” Train e It Don’t Mean a Thing.
Poi Zenni ci ricorda come fu proprio un critico – un critico della statura di John Hammond (attivo negli States a partire dagli anni Trenta) – a promuovere nuove dimensioni esecutive; che non potevano più essere solo quelle orchestrali (fino a quel momento protagoniste assolute del panorama musicale). Bisognava dare spazio ai solisti e ai piccoli gruppi, rilevanti soprattutto per la loro costitutiva “informalità” – unica reale custode del vero spirito del jazz (ammesso che si possa parlare di un “vero” spirito del jazz).
La piccola formazione permetteva infatti ai musicisti – ci spiega ancora una volta Zenni – di esprimersi con molta maggior libertà; inimmaginabile nel contesto dei “rigidi e standardizzati arrangiamenti per big band” (p. 374).

Ma poi il nostro storico analizza con cura e perspicacia anche le dinamiche sociali e antropologiche destinate ad animare le città, e a renderle protagoniste di una forma musicale tanto importante da esser ritenuta imprescindibile anche da compositori e musicisti classici come George Gershwin e Leonard Bernstein (per non parlare di Stravinsky).
Si pensi, in questo senso, al ruolo rivestito da una strada in particolare, sita nel cuore della Grande Mela: la Cinquantaduesima Strada, che divenne “l’epicentro mondiale del miglior jazz” (p. 375).
Certo, nei locali newyorkesi si faticava a produrre una reale collaborazione tra bianchi e neri. I musicisti bianchi, infatti, non lavoravano spesso in modo formale con i musicisti neri, e dunque non si creavano molte situazioni in cui trattare professionalmente con loro.
Fu solo nel 1935 che il già citato John Hammond convinse Benny Goodman a “formare un trio interrazziale con il pianista nero Teddy Wilson e il batterista Gene Krupa, a cui nel 1936 si aggiunse il vibrafonista nero Lionel Hampton” (p.376).
In ogni caso, tali barriere furono finalmente fatte cadere proprio nella Cinquantaduesima Strada.
D’altronde, il Jazz – ci mostra bene Zenni – è musica vocata a rompere barriere e infrangere steccati. È musica per natura polimorfa; e dunque priva di una natura identitaria realmente determinata o in qualche modo determinabile. Per questo il jazz, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, poté riscoprire le proprie origini africane, soprattutto (ma non solo) ad opera di artisti come Dizzy Gillespie; che le avrebbe riscoperte anche attraverso una interessantissima e azzardata ripresa delle declinazioni caraibiche (in particolare dei ritmi bantu) di quelle medesime origini.
Insomma, ogni volta il jazz ha dimostrato di sapersi fare “nuovo”, e ha saputo indicare nuovi percorsi e nuovi orizzonti di senso proprio tornando a guardare al proprio passato, e in particolare alle proprie origini. D’altro canto, non è certo un caso che le cose dovessero andare in questo modo: quando, infatti, si può essere realmente “nuovi” se non all’origine? Là dove nulla ci precede… obbligandoci a sentirci semplici ‘eredi’.
Quando, cioè, nulla è ancora ‘stato’ (ossia, all’inizio) e tutto può ancora essere. Ecco perché i grandi eroi di questa musica hanno saputo inventare e indicare nuovi percorsi sempre e solamente tornando a guardare alle proprie origini; ossia, riscoprendo l’origine. E dunque “facendosi origine” essi medesimi. Sì da potersi proporre quali coraggiosi inventori di nuove linee di ricerca.
Sarebbe accaduto anche con il free jazz; i cui protagonisti – ci dice il nostro studioso – non si dividono certo in conservatori o progressisti, ma si fanno piuttosto espressioni di “modi diversi di pensare e rinnovare un linguaggio condiviso” (p. 680). Sempre guardando alle origini, in ogni caso.
Si pensi solo al caso “Sun Ra”, ben analizzato da Zenni. Coraggioso protagonista dell’afrofuturismo musicale da lui battezzato guardando a ipotetiche origini egizie, volute anche per ridefinire la storia del popolo nero di là dai modi in cui la medesima “veniva rappresentata dalle istituzioni accademiche e culturali nere” (p. 676).
Vera e propria esperienza dell’origine, dunque, la sua; realizzata attraverso l’assunzione di un’identità aliena, valevole come ‘prova’ di un radicalissimo ritorno al vagito iniziale. Ossia, a quella condizione non somigliante a nulla di precedente (ché nulla può appunto precedere l’inizio), che avrebbe reso assolutamente “unica” l’esperienza frammentaria e radicale della musica composta e orchestrata da Sun Ra.
Stefano Zenni, insomma, ci mostra bene che il jazz altro non è che un grande “dispositivo”; perfettamente conforme alla definizione elaborata da Deleuze, lettore di Foucault. Deleuze, infatti, intendeva il ‘dispositivo’ come una matassa; come un insieme multilineare, composto di linee di natura diversa, che non delimitano né circoscrivono sistemi di per sé omogenei. Ma seguono direzioni e tracciano processi in perenne squilibrio; talvolta avvicinandosi, talvolta allontanandosi le une dalle altre.
E cosa è stato il jazz, se non un dispositivo come quello evocato dalla magistrale definizione deleuziana? Lo mostra perfettamente questo ricchissimo volume dedicato a una musica che ha davvero del “miracoloso”: una musica capace di far propri il linguaggio della tradizione ebraica (come nell’esperienza musicale di John Zorn), ma anche quello del flamenco (come nel caso di Tete Montoliu) o della tradizione indiana (ripresa con grande estro inventivo da Steve Lehman).
Musica capace di diffondersi in uno scenario globalizzato “dove nuove musiche afroamericane animano la scena, e in cui la diffusione capillare del jazz si è sciolta in un sistema arterioso musicale in cui si intrecciano scuole regionali/nazionali, gli ibridi trans-culturali della word music, la ritrovata centralità musicale dell’Africa, le nuove sintesi della diaspora nera nelle realtà urbane, la lingua franca dell’elettronica… ma anche alcuni ambiti della musica colta europea” (pp. 878-879). Una musica, insomma, cui questo volume restituisce finalmente la dignità che gli spetta, riuscendo a disegnarne l’assoluta “esemplarità” e il valore oltremodo paradigmatico in un mondo ormai irrimediabilmente privo di “centro” o di qualsivoglia semplicistica linearità.