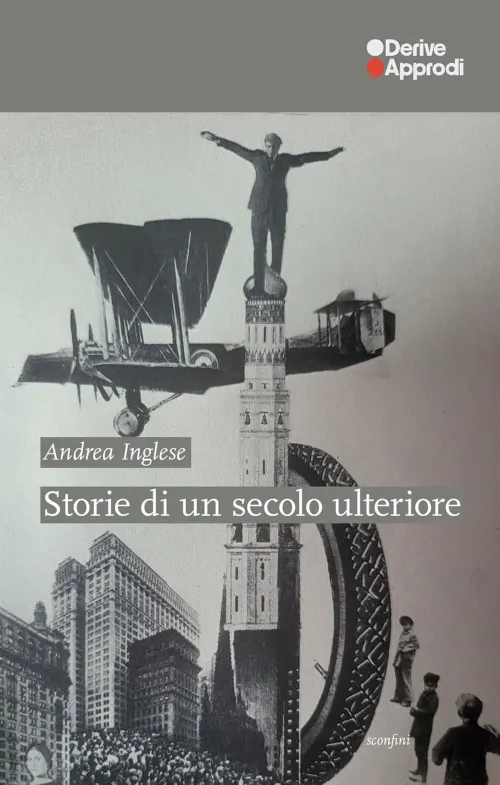L’umanità perduta di Andrea Inglese
La prima storia del secolo ulteriore è la “Storia del giro”. “Il giro è uno solo, ma contano di entrarci tutti prima o poi. […] Il giro è costosissimo in termini psichici, ma è anche l’unico concesso, e una volta entratoci, chiunque tu sia, sei destinato a rimanerci fino alla fine”. Il giro è lunghissimo, lo affrontano esseri di ogni specie, più o meno terrorizzati, più o meno determinati a finire prima degli altri.
Siamo tutti impegnati nel giro, noi umani, “quelli che parlano, quelli che danno ordini a destra e manca, quelli che imprecano, quelli che tentano di ammansire il branco, quelli che mettono gran dosi di volontà in gesti solitamente inutili e inefficaci”, ma tutto questo “profluvio di atti comunicativi, verbali e non verbali” non lo ascoltiamo, ci lanciamo l’un l’altro risposte, ma senza parlarci, “il giro si fa tutti assieme, nel sangue e nei colpi, ma ognuno corre la sua solitaria gara”.
Il racconto che apre Storie di un secolo ulteriore, di Andrea Inglese (Derive e Approdi, 2024) contiene già molti dei temi che attraversano la raccolta di brevi testi in prosa: l’assurdo che scava la nostra esistenza, la ricerca di una definizione – spesso per negazione – dell’umanità, il ridicolo della guerra che ci abita e che incendia le nostre relazioni, la comicità del nostro effimero destino, la goffaggine delle nostre insurrezioni, la disperazione della ricerca di senso, la pervasività del logos e lo scorrere delle parole che non riusciamo ad arrestare, pur senza riuscire a comunicare, e l’illusione del tempo che ci incastra (“il tempo che ci resta preme su quello consumato, ma quello consumato resiste alla sparizione: le vocine infantili si infilano nelle voci cupe e roche dell'adulto, e quale sia una vita resa vicina, resa a portata di mano, tastabile, nessuno riesce ancora a saperlo”, si legge in “Storia di un coma”).
Gli esseri umani protagonisti di queste storie continuano il loro giro, ubbidienti, in rivolta o arresi, marciano verso la fine, “il domani li ha già minacciati e le antiche miserie adolescenziali li accompagnano come un’ombra” e “ognuno vorrebbe un metro cubo di presente dentro cui infilare la testa, come una resina tiepida e traslucida, dove respirare è un incanto. Ma poi lo si capisce che il tempo sfugge assieme allo spazio, che nulla rimane davvero nelle tasche dei pantaloni o nei cassetti del soggiorno”.
Ma sono davvero umane poi, queste figure che si muovono tra le righe delle pagine e di cui spiamo le parole, i movimenti, i pensieri, e che sembrano lasciar trapelare qualcosa di difforme, grottesco, alieno? Secondo la “Storia della perduta umanità” non siamo più esseri umani da un bel pezzo e funzioniamo molto meglio, senza scrupoli, desideri o fantasia.
Quelli che pretendono di essere restati umani, sono dei temibili ipocriti, l’umanità è stata sostituita da una tabella preparata prima della nascita, con calcoli e disegni tecnicissimi, da consultare al bisogno.
L’umanità si perde dentro quel reticolato fitto di caselline vuote, negli ingranaggi che girano a vuoto, si spegne lungo i percorsi obbligati, nei gesti meccanici e ripetuti, mentre si prova a comprimerla dentro architetture forzate nell’illusione di costruire un senso, un’impalcatura che tenga, un discorso a cui credere, che ci tenga tranquilli, che si posi sulla realtà nascondendo mostruosità e vuoti e ci lasci continuare a girare.
In questo scenario ogni anomalia o deviazione dallo schema deve essere riassorbita, forzata tra le sue maglie strette, interpretata e spiegata (come eccentrica forma d’arte, innocua facezia) e se questo non è possibile va eliminata.
Così tocca decidere se rientrare nel sistema che tiene insieme le cose, agevolarne la pendenza, collaborare a governarne la direzione o abdicare, disertare, venir meno, morire (e “portarsi avanti, perché bisogna pur fare qualcos’altro a un certo punto, oltre a vivere”), oppure insorgere, scegliere la libertà smisurata e imprudente della balena: “C'è solo una balena e una baleniera e io devo scegliere. […] O la vita spensierata ma esposta alla morte del cetaceo, o la sicurezza del posto di lavoro, intorbidata dal biasimo e dal disprezzo altrui. Queste alternative, te le vendono ogni volta come ultime magnifiche occasioni. Ma alla fine sono semplicemente un’ulteriore e più sofisticata fregatura”.
Se anche la possibilità di una scelta è un abbaglio, se il gioco sembra truccato, la vita si rivela come un’enorme, articolata sceneggiata, uno spettacolo, una farsa.
In epigrafe, le parole di Liliane Giraudon, “abito un mondo di tragedia e di fiera”, anticipano il registro del libro di Inglese, tra l’umoristico e l’inquietante, con una scrittura che sperimenta la forma della prosa breve estendendone i confini (sconfinando, come raccomandato dalla Collana che ospita il libro); che cambia genere e voce ed esplora i territori dell’assurdo, del nonsense e del paradossale, con parodie, distopie, ucronie, esercizi di stile, che gioca con il fantastico, il mostruoso, l’alieno e passeggia su un piano parallelo (ulteriore), come lo spazio straniante e angoscioso dell’incubo, ma lo fa con leggerezza, conservando ovunque una lucidissima ironia grottesca.
La realtà ricomposta dalle storie che compongono il libro è riconoscibile, familiare, ma come trafitta da schegge ed elementi deformanti. Incrinata e obliqua, eppure verosimile, somigliante alla realtà come una sua prossima deriva, una sua piega nascosta, la parte in ombra del tempo che viviamo.

È da lì che vengono le storie del secolo ulteriore, dai luoghi marginali nelle increspature del nostro presente, un tempo densissimo (e densa è anche la scrittura di Inglese, ogni parola pare traboccare di senso sulle altre) di cui le storie portano alla luce il riverbero della parte eclissata.
A guardarla in faccia, la realtà, a cercarvi un senso, un verso, una chiave di lettura, “sembra alla fine, un gran baratro di buio, una gran parete di nebbia”, e bisogna avere pazienza, scrive Inglese, “suggerisco, benché ultimo arrivato, di guardare di fronte fino in fondo. Non bisogna distogliere lo sguardo proprio quando comincia ad affaticarsi”.
È un invito a restare in ascolto, anche nelle scomodità di un discorso che indugia tra opacità, spigoli e storture, dove la scrittura sembra accompagnare per mano e poi fa il vuoto sotto i piedi, toglie gli appigli e cambia il posto delle cose.
“Non tutto quello che dicono le parole, lo dicono per davvero. Non tutte le finzioni sono prive di fondamenti reali” e chi legge deve almeno credere che ci sia qualcosa da trovare, leggendo le “infrarighe”, nell’intercapedine tra le parole, quelle che si rovesciano sul mondo e lo ricoprono di significati.
Molte storie sono fatte di discorsi ininterrotti, parole che brulicano, ricolmano le cose, le travalicano, le cancellano (come in “Storia di un numero” o “Storia di una notizia”), tracimano e creano la realtà e le sue innumerevoli deformazioni possibili: “niente è meno chiaro di cosa sia uno stato o un popolo o persino una nazione – dice l’esperto di “Storia con esperto” – e avete perfettamente ragione la nazione è un sogno, un mito, un racconto, qualcosa di simile a una concatenazione di parole, parole affascinanti, certo, che stanno dentro legami saldi, legami che sembrano inscindibili, è vero, ma si tratta comunque di parole intessute saldamente tra loro, e di nulla più”.
Se la realtà è fatta di parole, la questione del senso si gioca sul piano simbolico: “non c'è veramente nulla di cui gioire: ricordo che una guerra simbolica, la peggiore mai conosciuta della specie umana, potrebbe scoppiare qui e oggi. Tutto è ingarbugliato e irrisolto, i corpi soffrono o sono troppo stanchi, le fonti energetiche interne ed esterne sono praticamente esaurite, ma i simboli, quelli, perdurano intatti” (nella bocca, nella testa, in appositi archivi…).
Nella “Storia con fagioli”, di fronte all’insopportabile vertigine causata dalla ricerca di senso, si auspica un discorso che riempia le cose e le rimetta in ordine: “sarebbe ora di andarsene o di compiere qualche gesto che dia un significato alla presenza del piatto di fagioli (pieno), o almeno del tavolo (una conferenza sulle favole, ad esempio, in cui il fagiolo ha un ruolo di oggetto transazionale, o di innesco narrativo, o di metafora atroce)”; nella “Storia delle frasi fatte” ci si domanda invece come riempire di parole otto miliardi di bocche che, come è tipico degli esseri umani, avranno voglia di parlare, perché “è come un istinto innato: aprono la bocca, e giù discorsi a non finire. Per loro è come un diritto”, ma non sanno cosa dire, e si auspica l’intervento di un’intelligenza artificiale che rovesci dentro i crani una memoria verbale gremita di frasi innocue, di ritornelli e di rime.
Parole vuote ma rodate, buone per ogni occasione, esercizi di stile (come la “Storia con plagio” o la “Storia con finali alternativi”), infatti, si legge nella “Storia con Madessa”, “nel 2032 i poeti vivono assieme ai cani randagi, come sempre non hanno la patente, ma ormai neanche un lavoro […] soprattutto non sanno scrivere, non conoscono, d'altra parte, i nomi degli alberi, degli uccelli che si posano sui rami o delle larve di insetti che si nutrono nelle conche dei tronchi”.
Con uno scivolamento sineddotico, il discorso sulle parole diventa quindi anche un discorso sulla scrittura, sulla letteratura e sulla sua funzione, su ciò che avviene nello scambio tra autore e lettore e su ciò che da ciò si può innescare.
È questo il filo che tiene insieme gli intermezzi senza titolo che interrompono la partitura dei racconti e cercano un dialogo con una seconda persona singolare, al di là della pagina scritta.
Sono testi nascosti tra le storie che instaurano con chi legge una conversazione che pare venire da lontano, sembra passare attraverso un filo lunghissimo, eppure suona intima e vicina, come in un cantuccio, o sotto la stessa coperta.
Sono frammenti di un discorso faticoso, che prova a fare i conti con la difficoltà del parlarsi e dell’ascoltarsi, con la resistenza e la sopraffazione che caratterizzano spesso gli atti comunicativi e che sono alla base di molte delle storie raccolte nel libro (“Tu hai già molte cose da ascoltare, cose molto più urgenti, molto più educative e ludiche, e poi tu vuoi dire la tua, perché dentro premono, come in un terribile formicolio, le molte parole. […] e comunque vorresti anche ascoltare le mie, ma senza che esse finiscano davvero per forzare, per deviare o cancellare le tue”).
Ma ci si prova lo stesso a fare il vuoto dentro, così che le parole risalgano, e sono “parole ruvide, spiacevoli, praticamente inutilizzabili”, “non erano quelle che tu volevi dire né quelle che io volevo trascrivere, ma sono proprio queste. Da qualche parte sono uscite”. “Eppure le abbiamo ascoltate insieme”.
Scrittura e lettura sono azioni che si rispondono, un “metodo esorcistico che funziona per possessione rovesciata, la voce ti entra dentro, dalla pagina”, ti attraversa e non servono nervi, ma moti dell’animo invisibili, immateriali.
Il nodo sta in quello scambio, sta lì l’umanità perduta, la possibilità di recuperare il senso, di arginare la deriva del nostro presente nel secolo ulteriore.
Ci si parla, ma il groppo rimane lì, nello stomaco, denso, oscuro, leggermente rumoroso e “c’è dentro tutto, c’è il significato della tua vita, che è poi il significato dell’uomo o della donna universale”.
Bisogna allora posare, come i Sioux, “l’orecchio al suolo, alle pareti, alle finestre a doppi vetri della camera da letto” e mettersi in ascolto: “io appoggio l'orecchio affinché possa percepire, e poi decifrare, i gemiti lievi del tuo groppo, i gemiti del grande universale significato, dentro cui trascorriamo tutti, come attraverso una nube a tratti scura a tratti lucente”.
Le parole sono solo un mezzo, un ponte, bisogna attraversarle, andare oltre lo strumento alieno della voce: “faremmo meglio ad alzarci insieme per andare a giocare a bigliardino. Con le birre in mano. Che almeno lì si grida, lì c’è gente intorno, le voci scoppiano ma senza lasciare traccia. Non cadono né dentro né fuori. C’è l’aria apposta per questo. Se le porta via l’aria, mentre noi siamo sì uno di fronte all’altro, ma tranquilli, siamo vuoti, siamo frenetici con i gesti del gioco”. Bisogna camminarsi accanto, ascoltarsi parlare, “aderire a gesti già scattati, restando più o meno in equilibrio sui propri passi. Finché qualcosa acquisisce la giusta centralità, finalmente”, superare le parole e la loro ridondanza, dimenticarne l’eco, lasciare che le porti il vento e trovare il coraggio di guardarsi davvero.