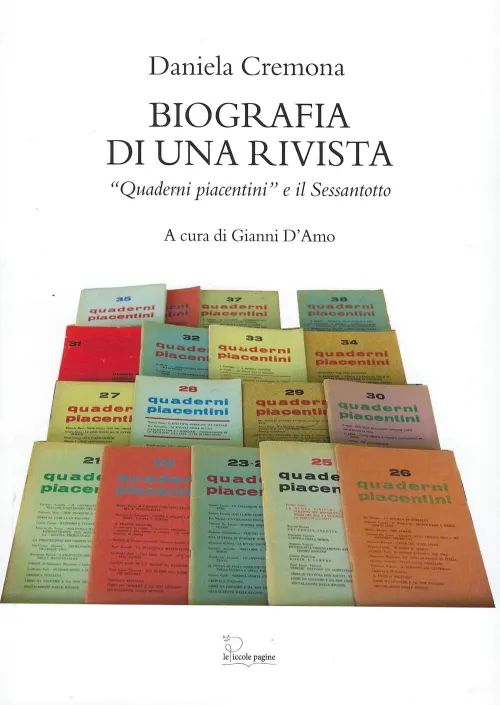Quaderni piacentini senza padroni
I ”Quaderni piacentini”, fondati nel 1962 nella città emiliana da Piergiorgio Bellocchio (1931-2022) e da Grazia Cherchi (1937-1995), è stata la più importante rivista tra cultura, politica e società dei decenni Sessanta e Settanta, per concludere la prima serie nel 1980 e proseguire con una seconda dal 1981 fino al 1984. Ad essi sono stati dedicate due antologie: la prima (1977), sul primo periodo, a cura di Luca Baranelli e Grazia Cherchi; la seconda, Prima e dopo il ‘68 (1998), a cura di Goffredo Fofi e Vittorio Giacopini, su tutto l’arco della loro storia. Esiste poi un breve saggio più recente (2017) I “Piacentini”. Storia di una rivista (1962-1980) di Giacomo Pontremoli, ma il libro di Daniela Cremona (1955-2012), Biografia di una rivista. “Quaderni piacentini” e il Sessantotto (le piccole pagine), a cura di Gianni D’Amo, è quella che si potrebbe definire l’opera definitiva sulla rivista che ha meglio rappresentato i fermenti della Nuova sinistra e ha fornito la biblioteca di base alla generazione del ‘68. Il libro è lo sviluppo di una tesi di laurea di una valorosa rappresentante sindacale di cui D’Amo, a cui si deve la fatica (il labor amoris) della pubblicazione, tratteggia la figura di donna impegnata nel sociale che ha riflettuto col rigore della studiosa e la passione della militante su un’impresa editoriale defilata ma centrale per comprendere l’Italia negli anni della sua massima trasformazione. I “Quaderni piacentini” nascono sull’esempio delle riviste di Piero Gobetti, del “Politecnico” di Elio Vittorini (e della celebre polemica con Togliatti) e di “Ragionamenti” (1955-1957), rivista milanese che nasce a cavallo dei fatti di Ungheria (1956), animata da Armanda e Roberto Guiducci e che molto deve al marxismo critico di Franco Fortini, già impegnato nel “Politecnico”. È a lui che si rivolse un gruppo di giovani piacentini, tra cui Bellocchio e la Cherchi, andandolo a trovare nella sua casa milanese. La risposta di Fortini – Lettera agli amici di Piacenza (1961) – è un avvertimento sul rischio di integrazione degli operatori culturali negli ingranaggi del sistema capitalistico. Una preoccupazione forse precoce, ma la storia dei “Quaderni piacentini” dimostra che il rischio è stato evitato per l’anticonformismo costitutivo del gruppo redazionale – “Si può e si deve non essere noiosi. Con allegria.” dall’editoriale del n.1, marzo 1962, ancora in ciclostile – per la sua distanza dai partiti della sinistra, pur essendo essi i naturali interlocutori, per l’indipendenza proprietaria, il che significava un lavoro collettivo di ricerca abbonati, di distribuzione dei fascicoli, di responsabilità finanziaria (nei suoi anni migliori i “Quaderni piacentini” superarono le 13.000 copie a numero). La Cremona mette in luce come collettivo fosse il lavoro redazionale (oggi rimpianto in tempi di riunioni via zoom), come i direttori, a cui si aggiunse Goffredo Fofi (1937-2025) dal 1966, avessero funzioni diverse: Bellocchio più maieutica, la Cherchi di collegamento con i collaboratori, Fofi, già instancabile nel far spola tra Parigi e le varie città italiane, quella di assoldarne di nuovi, e come la dialettica verso l’esterno nascesse prima di tutto nelle discussioni redazionali, anche con l’abitudine di ospitare pareri diversi uno a fianco all’altro. I primi numeri avevano qualche interesse per la cultura locale, anche se la città di Piacenza rimase sempre estranea alla storia dei “Quaderni”.
La polemica fu il sale della rivista che, in posizione antitetica al Gruppo 63, amava agitare le acque della cultura italiana, allora alle prese con i primi effetti della società di massa. Celebri in questo senso due rubriche: “Il franco tiratore”, non firmata ma di pugno di Bellocchio, e “Libri da leggere e da non leggere”. Più avanti furono le critiche cinematografiche di Fofi, dove venivano menati fendenti al cinema presunto engagé, italiano e non solo, a tenere alto il livello della polemica. Erano naturalmente le rubriche più attese, lette e citate. A Fortini nel tempo si aggiungono altri “fratelli maggiori” come Sebastiano Timpanaro, Cesare Cases, Giovanni Giudici, Elvio Fachinelli, la sinologa Edoarda Masi, Renato Solmi, Giancarlo Majorino, tutti nati negli anni Venti. Appartenenti al decennio successivo sono Giovanni Jervis, Luca Baranelli, Francesco Ciafaloni, Bianca Beccalli, Sergio Bologna, Federico Stame, Michele Salvati, Giovanni Mottura, ancora più giovani Guido Viale e Luigi Bobbio, per citare le firme più ricorrenti.
Bellocchio ha sempre affermato che gli anni che prepararono il ‘68 furono i più stimolanti, i più ricchi di scoperte. Precoce è l’interesse verso le rivolte studentesche di Berkeley da parte di Renato Solmi che poi si sviluppano nella critica alla guerra al Vietnam e all’imperialismo americano. I conti col mondo sovietico erano già stati fatti dopo la rivolta ungherese del 1956 e se ne ritorna a parlare dopo che nel 1968 i carrarmati russi sfilano per le strade di Praga. Edoarda Masi indica nella rivoluzione culturale cinese una possibile via nuova per il marxismo dopo la crisi dell’URSS e le proteste studentesche in occidente, difendendo la posizione all’interno della rivista anche dopo che gli accordi Mao-Nixon del 1971 ne rovesciano la prospettiva politica. Il primo a fare marcia indietro sulla rivoluzione culturale e i suoi abbagli è Gianni Sofri, mentre la Masi terrà il punto negli anni a venire.
Franco Fortini, a metà degli anni Settanta, scrisse che i “Quaderni piacentini” scelsero o quantomeno accettarono di essere il veicolo del movimento studentesco. La Cremona smonta questa tesi dimostrando come molti materiali preparatori, di discussione, uscirono sui “Quaderni”, ma come la rivista abbia mantenuto una distanza critica dal movimento. Già nel 1967 sono notevolissimi gli articoli in morte di don Milani di Fortini, Giudici, Fachinelli, che ne riconoscono le stigmate di vero rivoluzionario. Nello stesso 1967 Bellocchio commenta le proteste degli studenti bolognesi contro la guerra in Vietnam: “Sono l’unica speranza che abbiamo di uscire dall’attuale merda atlantica e coesistenziale”. Sempre nel 1967 Giovanni Jervis riferisce di un convegno londinese sulle dialettiche della liberazione, davvero un incunabulo di quello che avverrà. Vi partecipano pensatori americani del dissenso come Carmichael e Sweezy, Gregory Bateson, i teorici dell’antipsichiatria come Ronald Laing e David Cooper, ma chi colpisce di più è Herbert Marcuse di cui la rivista pubblicherà una lunga intervista dal titolo È una mistificazione l’idea di rivoluzione? I teorici del ’68, e prima ancora della critica al capitalismo, all’imperialismo, sono più o meno tutti discussi sulle pagine della rivista: Wright Mills, Fanon, Reich, Horkheimer e Adorno, gli autori del marxismo critico e di quello eretico L’interesse della rivista verso il movimento studentesco è immediato, già dai fatti di Palazzo Campana, l’occupazione dell’università di Torino nell’autunno 1967 guidata da Viale e Luigi Bobbio di cui subito vengono ospitati gli interventi sui “Quaderni”, ma a Torino ci sono anche Fofi e Ciafaloni che si definisce “testimone critico e partecipe”. Gli studenti, rivoltandosi contro lo status quo, rompono la catena sociale, fa notare Carlo Donolo, e il testo teorico più noto e il vero manifesto del Sessantotto italiano, Contro l’università di Guido Viale, esce all’inizio del fatidico ’68 sul numero 33 dei “Quaderni”. È il momento della pars destruens: le università sono specchio di una società divisa in classi sociali che si autoperpetuano. L’elaborazione critica della rivista è tuttavia molto più sofisticata. Fachinelli scrive: “Ciò che sta dietro, per questi giovani (e sottolineo questi) è un’immagine o un fantasma di società che, mentre promette una sempre più completa liberazione del bisogno, nello stesso tempo minaccia una perdita dell’identità personale (…) La liberazione dal bisogno sembra anzi avere come sua condizione la rinuncia al desiderio”. Così come Ciafaloni ammonisce che l’incontro tra studenti e lavoratori rincorso dal ’68 francese e poi da noi, è una pia illusione, perché diversi sono gli interessi e gli operai non possono scavalcare il ruolo di rappresentanza del sindacato. Il biennio ’68-’69 è seguito molto da vicino dalla rivista, raccontato città per città, ma è di nuovo Donolo a stimolare la discussione: se lo studente è un tassello del sistema capitalistico, le sue proposte non possono limitarsi all’università ma devono estendersi all’intera società. Lo studente diviene quindi uno strumento di rivoluzione: è il bivio davanti al quale il Movimento si troverà nel giro di un paio d’anni. Ciafaloni e Donolo firmano insieme «Contro la falsa coscienza nel movimento studentesco» (luglio 1969) in cui bacchettano (con rammarico) gli studenti perché scambiano la contestazione al potere con la presa di potere. La ritengono una fuga in avanti che non corrisponde a mutamenti sociali non ancora avvenuti. In queste condizioni l’incontro tra studenti e operai non può accadere così come la parola “rivoluzione”, metafora del cambiamento, risuona troppo spesso a vuoto. La posizione della rivista è molto lucida ma forse troppo in anticipo rispetto alle trasformazioni della società messe in moto dal movimento studentesco, ma che avranno successive detonazioni, lungo tutto il decennio successivo, nella scuola, nella famiglia, nel mondo del lavoro. Un inevitabile sbocco del movimento è la rappresentanza politica: Il gruppo del Manifesto e Lotta Continua ne sono i primi esiti. Se col primo prevarrà una diffidenza reciproca che proseguirà negli anni, col secondo non mancheranno i punti di collegamento e per un periodo Bellocchio accetta di diventare, pur solo nominalmente, direttore responsabile di «Lotta continua». Gli articoli forse più interessanti di quegli anni sono quelli di Ciafaloni, “abruzzese della montagna”, ingegnere dell’ENI poi passato in editoria, prima in Boringhieri, poi in Einaudi. È lui a seguire le lotte operaie dell’autunno caldo 1969. Quel che succede in FIAT è l’epicentro dello scontro tra un capitalismo italiano impreparato di fronte alle lotte dei lavoratori e una classe operaia che preferisce delegare ai sindacati che scelgono gli accordi-quadro con la proprietà piuttosto che nuove forme di partecipazione della classe operaia alla vita aziendale. Ciafaloni auspica un sindacato che sia un luogo di avanguardia e di elaborazione di nuove forme di gestione del potere, anche se in quel torno di tempo viene approvato lo Statuto dei lavoratori (1970), approdo di venticinque anni di lotte sindacali ed è difficile pensare a un immediato rilancio da parte della classe operaia, peraltro non più uniforme come in passato dopo la grande immigrazione meridionale.
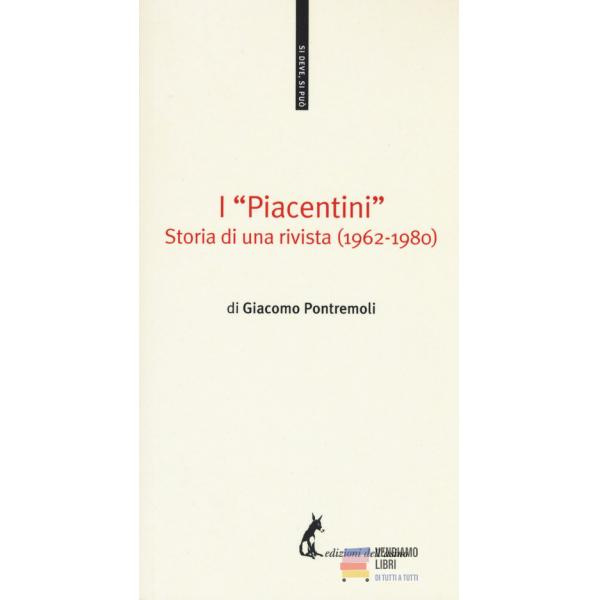
Al principio degli anni Settanta, in una società che comincia a ribollire, la rivista rileva come ogni conquista avvenga sulla spinta della dialettica politico-sindacale piuttosto che come elaborazione di nuove forme di convivenza sociale. La spinta movimentista si esaurisce attorno al 1972, mentre si consolida la forza di attrazione (anche intellettuale) del PCI di Berlinguer. I “Quaderni Piacentini” preferiscono allora ritagliarsi un ruolo di ‘coscienza critica’ della Nuova Sinistra senza davvero riuscirci, avverte la Cremona. Tuttavia, quel PCI oggi mitizzato, è ancora molto ‘grigio’ al suo interno, non ha davvero tagliato i legami con l’Unione Sovietica, è subalterno alle logiche di potere che portano al ‘compromesso storico’. Solo Michele Salvati, all’interno del gruppo redazionale, intravvede una possibilità riformista nel mutato assetto sociale e pensa a obiettivi a breve termine da realizzare dall’intera sinistra. Il più netto nella risposta è Ciafaloni che continua a considerare la DC prima di tutto un nemico di classe, un partito disinteressato alla maturazione dell’intera società. Federico Stame (poi notaio a Bologna) fa notare che la crescita della società civile sta in realtà svuotando i partiti dalla loro funzione di rappresentanza. I risultati del referendum sull’abrogazione del divorzio (1974) segnano anche la fine dell’obbedienza degli elettori ai partiti che li rappresentano. Anche Donolo concorda sul fatto che alcune delle battaglie sessantottine sono state vinte per i mutamenti sociali indotti dal sommovimento dell’intera società che ha prosciugato la classe operaia, mentre il cuore della società è ora rappresentato dal ceto medio. Al tempo stesso stanno cambiando la famiglia, i ruoli all’interno della coppia, la scuola, l’appartenenza ideologica, le istituzioni totali di cui il manicomio è l’emblema. Per Donolo, con le elezioni politiche del 1976, il quasi pareggio tra DC e PCI e l’avvio del percorso che dovrebbe portare all’incontro tra i due grandi partiti, manda in soffitto la lotta di classe, con la politica che riassorbe, istituzionalizzandole, tutte le spinte di cambiamento che arrivano dalla società. La politica torna nei partiti e i sindacati, fa notare Ciafaloni, si sono nel frattempo burocratizzati. Insomma, nella seconda della metà Settanta, le analisi sui “Quaderni piacentini” sono sempre molto lucide nel constatare che la società italiana sta vivendo una fase di ripiego dopo anni infuocati, ma la rivista stessa perde un po’ il suo ruolo di avanguardia nel dibattito politico e culturale.
Per la rivista, per i suoi direttori, occuparsi di cultura è un altro modo di fare politica. Gli articoli sui “Quaderni” (Baranelli, ad esempio) sono tra i primi ad accorgersi della mistificante sovrapposizione tra produzione e consumo culturale, un rischio in cui la “pedagogia” della cultura marxista italiana finiva per incappare. Ambivalente l’atteggiamento verso Pasolini di cui si apprezza la qualità dell’ispirazione, ma non si manca di far notare le smanie di intellettuale in carriera e la tentazione di arcadia. Scrive Fofi che per molti suoi film “ha scelto il mondo del passato”. C’è poi il tiro al bersaglio alle mode culturali: tra i “libri da non leggere” c’è “tutto Kerouac”. D’altra parte, il palato fine di Bellocchio suggerisce ai lettori i saggi letterari di Edmund Wilson come strumento per comprendere il XX secolo e come approccio antispecialistico alla cultura (sono pochi docenti universitari che scrivono sui “Quaderni”). Bellocchio dichiara: “siamo orfani, ma non figli di nessuno”, rivendicando la tradizione umanistica e le letture dei grandi romanzi dell’Otto-Novecento come strumento di interpretazione della società. Costante è la polemica con l’industria cultura ma sono rispettati i singoli come Volponi, Sereni, Giudici e Fortini che pure ci lavorano. Un errore, poi riconosciuto dai tre direttori, fu non cogliere la forza di novità di un romanzo come La vita agra (1962) di Luciano Biancardi, un’istantanea sulla mutazione antropologia degli italiani che avrà il valore di una profezia. Mai dismessa è la polemica contro il Gruppo 63, avanguardia dell’industria culturale.
In sede di bilancio la Cremona, che ha potuto giovarsi di una costante collaborazione da parte di Bellocchio, da lei sollecitato a riconsiderare quello che è stato fatto, ribadisce l’importanza dell’indipendenza economica della rivista, libera di esprimere le proprie opinioni senza rendere conto a nessuno (e non è quasi mai successo nella storia della nostra cultura). Non avere padroni è un punto di forza nell’interlocuzione col movimento studentesco. Inoltre, molto importante è la collaborazione tra intellettuali di due generazioni diverse, di differente estrazione sociale, di uomini e donne e, aggiungo, della naturale eleganza intellettuale di Bellocchio, per istinto fuori da ogni camarilla editoriale, culturale, con un’idea alta di cultura che non veniva enunciata ma praticata nei fatti. La Cremona conclude che fare una rivista è un’esperienza intellettuale collettiva che diviene una scelta politica. Una conclusione che vale per le migliori riviste cartacee o digitali di oggi, ma prima di tutto bisognerebbe discutere su che idea di mondo si ha in mente o perlomeno da che parte stare.
Nelle scorse settimane sono scomparsi Francesco Ciafaloni e Goffredo Fofi, grandi animatori dei “Quaderni piacentini” e di molte altre riviste negli anni a seguire. A loro va il nostro pensiero.