Un modo sudamericano di essere irreali / Ricardo Piglia & Juan Carlos Onetti
C’è un modo tutto sudamericano di essere irreali. O, se si vuole, di percepire l’irrealtà intorno a sé. (Ho il vago sospetto che questa constatazione, sempre che sia fornita di un qualche fondamento, si leghi in qualche modo al concetto di terra e territorio, così peculiare nell’America Latina).
In ogni caso oltre alle mitologiche genealogie di Garcia Marquez o agli spiriti di Allende, il Sudamerica ha fornito molti esempi di quello che è stato chiamato il genere ‘fantastico’, il quale nulla ha a che vedere con l’odierno fantasy, ma che piuttosto si apparenta (quasi come due cugini di primo grado) con quel famoso Realismo Magico che anche in Italia contò e forse conta ancora qualche rappresentante. Vari decenni orsono il Fantastico flirtò con una certa declinazione del cosiddetto Postmoderno; ora alcune prospettive un poco più ragionevoli si dipartono dalle postume lezioni di Francesco Orlando (edizione ‘rappezzata fra le rovine’) edite col titolo de Il soprannaturale in letteratura (Einaudi 2017) e, in misura più tenue, da The Weird and the Eerie di Mark Fisher (Minimum Fax 2018).
Non per niente Ricardo Piglia – autore delle intense lezioni che vanno sotto il titolo di Teoria della prosa (delle quali si è già trattato su Doppiozero) recentemente uscite in una bella edizione italiana per Wojtek, a cura di Federica Arnoldi e Alfredo Zucchi, traduzione di Loris Tassi – parla di una scuola del fantastico «del Rio de la Plata», cui apparterrebbero Borges e Cortázar, Arlt e Juan Carlos Onetti. L’opera di quest’ultimo fornisce appunto il ‘materiale’ su cui si esercita la teoria di Piglia, che inserisce invece nella sua cassetta degli attrezzi teorici soprattutto Deleuze e Guattari (il piano ‘letterario’ dei ‘mille’ dispiegati nel volume secondo di Capitalismo e schizofrenia), Auerbach (La tecnica di composizione della novella), Sklovskij e lo stesso Borges (L’arte narrativa e magia).
Non essendo un esperto di letteratura latino-americana né, lo ammetto, di quel Juan Carlos Onetti che ha tanta parte in questo libro, cercherò di darne un resoconto cercando di installarmi nelle prospettive critiche più generali che esso apre.
Il mondo e i personaggi di Onetti appaiono disgregati e sordidi, marginali e melanconici; nelle sue prose ci viene ammannito un mondo quasi gnostico di presenze umbratili, difettose, ambiguamente colpevoli e perverse così come le loro fantasticazioni, svolte spesso in camere d’albergo e aventi spesso prostitute come beatrici – dunque, tale mondo e tali personaggi sembrerebbero attagliarsi perfettamente a quella poetica sudamericana dell’irrealtà cui accennavo poco sopra.
Eppure – benché l’autore non si faccia scrupolo di usare il termine – le lezioni di Piglia non parlano del genere fantastico, né hanno l’irrealtà come loro punto di mira. Esse parlano della nouvelle – il termine, non senza ragione come si vedrà, viene usato sempre in francese – un genere forse absolument moderne che ha in Henry James il suo autore eponimo e, io credo, il suo maestro inarrivabile.
Capitava spesso a James di avere dei problemi con i redattori delle riviste alle quali mandava i suoi scritti. Essi erano spesso troppo corti o troppo lunghi per rientrare nel canonico numero di pagine con cui si definiva, con pragmatica e gordiana definizione di genere, il romanzo, il racconto o la novella. In questa incongruità e difficoltà di incasellamento – è un romanzo breve? è un racconto lungo? – si nasconde un indizio non secondario per definire la forma della nouvelle. Per Deleuze, che Piglia segue, il racconto risponde alla domanda: che cosa accadrà (futuro)? Nel romanzo, invece, l’interrogativo è: cosa sta accadendo, cosa succede (presente)?
La nouvelle risponde invece all’interrogativo: che cosa è accaduto? Tipica posizione fitzgeraldiana, esemplarmente esposta in The crack-up: che cosa è successo perché si arrivasse fin qui? Cosa mi è successo per cui sono arrivato fino a questo punto?
Naturalmente sarebbe erroneo, Deleuze ci avverte, prendere le tre dimensioni temporali come meccanico punto di riferimento per la definizione dei tre generi. Il romanzo, ad esempio, è attraversato da linee di futuro e di passato. Viceversa l’elemento dirimente perché si dia nouvelle è la presenza in essa di un segreto/mistero. Un nucleo insolubile, dall’ingombrante presenza eppure apparentemente ininterrogabile, che sta al cuore della nouvelle e che ne rappresenta il centro di gravitazione. Prendiamo un esempio arcinoto: il Giro di vite di James. Secondo le letture più correnti, il mistero irrisolto di questo testo è il seguente: ha davvero l’istitutrice visto i fantasmi dei due ‘corruttori’ degli incantevoli e inquietanti bambini a lei affidati? Scavando più in profondità, come fece ad esempio il succitato Orlando, il ‘vero’ segreto del Giro riguarderebbe la natura dei rapporti tra i due domestici adulti e i bambini stessi; ci sarebbe dunque un indicibile alla base del racconto, storicamente individuabile come il mistero/tabù della sessualità infantile, e dei suoi rapporti con quella adulta, sui quali di lì a poco Sigmund Freud avrebbe squarciato il velo.
Ma il punto non cambia. C’è un mistero, e c’è un narratore – su questo anche Piglia insiste – sostanzialmente inattendibile, come la narratrice diegetica del Giro di James, sulla quale grava il sospetto di ipersensibilità, ‘isteria’ ecc. Anche il tipico narratore di Onetti è inattendibile: il confine tra le sue fantasticazioni e la ‘realtà’ è confuso, convoluto, cangiante. In Il volto della disgrazia, è impossibile sapere non solo se il protagonista-narratore ha veramente ucciso la bambina, crimine per cui si fa arrestare, ma anche se abbia avuto al di fuori delle sue proiezioni desideranti dei rapporti sessuali con lei. Eppure c’è un punto della realtà, ci dice Piglia, al quale le fantasticazioni si saldano ad essa (nel caso in questione, il suicidio del fratello dell’io narrante). Infatti il mistero che forma la quidditas della nouvelle non è irrelato: ha sempre dei rapporti (spesso nella forma del «patteggiamento») sia con il narratore, sia col lettore sia, infine, con i ‘fatti’ classificabili sotto l’etichetta del verosimile storico.
Piglia oppone giustamente, sulle orme di Deleuze, la nouvelle al racconto poliziesco, che ha al suo centro un enigma che deve essere, e che immancabilmente viene, decrittato. Il racconto poliziesco, potremmo osservare noi, è figlio del clima positivistico: tutti i misteri possono essere risolti, non esistono enigmi insolubili. In questo senso uno Sherlock Holmes è il nuovo dandy-superuomo dell’età della scienza e della tecnica. Il racconto poliziesco ingloba i brividi e la suspence, insomma ‘gli effetti’ dei racconti del mistero ma vi aggiunge la rassicurazione finale: la realtà è sempre intellegibile, basta avere i reagenti giusti e i giusti strumenti di analisi.
Qualcuno potrebbe chiedersi in che cosa il procedimento letterario della nouvelle differisca non solo dalla narrativa diciamo modernistica, in cui i nessi causali tra i fatti non sono sempre matematicamente chiariti, ma anche dal realismo non volgare, che programmaticamente non riempie tutti gli inevitabili ‘buchi’ della narrazione. Diciamo che la nouvelle porta all’estremo l’instabilità dei nessi causali tra gli eventi – ciò che, ricorda giustamente Piglia, fa vacillare paurosamente il concetto stesso di narrazione – concentrandoli sotto l’ossessivo monoscopio di una ‘prima persona’ (la quale sulla pagina può anche essere un ‘egli’, ma focalizzato come se fosse in prima).
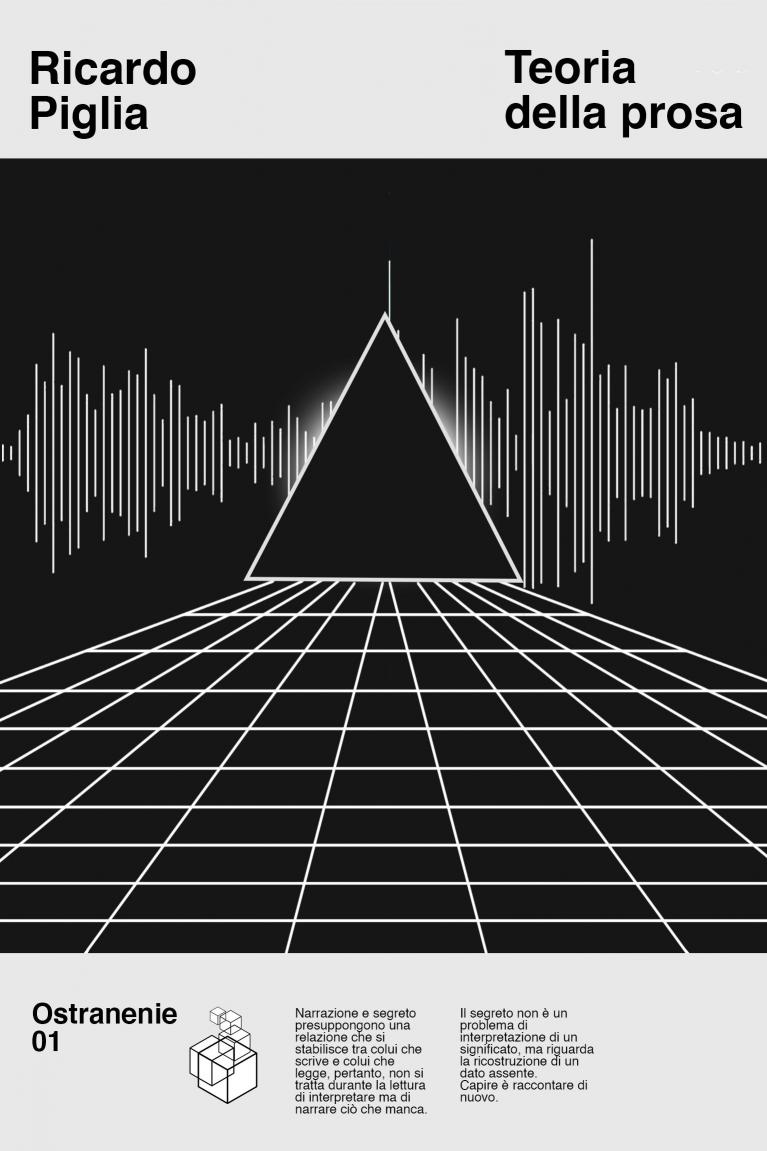
Piglia dichiara che in Onetti vi sono sempre due storie compresenti: una che risponde per dir così al principio di realtà e l’altra a quello del piacere, del desiderio. Questa storia segreta, peraltro, è incomunicabile. Anche se viene rivelata, il destinatario non ascolta. Le due non stanno in rapporto causale tra di loro, sono solo congiunte da un istante, da un gesto, da un’occasione.
Come dotata di una sua radioattività, la storia segreta emana dei segni, che però il critico definisce segni in sospeso. Il loro destino è restare sospesi, mentre ad esempio così non avviene in Proust. È sempre Deleuze a dimostrare, in un suo splendido saggio del 1964 (Marcel Proust et le signes, appunto) che il romanzo di Marcel è la storia di un apprendimento dell’arte di decifrare i segni. Si avverte dapprima sia nella mondanità che nell’amore un segreto, una verità nascosta da decifrare; tale verità muta nel tempo: ma è possibile, tramite il duro apprentissage dell’esperienza, arrivare a scoprirla.
Come si capirà, il particolare genere della nouvelle avrà il problema della conclusione. Eppure, facendo di due storie una sola storia, essa si chiude, è conclusa allo stesso modo del «fatto di cronaca» che Barthes contrappone al pezzo d’informazione (Structure du fait divers, in Essais critiques, 1964). Benché all’interno di tale fatto si ravvisi una «causalità perturbata», esso viene lasciato sussistere come tale, ed è la sua ‘stranezza’ a costituirne l’elemento interessante. Ma ciò che differenzia la letteratura dal giornalismo è propriamente la posizione del narratore rispetto alla storia, che Piglia definisce «laterale».
Il narratore, spesso estraneo alla vicenda che racconta, ne è però per così dire contagiato, vi aderisce entusiasta, ci costruisce sopra ipotesi, senza mai però venirne completamente a capo. Può essere in preda al delirio o raziocinante; a volte il suo sapere è confortato o ampliato da «aiutanti», termine preso dalla narratologia ma che a me ha fatto pensare subito a Kafka (si veda almeno Il Castello). Predisporre un io narrante disinformato, laterale e pur partecipe, o addirittura doppio (Holmes/Watson) sono tutti modi, secondo Piglia, di superare la struttura demiurgica del narratore ‘onnisciente’.
Andando in cerca di una definizione di narrazione, e riprendendo quella di Deleuze (nouvelle = cosa è successo?) l’autore dichiara che in letteratura importano di più le conseguenze, gli «effetti» dei fatti, che non i fatti stessi. Citando Onetti stesso – Gli addii, testo che Piglia considera un capolavoro assoluto del Novecento –: «... gli effetti sono infinitamente più importanti delle cause, e che queste possono essere sostituite, perfezionate, dimenticate». Sùbito viene in mente Kafka, che ha portato al suo apice tale possibilità: nulla ci viene detto sul perché e sul come Gregor Samsa viene trasformato in insetto; ciò su cui l’autore fa aggio per non farci staccare dal racconto sono appunto gli effetti di tale metamorfosi. Stesso discorso si può fare con Il processo. Nulla ci viene detto su chi ha calunniato Joseph K. e perché. La storia parte da questa semplice inspiegata constatazione.
Ma a proposito della ‘perturbazione’ del concetto di causa il lettore italiano potrebbe ricordarsi del leibnizianesimo esploso di un Gadda, in cui le «cause» sono eminentemente plurali e si attorcigliano nel celeberrimo «gliuommero»: ma sono pur sempre indagabili e ravvisabili, anche se ci vuole, per questa bisogna, nientemeno che un Ingravallo! Sarà forse perché Carlo Emilio si apparenta maggiormente col binomio Joyce-Woolf, che è a propria volta divergente da quello James-Conrad (cui Piglia aggiunge risalendo all’indietro un certo Poe e ‘in avanti’, un certo Faulkner) che pure si pongono entrambi sul fronte del rinnovamento della narrazione.
In effetti, che si sia su un brigantino in bonaccia senza acqua e galletta, o in un salotto pieno di boiseries e poltrone comodissime, in James e Conrad i problemi sono molto simili. Chi ha fatto cosa? E perché? E a chi? X è colpevole? X esiste? E via dicendo.
Suggestivamente, in queste lezioni Piglia punta più ad individuare il modo di costruzione dei testi affrontati che la loro interpretazione, avvicinandosi così al modo con cui gli scrittori leggono altri scrittori (forse anche perché lui stesso scrittore ‘di primo grado’). Le Lezioni di letteratura di Nabokov sono in questo senso esemplari. Anche gli esercizi dati agli studenti riguardano l’‘estrazione’ di una delle storie contenute nel possibile finzionale dei testi di Onetti, fino ad arrivare a teorizzare una ‘lettura finzionale’ che possa rendere letterari anche testi che non lo sarebbero per loro natura. Tale estrazione, come nella novellistica araba delle Mille e una notte, è potenzialmente infinita (Auerbach). Dunque, anche per storie unitarie, si dovrà parlare in questi casi di narrazioni al plurale: ve ne è sempre più d’una, di storie o mozziconi di storie, polloni o embrioni di storie, all’interno di ciò che sembra monoscopico...
Piglia diffida dei principali approcci critici dominanti negli Anni Novanta in cui scriveva: quello linguistico, quello psicanalitico o quello storico-sociologico. Ambiguo il suo rapporto col post-strutturalismo, ad es. con Deleuze che cita negativamente a p. 104 ma dal quale trae la pietra d’angolo della sua riflessione, e cioè il segreto come forma della nouvelle. E qui si tratterà di prendere un po’ il toro per le corna. La semiotica del segreto si lega a particolari contingenze, che si possono definire a partire da James. Il segreto circola in determinati luoghi, ovviamente, soprattutto in case o nella Casa (qui Onetti si accorda col maestro riconosciuto).
Il segreto si lega a determinati oggetti (anche qui siamo in area jamesiana, se le ‘lettere’ degli Addii possono rispondere a i papers di Aspern). Il segreto si lega a determinati enunciati, che spesso sono in James iscritti a caratteri cubitali sulla porta stessa del testo, cioè nel titolo: Giro di vite, La bestia nella giungla, La fonte sacra, senza dimenticare La cifra nel tappeto, racconto ‘meta’ in cui James pare riflettere su alcuni suoi stessi procedimenti. In queste immagini o metafore si pretende essere nascosta la chiave per scoprire ‘il segreto del segreto’: ma chi cerca di decifrarle va spesso incontro a contingenze nefaste. Poiché il segreto va trattato col dovuto rispetto, come il sogno secondo il testo di Curi che recensivamo, qualche mese fa, in questa stessa sede. La ‘bestia nella giungla’ è ad esempio la tragedia di chi prende alla lettera l’enunciato del segreto; la Cifra racconta la patetica storia di chi crede sia stato un altro a scoprire il segreto medesimo; con sommo e finale virtuosismo, La fonte sacra sancisce addirittura l’inesistenza attiva del segreto stesso, almeno secondo le somme tirate dal narratore in prima persona che però – come si è detto – è inaffidabile per definizione.
Si direbbe che il segreto che governa la nouvelle sia una fonte irradiante di vita e di linguaggio, che però deve rimanere nascosta per riuscire a darsi, a vivere: o esprimersi, appunto, in maniera cifrata. La nouvelle coglie il linguaggio in un’origine massimamente implicata, ma ad altissimo voltaggio. Poi, è questione di comunicazione, di linee di comunicazione, di passaggi spesso molecolari tra un’emittente e un ricevente. Questa linea del segreto è in effetti un modo per risollevare la narrazione dallo scacco in cui essa sembra essere caduta almeno dall’età post-flaubertiana. Jacques Rancière, nel suo Politique de la littérature (2007), ha descritto Borges riassumere sotto l’etichetta di ‘mal francese’ quei due fenomeni, strettamente intrecciati, con cui la democratizzazione della letteratura ha portato alla distruzione della narrazione classique. Da un lato, la perdita della gerarchia tra gli oggetti, che spinge Flaubert a fornire accuratissime descrizioni di arredamenti Kitsch o di angoli squallidi. Dall’altro, la decadenza dell’eroe, che diventa un personaggio irresoluto e quasi soffocato, appunto, dalla marea montante degli oggetti che reclamano, egualitaristicamente, pari dignità di rappresentazione.
La scuola del segreto, che fa vacillare le cause ma non le abolisce, si scava così la sua strana, sotterranea e autonoma via in prosa, differenziandosi, certo, dall’invasione delle cose flaubert-joyciana, ma anche dalla sempiterna mise en abyme e dai fantasmi di Borges e dei suoi sodali costruttori di labirinti in miniatura.







