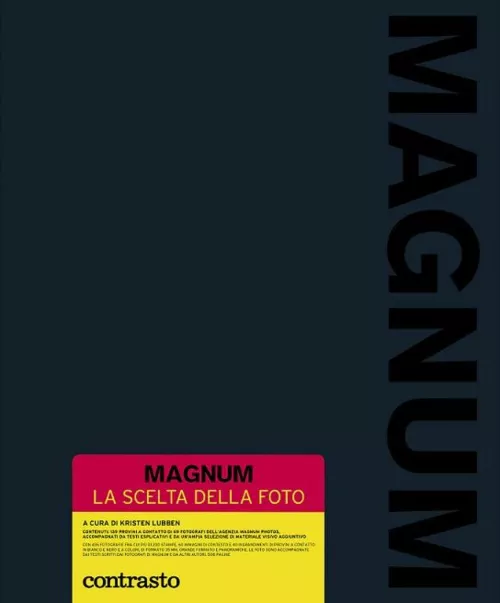Magnum. La scelta della foto
Riproponiamo questo articolo in occasione della mostra Magnum Contact Sheets presso il Forte di Bard che aprirà al pubblico in anteprima mondiale a partire dal 21 giugno sino al 10 novembre 2013.
Henri Cartier-Bresson è seduto su uno sgabello vicino a un tavolo, su cui sono accumulate in modo disordinato delle cartelline. Sta osservando con la lente d’ingrandimento un rettangolo: provini fotografici. Lo fa con la posa di un collezionista; meglio: di un investigatore alla ricerca delle prove del delitto. L’immagine è stata scattata nel 1959 da un altro celebre fotografo, René Burri, negli uffici della Magnum a New York. Cartier-Bresson sta svolgendo il suo lavoro: individuare tra gli scatti quello che merita di essere stampato, e quindi riprodotto su un giornale. Il rettangolo che tiene tra le mani, tra pollice e palmo, è una stampa a grandezza naturale di spezzoni di un rullo o di una sequenza di negativi, e rappresenta secondo Kristen Lubben, curatore di Magnum. La scelta della foto (Contrasto), il primo sguardo che il fotografo getta su ciò che è riuscito a catturare con la sua macchina.
Strana definizione. Siamo infatti abituati a pensare che il primo sguardo, quello che conta, sia lo scatto, ovvero l’“istante decisivo”. No, il primo sguardo è piuttosto quello in cui il fotografo osserva i propri scatti, così come vengono su carta, in piccolo; e subito cerchia di rosso, o giallo, oppure appone una x, per segnalare l’immagine giusta da trasformare in una vera fotografia. Tutto il resto finisce nel buio della scatola, dentro un raccoglitore, o ancora, come nel caso di Robert Capa, incollato su un quaderno con i riferimenti: luogo, data, soggetto. Nel 1939 lo stesso Cartier-Bresson tagliò i suoi negativi “come se si stesse tagliando le unghie”, e conservò del suo lavoro sino a quell’epoca solo immagini singole e sequenze valutate buone. A posteriori spiegò che una mostra fotografica, o un libro, sono come un invito a cena, ed è buona norma non far intingere il naso ai commensali nei tegami e nelle padelle, e ancora meno nel bidone della spazzatura. Mettere il naso nelle cucine di quei cuochi che sono i fotografi è invece proprio lo scopo che si prefigge questo libro dedicato alla loro celebre associazione, Magnum, fondata nel 1947 da Capa, Cartier-Bresson, Chim e Rodger, anche se c’è da dire subito che la pattumiera, ovvero lo scarto vero, nel libro non c’è, perché il curatore e i suoi collaboratori si sono premuniti di accompagnarci in visita nelle retrovie del ristorante dopo che i cuochi avevano messo tutto ben in ordine. Tuttavia molte cose interessanti vengono fuori dal volume.
La prima cosa che colpisce chi guarda è quanto sia difficile scegliere una bella foto. Ce ne sono troppe. Infatti tanti dei provini presentati, che coprono un periodo che va dal 1930 ai giorni nostri (oggi, con il digitale, i provini non esistono più), svelano che la foto giusta, quella che poi diventerà memorabile, è stata individuata dal fotografo (o dall’agenzia) a colpo d’occhio, seguendo l’intuizione piuttosto che un vero metodo. Provare per credere. Armati di lente d’ingrandimento provate a individuare l’immagine giusta tra quelle che René Burri ha scattato a Che Guevara nel 1963 a Cuba. Se non ci fossero quelle riquadrate in rosso, e stampate lì vicino in formato grande, sarebbe davvero difficile dire qual è lo scatto giusto. Lo diventa solo nell’occhio del fotografo stesso, il quale, com’è evidente dalle schede che accompagnano i provini, non è quasi mai cosciente di quello che fa. Va a caso, sia quando scatta sia quando sceglie; eppure non è mai un caso che la foto che decide di stampare, e far riprodurre, sia proprio la giusta. Per forza, vien fatto di pensare, sono tutti bravissimi fotografi! Ma non è solo questo. Il caso agisce in modo straordinario nel definire lo statuto del bello in questi provini. Come? Facendo di necessità virtù.
Prendiamo l’esempio di Paolo Pellegrin, grande reporter di guerra. Mentre inquadra un funerale serbo nel Kosovo (2000) si fa guidare, come racconta, dal “già visto”: “Mi torna in mente un quadro di Brughel”. Così accade per molte altre foto scelte: la memoria del passato: quadri, stampe, altre foto. Ma non è sempre così. Capa segue la strada opposta. Sta a ridosso della scena che vuol cogliere: “Se le tue fotografie non sono abbastanza buone, significa che non ti sei avvicinato abbastanza”. Così i suoi scatti di guerra, in Spagna, e anche in Normandia. Sebbene la sua foto più celebre, il soldato del D-day che nuota nell’acqua, sia il risultato di un errore di sviluppo della pellicola seppure compiuto da altri. Questo nel passato; oggi, nel mondo del “tutto-visto”, è davvero difficile cercare l’originalità del gesto chiesta da Capa ai propri scatti. La foto probabilmente è già nell’occhio del fotografo prima ancora dello scatto.
Alla fine del libro ci si conferma in una convinzione: la fotografia è un’arte del tempo. Lo dimostra questo straordinario libro che ci permette di guardare – seppur dal buco della serratura – il laboratorio segreto di tanti grandi fotografi, di essere, a nostra volta, dei voyeur. Dunque, c’è il primo sguardo, in macchina, come dice qualcuno, nonostante tutto; poi, il secondo sguardo davanti ai provini, che è il primo per chi sceglie il proprio lavoro; e intanto il tempo è trascorso. Quindi c’è un terzo sguardo, che si produce anche a distanza di anni, che, se posso dirlo, è quello che m’interessa di più. L’immagine più nota di Thomas Hoepker ritrae cinque giovani che conversano amabilmente a New York davanti al fiume, mentre lontano nel cielo si staglia la nube delle Torri in fiamme. La diapositiva ha riposato per cinque anni in una scatola, poi un curatore l’ha tirata fuori in occasione di una mostra. Con il tempo quell’immagine “blasfema” è diventata significativa.
Sono convinto che si potrebbe estrarre da questo libro, che contiene migliaia di foto in potenza, almeno cento immagini significative prodotte, non solo dal primo o dal secondo sguardo dell’autore stesso, ma dal nostro sguardo, che vive nel tempo e segna il tempo afferrando ciò che è stato scartato per allestire un buon pranzo. Serve guardare nella pattumiera, se c’è ancora, come del resto sanno i bravi detective. Il delitto, se c’è stato, lo si scopre solo così.
Una versione ridotta di questo articolo è uscito su “La Stampa”.