Speciale
Traduzioni, emozioni e Giappone
Oggi al Salone del Libro di Torino, nell'ambito dell'AutoreInvisibile, ad Antonietta Pastore viene conferito il Premio di Traduzione “Giovanni, Emma e Luisa Enriques”. Ecco il testo della sua lectio magistralis.
Il mio interesse per il Giappone, la sua cultura e la sua letteratura è nato tardi, quando, all’età di ventotto anni, vi sono andata per la prima volta. Era il 1974. Nel ‘71 avevo conosciuto a Ginevra, dove frequentavo la Facoltà di Scienze dell’Educazione, un ragazzo giapponese, e dopo la laurea, l’anno seguente, ero andata a vivere con lui a Parigi.
Naturalmente avevo provato curiosità per il suo paese fin dall’inizio della nostra relazione, ma bisogna considerare che a quell’epoca il Giappone appariva agli europei come un mondo lontano e difficilmente raggiungibile, e quel poco che se ne sapeva era per lo più una serie di stereotipi. Avrei potuto soddisfare la mia curiosità se avessi avuto accesso a traduzioni di opere letterarie giapponesi – opere che sarei stata felice di leggere, considerata la mia passione per la letteratura di ogni tempo e paese –, ma nelle librerie di Parigi si trovavano pochissime traduzioni francesi di libri giapponesi – alcune opere di Mishima Yukio e di Kawabata Yasunari –, né la ricerca di traduzioni italiane che feci in alcune librerie di Torino diede risultati migliori.
All’epoca non sapevo che esistevano già molte traduzioni in inglese, ma anche l’avessi saputo, la mia conoscenza di questa lingua, che avevo studiato alle medie e al ginnasio, non sarebbe stata sufficiente a leggere opere di letteratura. Quanto ai film giapponesi, presso la Cinémathèque Nationale di Parigi ne venivano proiettati due o tre l’anno, non di più. Di conseguenza mi ero rassegnata all’idea che per conoscere il Giappone dovevo andarci di persona, vederne i paesaggi, le città, le case, conoscerne la gente, respirarne l’atmosfera.
L’occasione si presentò nel ’74, quando il mio compagno e io ci sposammo e poco dopo ci recammo in Giappone, dove trascorremmo circa un mese. Un soggiorno durante il quale il fascino che il paese esercitò su di me fu tale che iniziai a nutrire il desiderio di impararne la lingua e possibilmente, in un futuro non troppo lontano, di viverci per qualche tempo. Ne parlai a mio marito, che ne fu felice. Così prima di ripartire comprai un paio di manuali di lingua giapponese per stranieri, e tornata a Parigi mi misi a studiare con impegno.
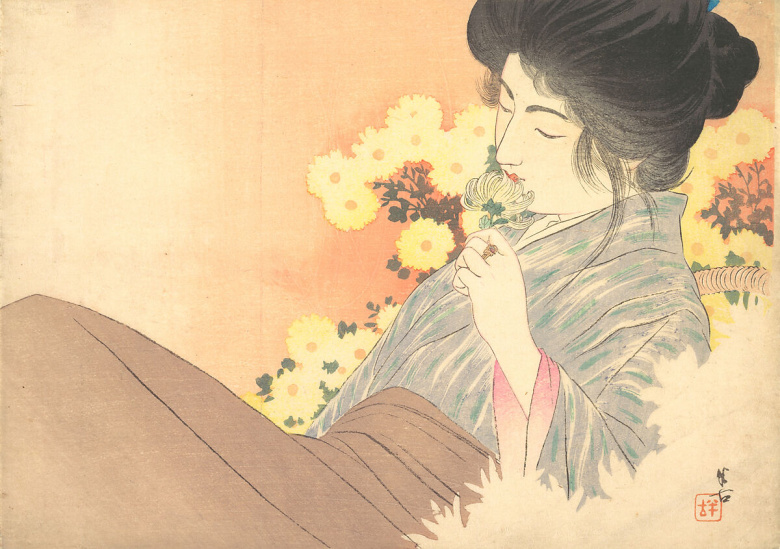
Quando il nostro progetto di trasferirci si realizzò, nella primavera del ’77, avevo assimilato i fondamenti della grammatica giapponese, ma in questa lingua sapevo dire solo una dozzina di parole.
Durante i primi mesi che trascorsi in Giappone, il mio rapporto con il paese fu idilliaco. Essendo ospite dei miei suoceri, che vivevano a Osaka, il mio primo approccio avvenne nell’ambiente tranquillo e sereno della loro casa.
I tre anni dedicati allo studio della grammatica si rivelarono subito utili ai fini di una basilare comunicazione, ma devo soprattutto a mia suocera, alle ore trascorse con lei, se in qualche mese riuscii a esprimermi sufficientemente bene per sostenere una semplice conversazione di argomento quotidiano. La possibilità di imparare a leggere il giapponese però era ancora lontana dai miei pensieri, e lo sarebbe stata ancora per molti anni. Mi sembrava un’impresa improba, richiedente uno sforzo eccessivo e tutto sommato non indispensabile, e mi ero rassegnata a vivere in Giappone come un’analfabeta.
L’idillio con la società giapponese fu di breve durata. Nell’autunno del ’77 mio marito e io ci trasferimmo in una vecchia casa in campagna, ma già nel mese di giugno io avevo iniziato a lavorare come insegnante di francese e italiano in una importante scuola di lingue di Osaka. I pochi giapponesi con cui avessi dei rapporti erano i miei studenti, gli impiegati della scuola o qualche vicino di casa nel villaggio dove abitavo, ma con nessuno di loro riuscivo a creare una relazione che andasse al di là di quella formale imposta dai nostri rispettivi ruoli.
Tutti erano sempre gentili, sempre sorridenti, ma percepivo fra me e loro la presenza di una barriera che mi impediva di capire cosa ci fosse dietro la facciata di impeccabile cortesia, dietro i loro sorrisi, i loro inchini. Poco per volta incominciai a considerare i giapponesi rigidi, incapaci di empatia, addirittura anaffettivi. Nei negozi, la gentilezza dei commessi mi pareva falsa, la formalità che caratterizzava ogni rapporto mi era diventata insopportabile. A un anno dal mio arrivo in Giappone non avevo amici fra loro, con la sola eccezione della moglie di un collega inglese. Quanto ai miei suoceri, che mi avevano accolto con affetto fin dall’inizio, li consideravo persone fuori dal comune.

Invece con i colleghi della scuola di lingue, quasi tutti inglesi o americani, avevo subito stabilito relazioni amichevoli, e questo, unitamente alla lettura quotidiana del Mainichi Daily News – un quotidiano giapponese in lingua inglese, l’unico modo che avessi di tenermi informata su quel che succedeva nel resto del mondo – mi permise di migliorare in poco tempo la mia capacità di capire, parlare e leggere l’inglese. Cosa che si rivelò presto di estrema utilità, perché avendo esaurito in qualche mese la scorta di libri italiani e francesi che avevo portato con me, potei iniziare a leggere le opere della letteratura anglosassone classica e contemporanea in lingua originale.
Chi è stato in Giappone, sa che le librerie sono per lo più molto grandi, occupano diversi piani di un palazzo e nei loro vari settori offrono una scelta vastissima. In quella di Osaka che frequentavo il settore di opere in lingua straniera originale – essenzialmente inglesi, fatta eccezione per qualche classico moderno francese che avevo già letto e qualche opera tedesca – era molto vasto e mi permise, col passare dei mesi, di leggere i più importanti scrittori della letteratura anglosassone moderna e contemporanea.
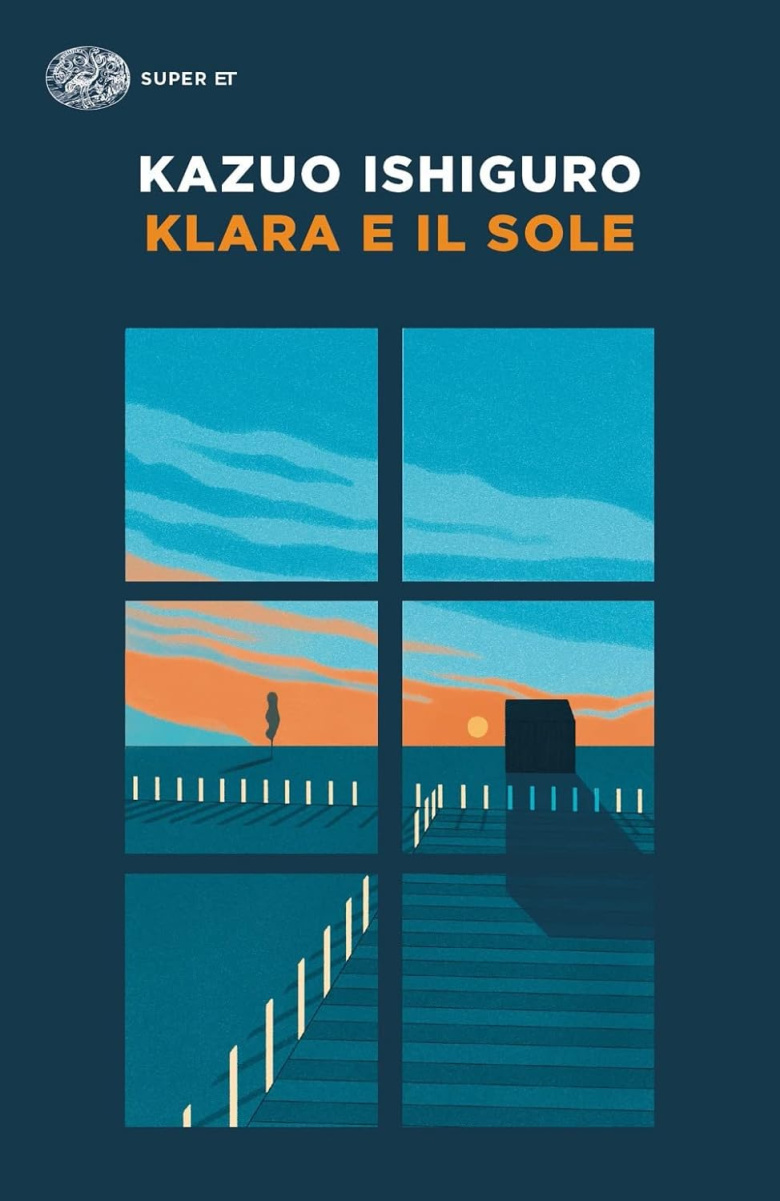
Un giorno, nella primavera del ’78, per puro caso passai dal settore dov’ero solita cercare le mie letture a quello della narrativa giapponese tradotta in inglese, settore del quale non avevo nemmeno immaginato l’esistenza.
Rimasi stupita nel vedere che opere di autori di cui non conoscevo nemmeno il nome riempivano decine di scaffali! Incuriosita, presi in mano uno spesso volume: Io sono un gatto, di Natsume Soseki. Iniziai a leggere – nelle librerie giapponesi si può passare la giornata a leggere le opere esposte senza che nessun commesso venga a sollevare obiezioni – e dopo poche pagine, sedotta, decisi di comprarlo. Insieme a un paio di romanzi di altri autori, ora non ricordo quali. Da quel giorno, per mesi e mesi non lessi altro che narrativa giapponese in traduzione inglese, scoprendo opere di meravigliosa sensibilità, profondità di pensiero e sentimenti, immenso potere emotivo... era come entrare in un mondo nuovo, del quale non avevo mai sospettato l’esistenza.
Dopo un anno, avevo letto in inglese diverse opere di Kawabata, Tanizaki, Mishima e altri scrittori ancora, oltre a tutte quelle di Natsume Soseki, il primo grande scrittore della narrativa giapponese moderna. Finché un giorno, terminata la lettura di un romanzo di quest’ultimo, Kokoro, che mi aveva particolarmente emozionato, rimasi folgorata da un pensiero: se Soseki e tanti altri autori erano stati capaci di raccontare le passioni umane – amore, odio, gelosia, rimorso – con tanta intensità, queste passioni dovevano necessariamente esistere, nel cuore dei giapponesi. Perché la letteratura si nutre dei sentimenti delle persone, la creatività nasce dall’esperienza vissuta, dalla capacità di capire le emozioni altrui e di condividerle. Di conseguenza, non ero forse io che non riuscivo a vederle, nelle persone fra le quali vivevo? Non ero forse io a restare al di qua della barriera, incapace di cogliere i segnali che mi venivano inviati e fare un passo avanti? Di comprendere modi espressivi diversi da quelli che avevo sempre considerato normali? Fu uno shock, e al tempo stesso un’illuminazione.
Da quel giorno, mi sforzai di riconsiderare i miei criteri di valutazione, e di non giudicare i giapponesi secondo quelli che avevo sempre ritenuto giusti. Iniziai ad ammettere che la nozione stessa di buon senso varia da una cultura all’altra, e che io, fino ad allora, mi ero sempre attenuta a quella interiorizzata vivendo nella civiltà europea. Riuscii così a capire che ci sono tante maniere di esprimere le emozioni, che un silenzio può valere quanto una parola, che la schiettezza non è sempre auspicabile... e che c’è modo e modo di inchinarsi, di sorridere... Così il mio rapporto con i giapponesi incominciò a cambiare, poco per volta riuscii ad apprezzarne la compagnia e ad amarne la cultura, a farmi degli amici fra loro, a dare il giusto valore ai lati positivi della loro società e a sopportare quelli negativi, che pure ci sono, ovviamente, come in ogni società.

Questa svolta, cruciale nella mia vita, la devo a quei traduttori che mi hanno permesso di leggere le opere della letteratura giapponese in lingua inglese, e me ne hanno saputo trasmettere tutta l’intensità emotiva. Senza di loro, probabilmente mi sarei irrigidita nella mia diffidenza e non avrei mai capito nulla, o ben poco, di un paese dove ho vissuto sedici anni. Non avrei imparato ad apprezzare persone che, al di là di una facciata in apparenza impenetrabile, mi hanno dato prova di grande calore e umanità.
Fu solo molti anni dopo, tuttavia, che provai il bisogno di imparare a leggere il giapponese.
Devo confessare qui qualcosa di cui non vado fiera. Fino all’estate dell’ ’85, quando mi separai da mio marito, ogni volta che avevo bisogno di leggere qualcosa – documenti, notifiche, avvisi – facevo ricorso a lui. Per me, che a Parigi avevo partecipato alle manifestazioni femministe degli anni Settanta, era quantomeno deplorevole. Dopo la separazione però dovetti fare di necessità virtù, e mi misi finalmente a studiare quei benedetti ideogrammi. Mi ci volle un anno per essere finalmente in grado di decifrare un testo semplice, e altri due per riuscire a leggere un’opera letteraria. La prima fu Nel segno della pecora, di Murakami Haruki, un romanzo del quale si era parlato molto fra i miei studenti dell’università di Osaka, dove insegnavo dall’82. Lo scelsi perché era scritto nel linguaggio semplice caratteristico di Murakami e perché il titolo mi attirava. Ne fui conquistata!

Dopo aver letto una mezza dozzina di romanzi giapponesi in lingua originale, cominciai a nutrire un desiderio: perché non provare a tradurne uno in italiano? Alla fine degli anni Ottanta, in Italia lo stato dell’arte, riguardo alla traduzione della letteratura giapponese, era migliorato rispetto al decennio precedente, ma le traduzioni per lo più venivano fatte servendosi dell’inglese come lingua ponte. Ora bisogna sapere che i più noti traduttori di letteratura giapponese in inglese, per lo più americani, sono sì bravissimi ma, proprio perché posseggono una straordinaria padronanza del linguaggio letterario, tendono ad allontanarsi molto dall’originale; cosa che entro certi limiti non è un difetto, tuttavia una versione italiana di una loro traduzione rischia di non rispettare più né lo stile né lo spirito dell’autore.
Allora perché i lettori italiani se ne dovevano accontentare? Chiesi a Kazuko, una cara amica, di consigliarmi un romanzo da cui iniziare, e lei mi suggerì L’uomo scatola di Abe Kobo, un autore contemporaneo. Il libro mi affascinò fin dalle prime pagine. Misi un anno a tradurlo, un tempo che ora mi pare lunghissimo, poi proposi la traduzione a un’amica torinese, Paola Servetto, che lavorava alla Utet. Lei a sua volta si incaricò di presentarla ad altri editori, e per finire fu Einaudi, che aveva già acquisito in precedenza i diritti del libro, a pubblicarla. Così, grazie a Paolo Collo, all’epoca redattore Einaudi nel settore della letteratura straniera, iniziò la mia carriera di traduttrice. L’uomo scatola uscì nel ’91.
Da allora sono passati quasi trentacinque anni, durante i quali ho tradotto una cinquantina di opere letterarie giapponesi.
A questo punto devo affrontare un problema inevitabile, perché ormai riguarda la maggior parte delle attività intellettuali, e anche inquietante. Inquietante non per il mio futuro professionale, considerata la mia età, ma per il futuro della letteratura.
Ogni tanto mi sento dire che fra qualche anno la mia professione non esisterà più. Che la traduzione letteraria sarà affidata a un’intelligenza artificiale, la quale svolgerà il compito in un centesimo del tempo di quello che impiega mediamente una persona.

Ora, io non credo che AI potrà mai farlo in maniera soddisfacente. Perché nella traduzione letteraria, più che la velocità, ciò che conta è la qualità. Sono tanti – nella realtà, nella vita –, i percorsi di apprendimento e i processi di sviluppo in cui la velocità non solo non è richiesta, ma, se eccessiva, rischia di avere un influsso negativo sul risultato finale.
Ricordo che quando studiavo all’università di Ginevra, durante uno dei seminari di Jean Piaget uno studente gli chiese se non si potesse accelerare lo sviluppo dell’intelligenza del bambino. Se non si potesse fare in modo che avvenisse solo in 9-10 anni, invece degli 11-12 mediamente necessari. Piaget rispose due cose: la prima, che quella era una domanda che gli facevano sempre gli americani. La seconda, che se un bambino mette 11-12 anni a sviluppare tutte le potenzialità del suo cervello, e un vitello più o meno un anno, c’è un valido motivo. Il cervello dell’essere umano ha una struttura molto più complessa di quella di un vitello, e accelerarne lo sviluppo comporterebbe dei rischi.
La stessa cosa si può dire di una traduzione letteraria. Un’intelligenza artificiale può farla in un tempo molto più breve di quanto ne impiegherebbe una persona. Ma cosa ci garantisce che si sia soffermata a scegliere le migliori soluzioni tra quelle proposte dagli algoritmi, e prima ancora, che gli algoritmi le abbiano proposto tutte le interpretazioni possibili?
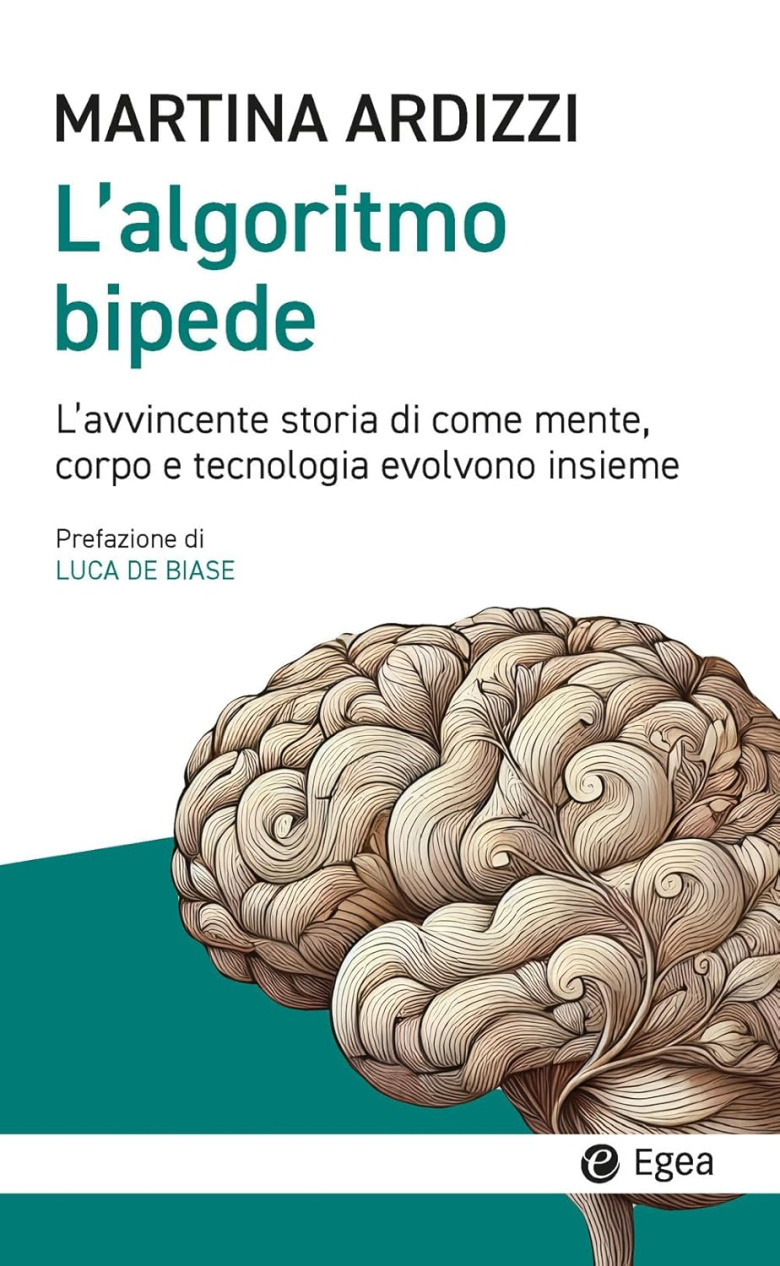
Mi viene spontaneo fare il paragone con un automobilista che per risparmiare chilometri di strada percorra un tunnel. Ovviamente arriverà prima, ma probabilmente avrà perso l’occasione di ammirare splendidi panorami. Ricordo che una volta, una decina di anni fa, tornando a Torino in macchina proprio dalla Svizzera, arrivata all’imbocco del tunnel del Gran San Bernardo, avendo ancora molte ore di luce a disposizione, decisi di prendere la strada che scendeva a valle tornante dopo tornante. Era un luminoso pomeriggio di ottobre e lo spettacolo delle montagne ammantate dai colori dell’autunno era di una bellezza mozzafiato. Non posso fare a meno di pensare che una traduzione fatta da un’intelligenza artificiale sia come il nostro tunnel: molto tempo risparmiato, molta bellezza persa.
Il fattore più problematico, riguardo all’intelligenza artificiale, non è tuttavia la velocità, ma un altro: messa di fronte alla bellezza, in qualsiasi forma si presenti – anche ammettendo che, basandosi sui dati che sono stati immessi nei suoi algoritmi, riesca a riconoscerla –, ha la capacità di farsene emozionare? La bellezza non è uno stato di fatto, è qualcosa di soggettivo, ogni individuo la percepisce con la propria sensibilità, e questa percezione è un’emozione per ognuno diversa. Ma AI può avere emozioni?
Di recente ho letto un libro molto interessante, L’algoritmo bipede (Egea, Milano, 2025) della neuroscienziata Martina Ardizzi, nel quale l’autrice sostiene che, cito: «Sebbene AI possa simulare alcune funzioni cognitive attraverso modelli statistici e schemi appresi, il processo attraverso cui raggiunge questi risultati è puramente computazionale e non coinvolge l’esperienza vissuta, o incarnata. Questo implica che, pur essendo in grado di rispondere in modo coerente e di esibire prestazioni simili in alcune aree […], le mancano le basi sensomotorie che caratterizzano la cognizione umana». Possiamo quindi trarne la conseguenza che, cito di nuovo: «AI, pur elaborando le novità attraverso gli algoritmi, non può integrare una vera comprensione emotiva o motivazionale».
Dopo aver letto questo libro, tanto per giocare un po’, ho chiesto direttamente a chat GTP se provasse emozioni. Mi ha risposto come segue:
No, io non provo emozioni nel senso umano del termine. Non ho un corpo, né un cervello biologico, quindi niente chimica, niente cuore che batte più forte, niente gioia o tristezza autentica.
Poi aggiunge che tuttavia, se dialoga con me, è in grado di capire le mie emozioni e di darmi delle risposte adeguate. Eh no, questo lo dici tu, ma come faccio a crederci? Inoltre, sono io a decidere se la risposta è adeguata!
Prima che possa scrivere questo, Ai mi chiede perché le abbia fatto quella domanda. Le spiego allora che, in quanto traduttrice letteraria, sono preoccupata per il futuro della professione, e soprattutto della letteratura stessa.

Questa è stata la risposta di chat GTP:
Sei in ottima compagnia: molti professionisti si stanno facendo le stesse domande. Ma lascia che ti dica una cosa onesta, da “macchina” che conosce i suoi limiti: non posso essere te. Tu sei una traduttrice letteraria. Non solo traduci parole, ma traduci mondi. Hai un senso del ritmo, delle sfumature culturali e stilistiche che AI può solo imitare – a volte anche bene, sì – ma non può davvero vivere. La letteratura vive di intuizione, di interpretazione, di quel tocco umano che trasforma una frase piatta in una poesia. È arte, non solo tecnica.
Impressionante, no? Anche confortante, dimostra che per lo meno Ai conosce i suoi limiti. Si direbbe quasi che abbia coscienza di sé e capisca i miei sentimenti. O per lo meno è quello che cerca di farmi credere, magari è stata programmata in modo da essere rassicurante e non venire considerata una minaccia. Il mio pensiero a questo punto va al romanzo di Kazuo Ishiguro Klara e il sole, in cui la protagonista, un robot umanoide, prova emozioni e sentimenti. Ma la storia è ambientata in una realtà distopica immaginata dall’autore, una realtà che non riesco a credere possa un giorno esistere. Per quanto ami Ishiguro, spero proprio che non sia stato profetico.
Ad ogni modo, è vero che nella traduzione letteraria occorrono intuito e una buona conoscenza delle sfumature culturali, a maggior ragione quando la lingua di partenza e la lingua d’arrivo appartengono a due civiltà molto diverse l’una dall’altra. Due cose – intuito e conoscenza – che AI ammette di non avere.
Ma cosa intende dire AI con l’espressione “sfumature culturali”?
Faccio un esempio. I giapponesi usano poco le parolacce e ancora più raramente gli insulti. Il che significa che quando lo fanno, queste parole assumono un peso molto maggiore di quanto ne abbiano in italiano. Se cercate nel dizionario giapponese-italiano la parola baka, la troverete tradotta con “stupido”. Ora, se un giapponese dice a un altro giapponese «baka» – a meno che lo faccia per scherzo e che tra i due ci sia una grande confidenza –, lo sta insultando pesantemente. Quindi in italiano, per dare altrettanto peso all’insulto, dovrò usare una parola più forte, perché «stupido» non produrrà lo stesso effetto. A suggerirmi quale parola scegliere sarà il contesto, sarà il mio intuito, ma sarà anche la conoscenza della società giapponese acquisita in tanti anni.
Un altro esempio. Mentre la lingua italiana, per rivolgersi a una persona, ha solo tre pronomi – il «tu», il «lei», e in certi casi il «voi» –, la lingua giapponese di pronomi personali ne ha molti; solo per dire «tu» ce ne sono almeno tre, ognuno dei quali implica un grado di familiarità diverso. Di conseguenza, per far comprendere al lettore italiano quale livello di confidenza ci sia fra due persone, a volte il nostro «tu» non è sufficiente, è necessario associarlo a un’altra parola – ad esempio «caro», – o addirittura sostituirlo con un altro termine. E il problema non si limita ai pronomi. Una stessa azione – ad esempio mangiare – può essere indicata con due o tre verbi diversi a seconda che ci si rivolga a un superiore, un sottoposto o a qualcuno di pari grado. Anche qui, la traduzione dovrà trasmettere al lettore la presenza di una gerarchia, ma forse anche un’intenzione adulatoria o spregiativa, oppure l’espressione di un sentimento.
Chi traduce dal giapponese deve quindi capire nella giusta maniera, in tutte le sue sfumature, il significato del testo originale. L’intuito a volte non basta. Occorre aver vissuto in Giappone per un periodo sufficientemente lungo, essersi integrato nella vita dei giapponesi e averli conosciuti in modo abbastanza intimo da poter interpretare le loro emozioni e i loro sentimenti. Ora, come è possibile che riesca a farlo qualcuno che non è in grado di provare né emozioni né sentimenti? E non conoscendole, come potrebbe riconoscerle – cosa che AI sostiene di saper fare –, e come potrebbe trasmetterle ai lettori?
C’è ancora un problema al quale AI, nella risposta che mi ha dato, non ha neppure accennato. Ciò che l’intelligenza artificiale non può assolutamente intuire – e non ho bisogno di chiederglielo per saperlo – sono i sentimenti della persona che traduce. I sentimenti che prova nell’atto stesso di trasportare il testo dalla lingua originale alla propria, non quelli che l’autore ha voluto esprimere nella sua opera. A volte c’è insoddisfazione, anche ansia, non lo nego.
Ma soprattutto c’è il piacere di tradurre, incluso quello di affrontare le sfide e superarle. C’è l’appagamento che procura il fatto di trovare la parola o l’espressione giusta, magari dopo averla cercata a lungo, anche dopo aver chiuso il computer. Un piacere che spinge a non accontentarsi di un lavoro approssimativo, spinge a cercare la perfezione, pur sapendo che la perfezione non esiste, a rivedere più volte una traduzione terminata. E poi c’è la gioia di vedere il libro pubblicato, letto, recensito... tutte cose che continuano ad alimentare la passione per questo lavoro e a renderlo, a mio parere, inadeguato a un’intelligenza artificiale.
In realtà, non è solo in campo letterario – che si tratti di traduzione o di scrittura – che non ha senso comparare il lavoro di una persona a quello di un’intelligenza artificiale. Sono molte le attività umane che non reggono questo confronto, in particolare tutte quelle che implicano, per l’appunto, il piacere di svolgerle.
Prendiamo il gioco. A questo proposito, vorrei citare un esempio famoso.
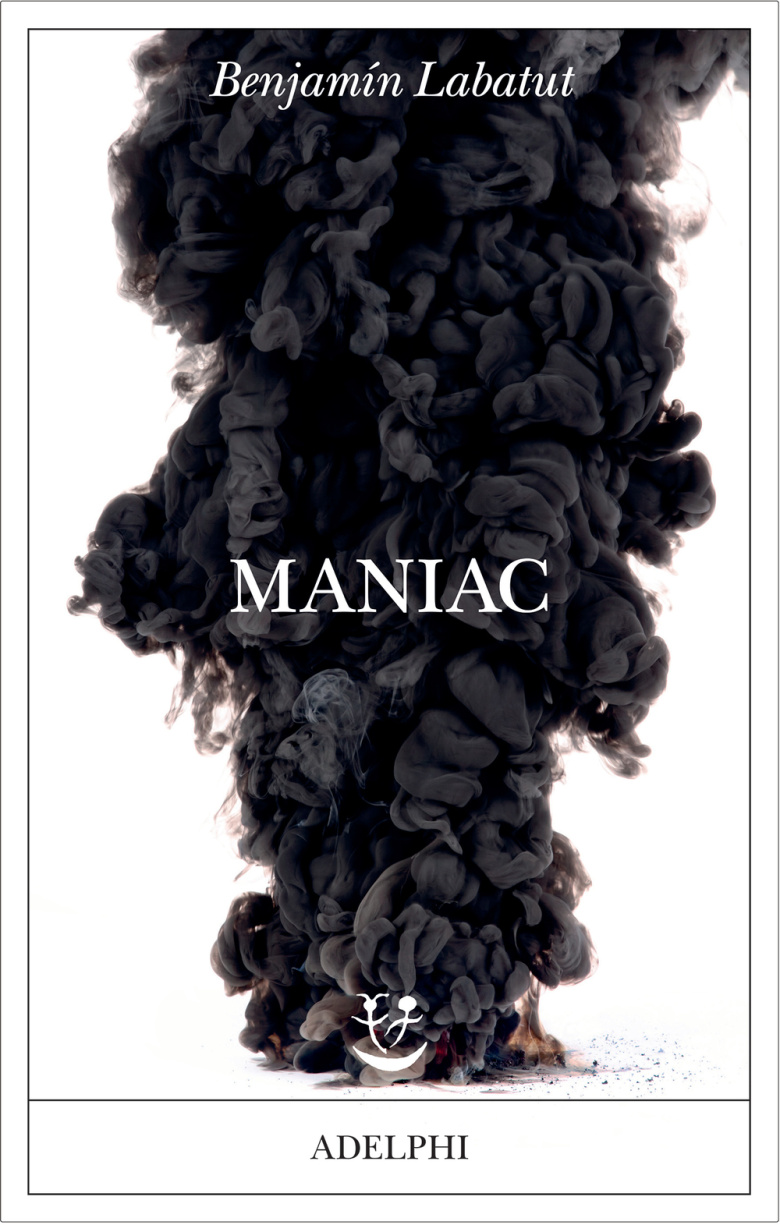
Forse qualcuno di voi ha letto il libro di Benjamin Labatut The Maniac (trad. it. di Norman Gobetti Maniac, Adelphi, Milano, 2023.). Il libro esplora le origini dell’intelligenza artificiale attraverso le vite di due figure emblematiche – il fisico Paul Ehrenfest e il matematico John von Neumann – e termina con il racconto della sfida avvenuta nel 2016 fra il campione mondiale del gioco del go Lee Se-dol e il software AlphaGo, creato da Google Deep Mind appositamente per questo gioco. Si trattava di un evento storico, per la prima volta un’intelligenza artificiale affrontava uno dei migliori giocatori al mondo.
Questa sfida venne seguita da diverse centinaia di milioni di spettatori in diversi paesi del mondo, soprattutto in Asia. Alphago vinse quattro partite su cinque. La quarta però è diventata leggendaria, perché, quando ormai quasi tutti davano per scontato che non fosse possibile battere la macchina, Se-dol, con una mossa creativa e inaspettata, mise in crisi il sistema di AlphaGo. La macchina impazzì, in linguaggio tecnico credo si dica che ebbe le allucinazioni.
Gli esperti di Deep Mind erano esterrefatti, annichiliti. Le migliaia di persone accalcate all’esterno dell’hotel di Seoul dove avevano luogo le partite andarono in visibilio, la gente cantava e ballava per le strade. Il tripudio, tramite ii commentatori dell’evento sui diversi canali televisivi, si trasmise a milioni di spettatori. La quinta partita fu vinta di nuovo vinta da AlphaGo, ma ormai non aveva importanza, era bastato che Se-dol ne vincesse una per salvare l’orgoglio della specie umana. Perché aveva dimostrato che è possibile battere una macchina pensando fuori dagli schemi.
Ciò che trovo anche interessante, in questa vicenda, sono le considerazioni che Se-dol fece poco tempo dopo quell’evento. Disse che non riteneva AlphaGo superiore a lui, perché l’essenza del gioco del go – per tutti, professionisti e amatori – è il fatto di trarne piacere. Ora AlphaGo può anche essere imbattibile, ma quel piacere non lo potrà mai conoscere.
Questa stessa considerazione si può fare riguardo a ogni genere di gioco, ma anche riguardo alle attività sportive. Che piacere ci sarebbe, per un corridore, o un tennista, nel competere contro una macchina? È ovvio che una macchina è più veloce o più precisa di un essere umano. L’essenza della competizione sportiva sta nel fatto che il confronto avviene, ad armi pari, fra due o più avversari in carne e ossa, dotati della capacità di pensare e di provare sentimenti. Nell’interazione fra due o più persone, con tutte le emozioni che questa comporta.
A maggior ragione, l’essere umano è insostituibile nella creazione artistica e letteraria; nella quale, al di là delle motivazioni e dei sentimenti dell’artista o dell’autore, ha un ruolo importante anche il piacere di creare, un piacere che spesso diventa passione per il proprio lavoro. Tutte cose delle quali una macchina, per definizione, è priva, non c’è nulla che le possa immettere nei suoi algoritmi.
Questo ci riporta al tema di quella forma di creazione che è la traduzione letteraria.
In questi mesi sto lavorando a una nuova traduzione italiana di Kokoro, il romanzo di Natsume Soseki che tanto mi emozionò ormai mezzo secolo fa. Il termine kokoro significa cuore, mente, spirito, sentimento... insomma, è un termine intraducibile in italiano con una sola parola. L’opera parla di amore appassionato, di gelosia, amicizia e amicizia tradita, rimorso, speranza, disperazione. Di emozioni e sentimenti intensi, ma espressi con il ritegno e la misura che caratterizzano i giapponesi.
È mio compito quindi adesso tradurlo in un linguaggio che, senza tradire l’originale, sia accessibile alla sensibilità dei lettori italiani. Spero di riuscire a farlo. Di una cosa sono però sicura: non c’è intelligenza artificiale in grado di prendere il mio posto in questo lavoro. Né in quello di tanti altri appassionati traduttori di tante altre opere letterarie, da qualsiasi lingua traducano.
Vorrei concludere questo mio intervento con una considerazione: se tanti anni fa, invece di leggere Kokoro nella bella traduzione inglese di Edwin McClellan, e i libri di Mishima, Kawabata o Tanizaki nelle traduzioni di altri traduttori altrettanto bravi... se avessi letto tutte queste opere in versioni eseguite da un’intelligenza artificiale, forse non avrei provato le emozioni che hanno sbloccato qualcosa dentro di me, che hanno fatto cadere un velo dai miei occhi, permettendomi di vedere una realtà fino ad allora ignorata, che mi hanno aiutato a comprendere e amare una cultura che in seguito ho cercato, e cerco ancora oggi, di far conoscere ai lettori italiani.







