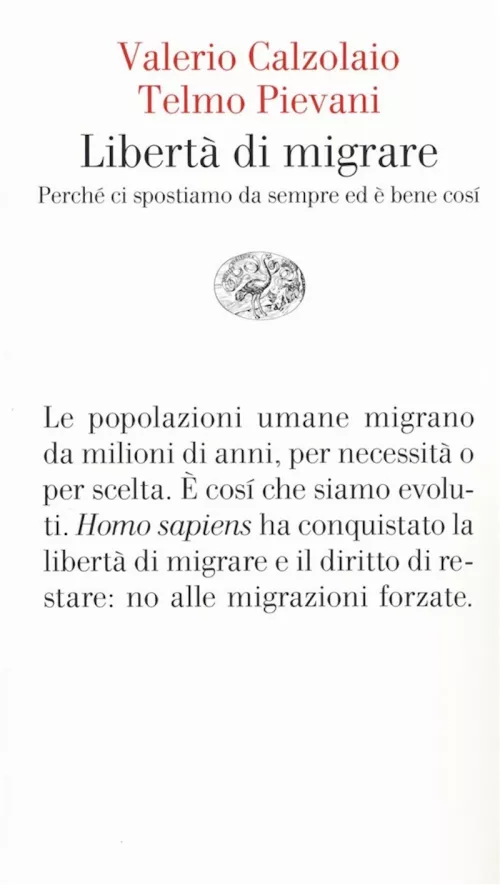Perché ci spostiamo da sempre ed è bene così / Libertà di migrare
Dopo essere rimasti a lungo puntati in maniera pressoché esclusiva sul sisma che ha devastato il Centro Italia, i riflettori mediatici hanno ripreso gradualmente a volgersi altrove; e, com’era facile prevedere, tra gli obiettivi principali ci sono le acque del Mediterraneo, solcate dai barconi dei migranti. Accanto alle macerie, alle tende, alle lacrime dei sopravvissuti sono tornati sui nostri schermi i relitti, i salvataggi, i visi stremati dei naufraghi, i campi di raccolta, i muri.
Nessun argomento come quello dell’afflusso dei migranti sollecita meccanismi istintivi di reazione. In certa misura questo è inevitabile, e sarebbe bene che tutte le forze politiche ne tenessero conto: non solo quelle xenofobe, che da sempre fanno leva sui moti irriflessi di repulsione verso l’estraneo e il diverso, tanto più che ora la tragedia del terremoto offre loro un facile spunto retorico. Non occorre un profeta per indovinare che di qui in avanti, per ogni futura somma destinata ai migranti, ci sarà chi recriminerà sulle risorse sottratte alla ricostruzione, all’assistenza ai terremotati, alla prevenzione antisismica. Ma poiché il fenomeno migratorio è davvero – insieme ai mutamenti climatici e alla sovrappopolazione – una delle questioni sulle quali si giocherà il nostro futuro, è importante averne una cognizione meno approssimativa. Un contributo prezioso, anche per la sua agilità, è il volumetto apparso pochi mesi fa nelle «Vele» a firma di Valerio Calzolaio e Telmo Pievani: Libertà di migrare. Perché ci spostiamo da sempre ed è bene così (Einaudi, pp. 134, € 12).
Per dirla nella maniera più breve, ciò che questo denso libretto propone è un esercizio di lungimiranza. Lungimiranza: cioè sguardo da lontano, che punta lontano. Le immagini della cronaca tendono a colpire, ad abbacinare, e perciò – a prescindere dalle intenzioni soggettive di chi le confeziona – tendono a fomentare risposte precipitose. Solo uno sguardo esteso su orizzonti spaziali e temporali di ampio respiro, può aprire la via a una maggiore consapevolezza, e quindi a decisioni più fondate ed efficaci. Non si può far fronte alle grandi questioni del presente senza conoscere il passato (anche il passato remotissimo), e se non si dispone di un’immagine globale dei fenomeni: e questo è tanto più vero se l’obiettivo che ci si pone è una gestione sostenibile delle migrazioni. Per inciso, a proposito del tempo presente, il Congresso Internazionale di Geologia tenutosi a Città del Capo il 29 agosto ne ha certificato la nuova identità. L’epoca post-glaciale (l’Olocene) si è conclusa, siamo entrati in una nuova era geologica, denominata Antropocene. Il termine non è nuovo; coniato negli anni Ottanta dal biologo americano Eugene Stoermer, ha cominciato a circolare e a diffondersi dall’inizio del secolo, specie dopo la pubblicazione di un articolo dello stesso Stoermer e dell’olandese Paul Crutzen (Nobel per la chimica nel 1995) apparso sulla newsletter dell’IGBP (International Geosphere and Biosphere Programme) il 31 agosto 2000. Quello stesso intervento, facilmente reperibile sul sito, ricordava peraltro che già nel 1873 Antonio Stoppani (sì, proprio quello del Bel Paese), aveva proposto per il nostro tempo la denominazione di «Era Antropozoica».

L’intento degli autori di Libertà di migrare – uno studioso di evoluzione e un esperto di problemi ambientali – è di offrire «un atlante globale, storico e geografico, delle migrazioni umane, letto per la prima volta in chiave evoluzionistica». Anche se il volume si presenta come unitario, evidente è la spartizione dei compiti. La prima parte (grosso modo, 6 capitoli su 12), di competenza di Telmo Pievani, ricostruisce origine e sviluppo del genere Homo e della specie Homo sapiens; nella seconda, dopo aver tracciato una sintesi dell’età storica, Valerio Calzolaio illustra il panorama attuale del fenomeno migratorio e propone gli scenari possibili per i prossimi decenni.
Tutti i viventi, vegetali e animali, si spostano, secondo le opportunità delle condizioni ambientali e la pressione delle variazioni climatiche. La migrazione di certe specie condiziona poi a sua volta altre specie; vi sono specie che si sono trasferite in luoghi diversi da quelli dove si erano formate, altre che si sono adattate a migrazioni periodiche. Nel caso del genere al quale apparteniamo, la migrazione ha svolto una funzione evolutiva straordinaria. Primate esploratore e camminatore, Homo si è evoluto migrando, e adattandosi rapidamente a ecosistemi quanto mai diversi fra loro. Ciò è avvenuto perché ai processi lentissimi dell’evoluzione genetica si sono aggiunti quelli ben più rapidi dell’evoluzione culturale. Ma diversamente da quanto si è pensato fino a poco tempo fa, la «novità cruciale» nella nostra filogenesi non è stata la crescita del cervello, bensì l’adozione della postura bipede, legata all’inaridimento progressivo dell’Africa orientale dopo la formazione della Rift Valley. L’avventura umana comincia da lì.
Da tempo è invalsa l’espressione «Out of Africa» (ovviamente debitrice del titolo di Karen Blixen) per indicare le disseminazioni che a partire da oltre un milione e mezzo di anni fa hanno portato specie umane a colonizzare l’Asia e l’Europa, dal Caucaso alla Cina, da Giava alla penisola iberica. Non si tratta di migrazioni nel senso più comune oggi, bensì di espansioni geografiche progressive, condotte prima da Homo ergaster, quindi, qualche centinaio di migliaia di anni dopo, da Homo heidelbergensis (da queste specie se ne sviluppano poi varie altre, nei diversi areali, fra cui Homo neanderthalensis). Della terza Out of Africa, circa 135.000 anni or sono, sarà finalmente protagonista Homo sapiens. Ma ce ne sarà ancora un’altra, fra 70 e 60.000 anni fa, dopo il «collo di bottiglia» evolutivo di una drastica riduzione della popolazione globale, dovuta forse a una catastrofica eruzione vulcanica in Indonesia. La variabilità genetica della popolazione odierna è infatti assai modesta, e sempre più piccola man mano che ci si allontana dall’Africa: di qui l’ipotesi che gli oltre 7 miliardi di umani che oggi popolano il pianeta discendano da un gruppo di poche decine di migliaia di individui. Naturalmente non dobbiamo immaginare un’espansione lineare, regolare e progressiva: «insieme o accanto alle specifiche ondate vi potevano essere altre migrazioni, fughe, riflussi, dispersioni individuali, ramificazioni». Inoltre, bisognerebbe distinguere fra diversi tipi di mobilità: i cacciatori sono erranti, più che nomadi.
La stanzialità indotta dalla nascita dell’agricoltura, generando nuove e più complesse articolazioni sociali e potenziando enormemente le capacità di cooperazione, modifica profondamente sia il rapporto con gli ecosistemi sia le pratiche migratorie. «Andarsene diventò un’opzione eventuale e meditata, sempre più legata a dinamiche umane»: in altri termini, «una scelta culturale». È difficile sottovalutare la portata della rivoluzione neolitica. Valga un minimo riscontro demografico: 12000 anni fa i cacciatori raccoglitori erano il 100% di una popolazione globale di forse 10 milioni, 500 anni fa erano l’1% su un totale di circa 350 milioni. Ma i semi erano stati gettati prima. Un’intima sintonia lega infatti da sempre il camminare al pensare, e migrare – cioè spostarsi lontano dai luoghi familiari – stimola una serie di attitudini decisive per l’evoluzione umana: la curiosità esplorativa, la flessibilità di comportamento, la disposizione a cooperare con i propri simili, la capacità di immaginare i connotati di ambienti sconosciuti. Le radici delle straordinarie innovazioni tecnologiche moderne – incluso l’iPhone 7, di cui qualche lettore avrà forse appena preso visione su una qualche pagina web – affondano nell’infaticabile incamminarsi dei nostri ancestrali progenitori, nell’ostinato impulso dei nostri antenati a volgere verso il largo le prue di piroghe e di velieri.
La diffusione dell’agricoltura stanziale ha come effetto la nascita (o forse bisognerebbe dire l’istituzionalizzazione) dei confini. I confini antropici definiscono un luogo e un’appartenenza, distinguendo l’emigrare dall’immigrare. Di conseguenza, migrare diventa anche un cimento con i confini, che implica «una doppia assenza e una doppia presenza», rispetto all’origine e alla destinazione. In pace e in guerra, le forme del migrare cambiano. Viaggi e commerci, contatti e conquiste, invasioni e deportazioni danno vita a una quantità di fenomeni correlati – assimilazioni, assoggettamenti, cooptazioni, integrazioni – e la dialettica tra costrizione e libertà si fa sempre più articolata e complessa.
A metà dello scorso millennio, quando i popoli con istituzioni e confini statuali sul proprio territorio erano ancora di fatto una minoranza, si è verificata la prima «Out of Europe». Gli Stati nazionali d’Europa impongono un dominio militare, economico, tecnologico, culturale che ha implicazioni demografiche imponenti, quali il popolamento massiccio delle Americhe e la deportazione di schiavi dall’Africa subsahariana, cioè la più grande migrazione intercontinentale forzata di tutti i tempi, non meno di 12 milioni di persone nell’arco di tre secoli. Negli ultimi 250 anni si è poi si è verificata, secondo i nostri autori, una «Out of Europe 2», consistente nella diffusione di areale dell’economia capitalistica. Nel 1914 l’Europa controllava l’80% della superficie terrestre. Anche dal punto di vista del fenomeno migratorio la Prima Guerra Mondiale segna una svolta. Si chiude l’epoca delle migrazioni libere; il numero degli Stati nazionali si moltiplica rapidamente, crescono le barriere istituzionali e motivazionali della mobilità. Ma l’economia-mondo continua a innescare migrazioni, le sollecita, se ne alimenta; i confini la condizionano, ma ciò non le impedisce di superarli e di crearne di nuovi.

Nel frattempo le migrazioni divengono oggetto di studio e di riflessione da una quantità di prospettive, compresa quella giuridica. Così suona l’art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948: § 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. § 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. «Libertà di partire, diritto di restare. Diritti umani in patria, libertà di migrare altrove».
Ideali, com’è ovvio, che non sembrano ancora a portata di mano, e che l’allarmante fondale «antropocenico» sui cui si svolgono le migrazioni dei nostri tempi (inquinamento, effetto serra, perdita di biodiversità, degrado del suolo, carenza di acqua dolce) sembra anzi sospingere sempre più lontano. Il fenomeno migratorio contemporaneo comprende ogni motivo possibile, «espellente o attraente, volontario o coattivo»: lavoro, ricchezza, povertà, fame, sete, guerre, persecuzioni, catastrofi ambientali. Quest’ultimo tema è particolarmente caro a Valerio Calzolaio, che l’ha affrontato nel volume del 2010 Ecoprofughi (nuova edizione Nda Press, 2016). Gli environmental refugees sono ormai più numerosi dei profughi politici, e gli sconvolgimenti ecologici – a cominciare dall’inaridimento del suolo in vaste plaghe Africa – minacciano un incremento vertiginoso del loro numero.
Bisognerebbe soffermarsi in maniera analitica sugli ultimi capitoli di questo libro, che illustrano la situazione attuale fornendo dati e numeri che tutti dovrebbero conoscere prima di parlare di migrazioni e di migranti. Perché questo è il guaio: i numeri, bisogna saperli usare; e con proprietà, e correttezza. Se infatti i numeri di per sé non mentono, con i numeri è molto facile sia ingannare, sia ingannarsi. La prassi più comune nell’informazione mediatica è l’esibizione di valori isolati, estrapolati dai contesti, ai quali è un gioco da ragazzi imprimere la coloritura emotiva desiderata. La maggior parte delle cifre che ci intercettano dai giornali, dai tg, dai media sociali, equivalgono di fatto a sinonimi di tanti, o troppi, o troppo pochi. E solo dell’impressione di questi avverbi serbiamo qualche memoria.
Darò in conclusione due numeri anch’io, sperando che vengano presi per il verso giusto: non surrogati di un’argomentazione, ma stimolo a informarsi, consultando le tabelle fornite da fonti attendibili (ad esempio le relazioni annuali di agenzie internazionali). Il primo è un dato: dal 2008 al 2014, secondo l’IDMC (International Displacement Monitoring Centre) sono stati delocalizzate per disastri di varia natura 185 milioni di persone in 173 paesi: tra questi, il 20% della popolazione delle Filippine (i discorsi sulle migrazioni soffrono di una radicale sottovalutazione delle migrazioni interne, spesso non meno traumatiche per gli interessati). Il secondo è una previsione: nel 2030 la probabilità di diventare rifugiati climatici riguarderà non meno di 250 milioni di persone. A proposito di numeri: sapreste dire quanti sono i profughi che arrivano in Europa ogni anno?
Ad onta di un quadro che sembra avere (e che in moti casi ha) connotati quasi apocalittici, gli autori di Libertà di migrare si esprimono in maniera non equivoca sulla possibilità di gestire migrazioni sostenibili. Per inciso, fra i termini che contengono in nuce lo spirito dell’epoca, «sostenibile» è uno dei più pregnanti, come testimonia il ventaglio di sostantivi a cui si abbina (agricoltura, architettura, benessere, economia, mobilità, sviluppo, turismo…). La «sostenibilità» è una delle grandi «sfide» (altro vocabolo di attualità sociolinguisticamente marcato) del mondo odierno. Ma un approccio corretto richiede di sgombrare il campo sia dai pregiudizi, sia dalle classificazioni storicamente obsolete. Fra queste va annoverata la distinzione, tuttora vincolante sul piano giuridico, fra migranti economici e rifugiati politici (vittime di guerre o persecuzioni). Abolirla non sarebbe che il primo passo del cammino – del lungo cammino – che dobbiamo percorrere.
Valerio Calzolaio e Telmo Pievani, Libertà di migrare. Perché ci spostiamo da sempre ed è bene così (Einaudi, pp. 134, € 12).