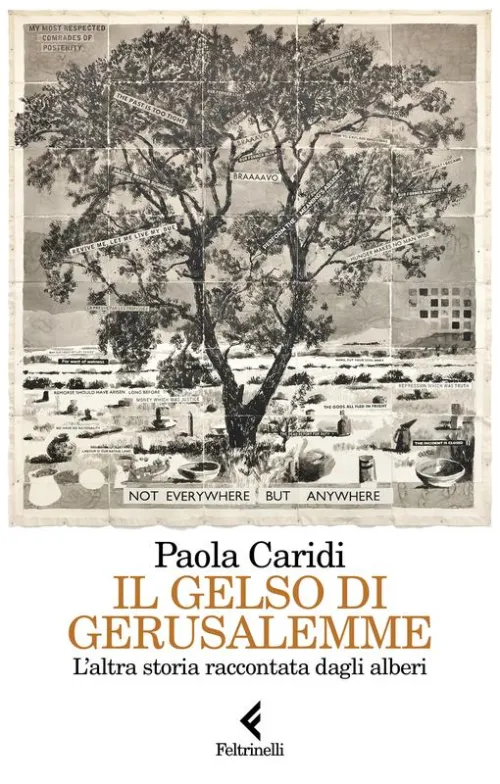Gerusalemme: il gelso non c’è più
«L’enorme quercia era onorata dalle donne del villaggio che facevano voti al suo indirizzo e legavano ai suoi rami lunghi teli bianchi»: questa citazione, proveniente dalla tesi di dottorato di Suad Amiry, istituisce una continuità molto più che ideale tra Il gelso di Gerusalemme. L’altra storia raccontata dagli alberi (pagine 160, euro 17) e Sudari. Elegia per Gaza (pagine 124, euro 12), i due libri di Paola Caridi pubblicati da Feltrinelli rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Sono i capitoli più recenti della riflessione che da molto tempo l’autrice conduce sul Medio Oriente. I suoi Arabi invisibili, Gerusalemme senza Dio e Hamas (tutti in catalogo da Feltrinelli) sono ormai riferimenti indispensabili per chi voglia conoscere di più, e con maggior cognizione di causa, le drammatiche implicazioni della questione palestinese. Già corrispondente dal Cairo e da Gerusalemme, dove ha vissuto per dieci anni, Caridi è una giornalista dalla scrittura misurata e sapiente, ed è una studiosa che ricorre all’onere della prima persona solo quando questo le permette di corroborare il proprio statuto di testimone. Succede nel Gelso di Gerusalemme, dove l’elemento autobiografico affiora a più riprese, senza mai offuscare il disegno di un’analisi dolorosa e affascinante. Caridi fa della documentazione – straordinariamente ampia e costantemente aggiornata sulle fonti internazionali – lo strumento di una poetica che indaga il mistero dell’umanità attraverso il dialogo serratissimo e appassionato con il “nonumano”. Anzi, con i nonumani, la cui presenza silenziosa si qualifica non soltanto in contrapposizione all’umano, per via di negazione, ma semmai in solidarietà con l’umano stesso, per via di coesistenza e collaborazione. Ne danno conferma gli alberi censiti nel Gelso di Gerusalemme, le cui vicende si intrecciano di continuo con le attività umane (troppo umane, talvolta) di coltivazione, commercializzazione, catalogazione. Rientrano in questa sfera anche i diversi manufatti, più o meno nobili o degradati, che Caridi passa in rassegna nelle pagine di Sudari, testo di fulminante brevità che non dissimula la sua origine teatrale e che infatti continua a essere riproposto in una serie di partecipate letture sceniche.
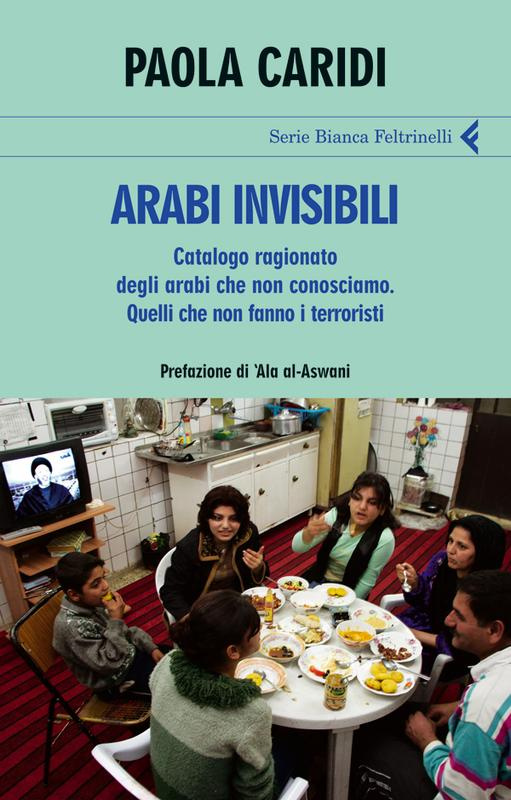
È un punto importante, sul quale occorre soffermarsi. Per Caridi, il nonumano non è un’alternativa all’umano, ma una componente che lo definisce. E questo non è meno vero quando il nonumano si manifesta nella modalità del vuoto e dell’assenza, lungo una scala di sottrazione che conduce, da ultimo, all’umanissima dimensione del lutto. Sia Il gelso di Gerusalemme sia Sudari sono celebrazioni dell’assenza, tentativi di riconquistare ciò che sarebbe altrimenti perduto. Come il gelso che dà titolo al libro dello scorso anno, albero rigoglioso del quale rimane solo un moncone. Qualcuno si è sbarazzato della pianta, probabilmente per evitare che le bacche, cadendo, macchiassero il selciato della Città Vecchia. «Moncone – insiste Caridi –, come il pezzo rimasto di un braccio (umano)». Da questo minimo stratagemma lessicale discende gran parte della struttura del racconto, che è anzitutto un racconto di idee. Il gelso non c’è più, così come sono scomparsi molti dei villaggi palestinesi che un tempo si sviluppavano attorno ai sicomori, gli «alberi-piazza» che con la loro ombra garantivano coesione e riparo alla comunità. Anche ai rami del sicomoro, ricorda Caridi, venivano appesi «pezzi di stoffa bianchi: non erano un abbellimento, erano – semmai – un contatto stabilito con l’albero come mediatore per ricevere la grazia». Segno dell’ospitalità e della gratuità, nella cultura tradizionale il sicomoro offre il proprio frutto senza eccezione e senza chiedere nulla in cambio a chi se ne ciba.
Se pure non viene eliminato, un albero può essere tramutato e travisato, come è accaduto agli aranceti di Jaffa, che da orgoglio dell’economia palestinese nell’epoca precedente la Nakba sono diventati l’emblema dell’intraprendenza agricola e imprenditoriale dello Stato di Israele. Ancora una volta, nella prosa di Caridi ricognizione storica e visione poetica si completano a vicenda, grazie a un verso di Mahmoud Darwish o a un frammento narrativo di Ghassan Kanafani, voci tra le più alte e riconoscibili della letteratura palestinese. La costruzione dell’identità israeliana non si limita, in ogni caso, all’appropriazione e alla conseguente risemantizzazione delle caratteristiche arance shamouti, ma prevede anche il ricorso al bosco come barriera di occultamento che ribadisce la reclusione della popolazione palestinese. Le intenzioni degli umani hanno la capacità di ledere l’innocenza dei nonumani e perfino il gelso può trasformarsi in minaccia, come dimostra uno degli episodi meno noti e più rivelatori tra i molti evocati da Caridi, quello della monocoltura del gelso introdotta in Libano nel corso del XIX secolo, in conseguenza della quale il Paese si trovò a soffrire una devastante carestia negli anni della Prima guerra mondiale.

Non sono soltanto storie di ieri, le “altre storie” che gli alberi raccontano. Una sezione consistente del Gelso di Gerusalemme è dedicata alle cronache dell’ultimo decennio, nelle quali – dalla simbolica occupazione di Zuccotti Park a New York fino alla fallita rivolta del parco di Gezi a Istanbul – gli spazi del verde urbano si impongono come luoghi di insurrezione e resistenza: come occasioni per pensare altrimenti, nel segno di quell’alterità che il nonumano consente all’umano. Sembra appartenere a questa categoria il magnifico Orto Botanico di Palermo, la città nella quale Caridi vive attualmente e che nel libro si affianca alle memorie di una Roma ancora in parte rurale e dell’amatissima, tormentata Gerusalemme. Ma proprio nell’Orto Botanico affiorano le tracce di un’ulteriore ambiguità, relativa alla nomenclatura che, da Linneo in poi, la colonizzazione occidentale ha imposto alle specie botaniche di altri continenti. Con questo si ritorna al tema dell’assenza, che corrisponde qui alle denominazioni indigene soppiantate dal latinorum dei classificatori europei, e ci si avvicina di un altro, decisivo passo allo strazio di Sudari.
Nel resoconto – accidentato, reticente, incompleto – della distruzione di Gaza vanno conteggiate tra le vittime anche le parole, a partire dall’impronunciabile “genocidio” che invece Caridi colloca in apertura di un libro le cui dimensioni sono inversamente proporzionali alla risonanza che riesce a generare. Tra le poche acquisizioni sicure del Secolo Breve, c’è però la certezza che le immagini sappiano spingersi dove le parole non arrivano o non possono arrivare. A dare corpo alla vastità dello sterminio sono dunque i fotografi palestinesi che, tra un bombardamento e l’altro, riproducono il moltiplicarsi dei teli bianchi usati come sudario per i morti. Il salto nell’incalcolabile avviene presto, presto si esaurisce la materia prima (mussolina, cotone) e presto si passa ai sacchi di plastica., fino a quando sui cadaveri non si stendono gli stracci recuperati dalla disperazione. I sudari di Gaza, osserva Caridi, «sono uguali alle stesse bende in cui Gesù Cristo era stato posto dopo la crocifissione, e che vengono trovate a terra da chi accorre alla tomba». Rispondono alla stessa logica del velo di seta bianca posto sul volto del papa (da ultimo, sul volto di papa Francesco) prima che la bara sia richiusa. La differenza sta nel fatto che, mentre nelle società occidentali è il segno di una tradizione per molti aspetti sbiadita, in Palestina il linguaggio dei sudari resta tragicamente intelligibile. Anche in questo libro ci sono gli alberi, primo fra tutti il melograno che, in una novella dell’esule irakeno Sinan Antoon, viene irrorato dall’acqua di scolo dell’obitorio.
Il massacro dei gazawi procede in lugubre sincronia con l’accumularsi delle macerie (Caridi propone una stima di oltre cinquanta milioni di tonnellate, nel frattempo la cifra ha superato i sessanta milioni), in un atto di simbiosi estrema fra umano e nonumano. Sudari è un testo militante, che non nasconde la propria natura, ma è nello stesso tempo un appello a superare divisioni e confini. Proprio per questo le parole riferite e le immagini descritte non appartengono solamente alla cultura mediorientale, ma ci riconducono a un contesto che consideriamo familiare e il cui portato profondo abbiamo semplicemente e tenacemente preferito trascurare. E così, nell’apparente rifugio dalla storia offerto dalla Cappella Contarelli nella chiesa romana di San Luigi dei Francesi, Caridi sente affiorare la più razionale e angosciosa delle domande. Delle tre tele di Caravaggio, ad attirare la sua attenzione non è la celeberrima Vocazione di Matteo, né il ritratto centrale, nel quale il santo è intento a scrivere il suo Vangelo. L’istantanea più ossessionante è quella del Martirio, nella quale l’anziano Matteo subisce violenza sotto lo sguardo di una piccola folla attonita e inerte. Tra quegli spettatori colpevoli, Caravaggio ha raffigurato sé stesso. Prima o poi, avverte Caridi, anche noi dovremo ammettere di avere visto il male e di non aver fatto nulla per impedirlo.