Antelme e la distruzione della specie umana
Mai come quest’anno è necessario celebrare il Giorno della Memoria. Mai come quest’anno la ricorrenza è stata così attuale, così significativa, così pregnante. Per molto tempo è stato lecito ritenere che il 27 gennaio fosse una data importante soprattutto per i non ebrei. Alla memoria ebraica, infatti, la Shoah s’imponeva comunque: era a tutti gli altri che conveniva ricordare quanto era accaduto. Erano coloro che per loro fortuna non erano stati toccati da quella tragedia, nemmeno indirettamente, che potevano dimenticarsene – o magari essere tentati di farlo. Ora le cose sono cambiate. Una celebrazione che anno dopo anno rischiava di logorarsi, diventando per molti, specie fra i più giovani, un rituale ripetitivo e privo di mordente, ha riacquistato una bruciante attualità, nel più paradossale e doloroso dei modi.
I tragici eventi degli ultimi ventiquattro mesi hanno messo in evidenza con inedito nitore il divario che sussiste fra due divergenti e non compatibili visioni del Giorno della Memoria. Il politologo franco-libanese Gilbert Achcar (Gaza, génocide annoncé. Un tournant dans l’histoire mondiale, La Dispute, 2025) le ha sintetizzate in due motti. Il primo suona «Plus jamais ça aux Juifs»: mai più questo agli ebrei. Il secondo, semplicemente, «Plus jamais ça»: mai più, a nessuno; mai più, e basta. Da un lato un’interpretazione limitativa, esclusiva e nazionalistica; dall’altro l’interpretazione universalistica, che riguarda l’umanità in quanto tale. Ed è quest’ultima – è quasi inutile precisarlo – l’unica conforme all’insegnamento dei grandi testimoni dello sterminio. Mai ce ne eravamo resi conto tanto chiaramente come oggi, quando lo Stato fondato all’indomani della tragedia della Shoah, e in buona misura proprio a seguito di essa, si è reso responsabile di una guerra che nell’arco di pochi mesi, dopo il 7 ottobre 2023, ha assunto carattere genocidario. Il che significa che nessuno può dirsi immune dai perversi meccanismi mentali che possono produrre i comportamenti mostruosi rappresentati in maniera paradigmatica da quello che fu lo Stato delle SS. I germi della disumanità covano nell’animo di ogni essere umano: contenerli, controllare che non si propaghino e prendano forza, impedire che abbiano il sopravvento, è un dovere perennemente attuale.
Oggi, israeliani e palestinesi (la maggioranza degli israeliani, una frazione comunque determinante dei palestinesi) appaiono accomunati dal reciproco disconoscimento dell’umanità dell’altro. I nemici non sono uomini, sono nemici e basta: dei lutti degli altri non si fa alcun conto. Con la differenza che Israele è un Paese libero e prospero, mentre Gaza, prima della distruzione seguita all’assalto del 7 ottobre 2023, denominato “Diluvio di al-Aqsa”, non meno assurdo che atroce (umanamente atroce, politicamente assurdo), assomigliava a una prigione a cielo aperto. Analogamente, israeliani e gazawi sono accomunati dal fatto di aver scelto di affidare la propria rappresentanza politica alle forze più radicali e intransigenti: da una parte l’estrema destra israeliana, che da sempre persegue la strategia della pulizia etnica nei territori occupati, dall’altra Hamas, movimento islamista che ripudia ogni compromesso e coltiva il terrorismo. Con la differenza che a Gaza le uniche elezioni sono state tenute nel 2005, mentre in Israele, da allora, si è votato nove volte.
Anche in questa luce, rileggere Primo Levi è sempre istruttivo. Nel 1982 l’autore di Se questo è un uomo fu tra coloro che condannarono l’invasione del Libano, e dopo i massacri di Sabra e Chatila chiese le dimissioni del primo ministro Menachem Begin. Non ci possono essere dubbi sul giudizio che avrebbe formulato sulla politica, ben altrimenti spietata e sanguinaria, di Netanyahu. In generale, da tutti i suoi scritti e interventi – in particolare dalle interviste, spesso notevolissime per lucidità ed equilibrio – emerge una visione della vita associata lontana quanto più non si potrebbe dell’attuale recrudescenza del primato della forza bruta sui valori della ragione e del dialogo.
Un’altra buona occasione per ripensare il senso del Giorno della Memoria è offerta dalla nuova traduzione, sempre presso Einaudi, di uno dei classici della memorialistica concentrazionaria, L’Espèce humaine di Robert Antelme, apparso in Francia nel 1947 (lo stesso anno di Se questo è un uomo), e molto apprezzato da Elio Vittorini, che lo pubblicò, sia pur in versione ridotta, nei «Gettoni» (La specie umana, 1954); solo nel 1969 uscì la prima traduzione integrale, ad opera di Ginetta Vittorini. Questa nuova versione è firmata da una traduttrice di vaglia, Stefania Ricciardi, alla quale si deve fra l’altro la proposta per i tipi di Neri Pozza di uno dei maggiori scrittori belgi francofoni contemporanei, Antoine Wauters, e che qualche anno fa si era cimentata con un altro monumento della letteratura dello sterminio, la Suite francese di Irène Némirovsky (Bompiani, 2020). Il volume comprende inoltre tre testi di Antelme legati alla Specie umana finora inediti in Italia, uno storico intervento di Georges Perec, a titolo di Prefazione, il saggio Robert Antelme o la verità della letteratura, sulla cui importanza si era già soffermato Alberto Cavaglion nella prefazione all’edizione einaudiana del 1997, e una dotta e corposa postfazione di Domenico Scarpa, seguita da una ricca bibliografia.
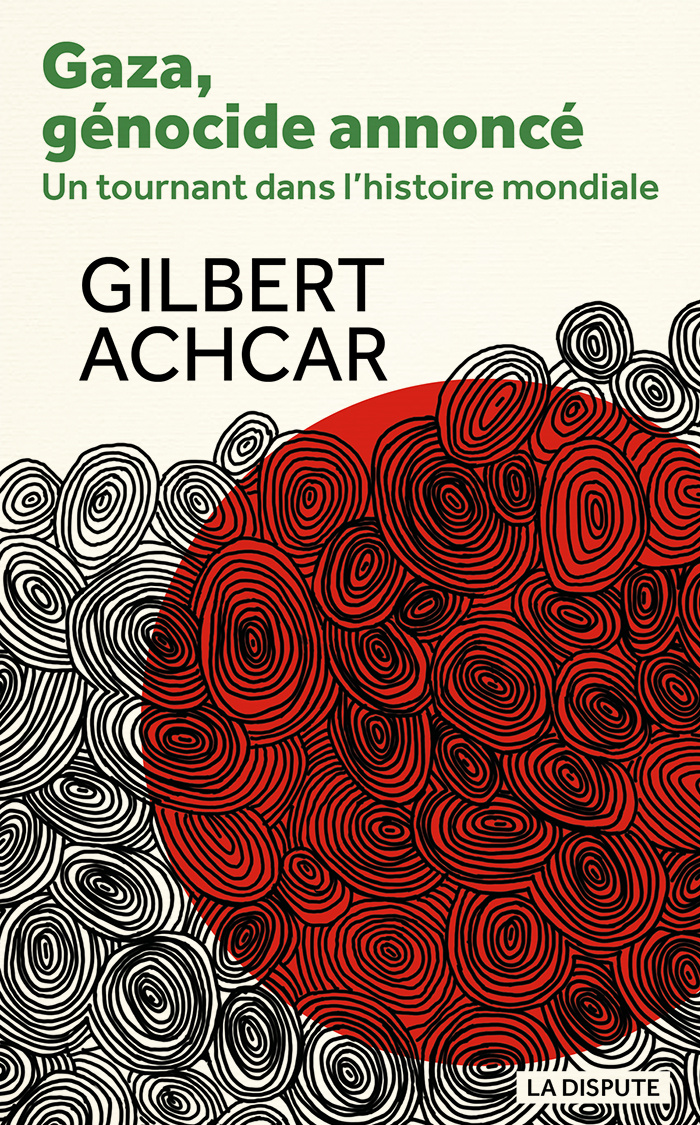
Scarpa inizia tracciando un profilo biografico di Robert Antelme: si sofferma sulla sua formazione, sui suoi rapporti con Marguerite Duras e Dionys Mascolo, sulle modalità della cattura e della prigionia; quindi ricostruisce la genesi della Specie umana e la storia della sua ricezione in Francia e in Italia, analizzando i rapporti fra l’opera di Antelme e le prime, coeve pubblicazioni sui Lager; infine dedica un accurato esame al saggio di Perec (pure tradotto qui in italiano per la prima volta), sottolineandone l’importanza nel contesto della sua carriera di scrittore. Si tratta di un’operazione significativa, anche perché sottrae Perec a un’immagine corrente tuttora un po’ troppo funambolica, un po’ troppo oulipienne. Con validi motivi Scarpa argomenta invece che è proprio il modello dell’Espèce humaine a consentire a Perec di superare l’impasse creativa in cui si trovava all’inizio degli anni Sessanta, quando la letteratura francese gli appariva arenata fra l’esaurimento dell’ottimismo pedagogico dell’engagement e il sostanziale anti-realismo dell’école du regard. Il valore del libro di Antelme consiste in un principio estetico, in una matrice compositiva: «La letteratura, indissolubilmente legata alla vita, è il prosieguo necessario dell’esperienza, il suo esito evidente, il suo completamento indispensabile». In altre parole, scrive Scarpa, Antelme offre «un esempio di dicibilità del mondo»: nato dall’esperienza di una realtà estrema, il suo «è un libro contro l’ineffabile». Non a caso, il titolo provvisorio dell’intervento parlava non di «verità», ma di «nascita» della letteratura (Robert Antelme, ou la naissance de la littérature). Il saggio esce all’inizio del 1963; l’anno successivo l’editore Julliard riceve il manoscritto del romanzo Les choses. La Postfazione alla Specie umana finisce così per trascolorare in un saggio su Perec; interessante, in particolare, una valutazione critica riguardante W ou le Souvenir d’enfance (1975: qui la recensione di Anna Stefi), «che non è il più conosciuto dei suoi libri, ma con tutta probabilità è il più importante, quello che rivela più cose nella sua storia».
Certo, come scrittore Robert Antelme non vale Primo Levi, e L’Espèce humaine non ha la forza stilistica né la profondità di pensiero di Se questo è un uomo. Tuttavia ci sono ragioni che rendono questa lettura, oggi, particolarmente raccomandabile. La condizione di un prigioniero politico a Buchenwald (o a Gandersheim), pur spaventosa, non raggiunge gli estremi di quella di un ebreo ad Auschwitz (o a Monowitz). Ad Antelme non viene tatuato un numero di matricola sul braccio; alla sua esperienza sono estranei sia lo smarrimento di fronte alla babelica molteplicità delle lingue, sia la negazione assoluta della comunicazione; nel campo dove è internato non ci sono le camere a gas. La vicenda che egli narra manca insomma degli eccessi estremi che a volte conferiscono alla testimonianza di Levi un’aura di vertiginosa assurdità (di cui ovviamente l’autore è più che mai consapevole). E tuttavia rimane il resoconto di una persecuzione feroce, sopravvivere alla quale è stata comunque – per riprendere un memorabile understatement leviano – «non piccola ventura».
Molte sono le pagine (per dir così) da antologia, come la descrizione del miserando pasto del prigioniero, con l’inesorabile, sconfortante consumarsi dell’esiguo contenuto della gamella (anche per La specie umana vale la definizione di «libro della fame», data da Cesare Segre a Se questo è un uomo). O il lungo racconto del tormento dei pidocchi, che rende più ripugnante che mai la percezione del proprio corpo. O il raffronto tra cosa significa libertà dentro il campo e fuori: «Laggiù dicono: “Esco”, e scendono le scale, sono in strada. Dicono: “Vado a sedermi”, dicono: “Andiamo a cena insieme”, dicono: “Vado…” e vanno, fanno. “Io” è il pane, il letto, la strada. Qui si può solo dire: “Vado al cesso”. I cessi, qui, sono con ogni probabilità ciò che meglio corrisponde a quello che laggiù si chiama comunemente libertà». O ancora, la rappresentazione dell’eloquio disarticolato e lutulento di prigionieri, sconvolti dalla fatica, dalla denutrizione, dalle percosse, dalle frustrazioni: «Fango, inconsistenza di linguaggio. Bocche da cui non usciva più niente di ordinato né di abbastanza forte da restare impresso. Era un tessuto inconsistente che si sfilacciava. Le frasi si susseguivano si contraddicevano, esprimevano una certa eruttazione della miseria; una bile di parole. Un flusso ininterrotto che mescolava tutto: il bastardo, la moglie abbandonata, la zuppa, il vino, le lacrime della vecchia, il frocio, e via dicendo, la stessa bocca diceva queste parole l’una dopo l’altra. Uscivano da sole, il tizio si svuotava. Solo di notte c’era una tregua. L’inferno dev’essere questo, il luogo in cui tutto ciò che si dice, tutto ciò che si esprime viene sputato fuori indistintamente, come nel vomito di un ubriaco». Leggiamo, nella Nota al testo della traduttrice: «Si è trattato, a ben vedere, di tradurre il linguaggio attraverso la lingua. E il linguaggio del corpo, la postura curva, il decadimento fisico, la lotta contro la negazione dell’essere hanno imposto una lingua spiccia, umile, scarnificata, cruda».
Dal punto di vista della comprensione del fenomeno del Lager, l’aspetto più rilevante di La specie umana consiste nell’illustrazione dei rapporti gerarchici fra i prigionieri, in particolare del rapporto fra i “politici” francesi e i “criminali” tedeschi, ai quali erano riservate le posizioni di comando. Sintomatica è la pervicacia con cui i prominenti respingono tutte le proposte dei prigionieri di migliorare l’organizzazione della vita del campo: il mantenimento del disordine era funzionale all’esercizio della loro autorità, cioè all’esercizio indiscriminato della violenza, che guadagna loro l’apprezzamento delle SS. Non diversamente da Primo Levi, Antelme si sforza non solo di sopravvivere, ma anche di comprendere. A sorreggere il suo impegno testimoniale è una convinzione di fondo: l’empia intrapresa dei nazisti si risolve comunque in un fallimento. «L’uomo può uccidere un uomo, ma non può mutarlo in qualcos’altro». L’umanità è più forte della sua negazione: «Il regno dell’uomo, che agisce o esprime senso, non si esaurisce. Le SS non possono alterare la nostra specie. Sono comprese a loro volta nella stessa specie e nella stessa storia. Tu non devi essere: su questa ridicola volontà di idioti è stata montata una macchina enorme. Hanno bruciato degli uomini e ci sono tonnellate di cenere, questa materia neutra possono pesarla a tonnellate. Tu non devi essere, ma loro non possono decidere, al posto di chi di lì a poco sarà cenere, che lui non sia. Devono tenere conto di noi finché viviamo, e dipende ancora da noi, dal nostro accanimento a essere, se nei momenti in cui ci avranno fatto morire avranno la certezza di essere stati completamente fregati».







