Pietro Grossi, prima persona plurale
“Quando Faust pronuncia le parole, celebri fra i maestri di scuola, ammirate con un brivido dai borghesucci: «Due anime, ahimè, son nel mio petto!» egli dimentica Mefistofele e una folla di altre anime che sono anch’esse nel suo petto”, così scrive Herman Hesse in Il lupo della Steppa e si sbaglia anche il suo protagonista, quando si sente abitato da due anime in conflitto, l’uomo e il lupo, e “già gli pare di avere il petto molto angusto”, ma se “il petto, il corpo è infatti sempre uno, le anime invece che vi albergano non sono due o cinque, ma infinite; l’uomo è una cipolla formata di cento bucce, un tessuto di cento fili”.
“In realtà – sostiene ancora il narratore – nessun io, nemmeno il più ingenuo è un’unità, bensì un mondo molto vario, un piccolo cielo stellato, un caos di forme, di gradi e situazioni, di eredità e possibilità”.
Il protagonista di Qualcuno di noi, di Pietro Grossi (Mondadori, 2025), coincide con il pronome plurale che chiude il titolo e pare volersi inserire nell’eredità di questa intuizione (proprio grazie alla lettura di Hesse, chi racconta arriverà al disvelamento delle sue affollate architetture interne).
La voce che parla è una ma sottende una moltitudine non sempre facile da seguire senza rischiare di perdersi in biforcazioni, nella moltiplicazione dei gesti e degli sguardi che sottende, di scivolare in un’apparente dualità che si scoprirà poi collettivo di voci (quarantadue ne conterà il protagonista, come la risposta fondamentale, un piccolo universo, il mondo vario e caotico teorizzato da Hesse).
Il caos entropico che la prima persona plurale porta con sé (con le sue evoluzioni lungo la storia) è però trattenuto in una rigida struttura a doppia tripartizione; il libro si suddivide in tre parti, ciascuna composta da tre capitoli che segnano le tappe di un percorso di formazione dall’infanzia alla vita adulta, un bildungsroman che attinge generosamente dalla storia di chi scrive.
Quella che si configura apertamente come autofiction, comincia però con la denuncia di una finzione: “Non ci restava che fingere” sono le prime parole del libro e, sin dall’incipit, all’invenzione e alla finzione viene riconosciuto il potere di un atto creativo, generativo, che ha influenza diretta sulla realtà e che sarà poi elaborato nella pratica della scrittura e nell’esperienza letteraria.
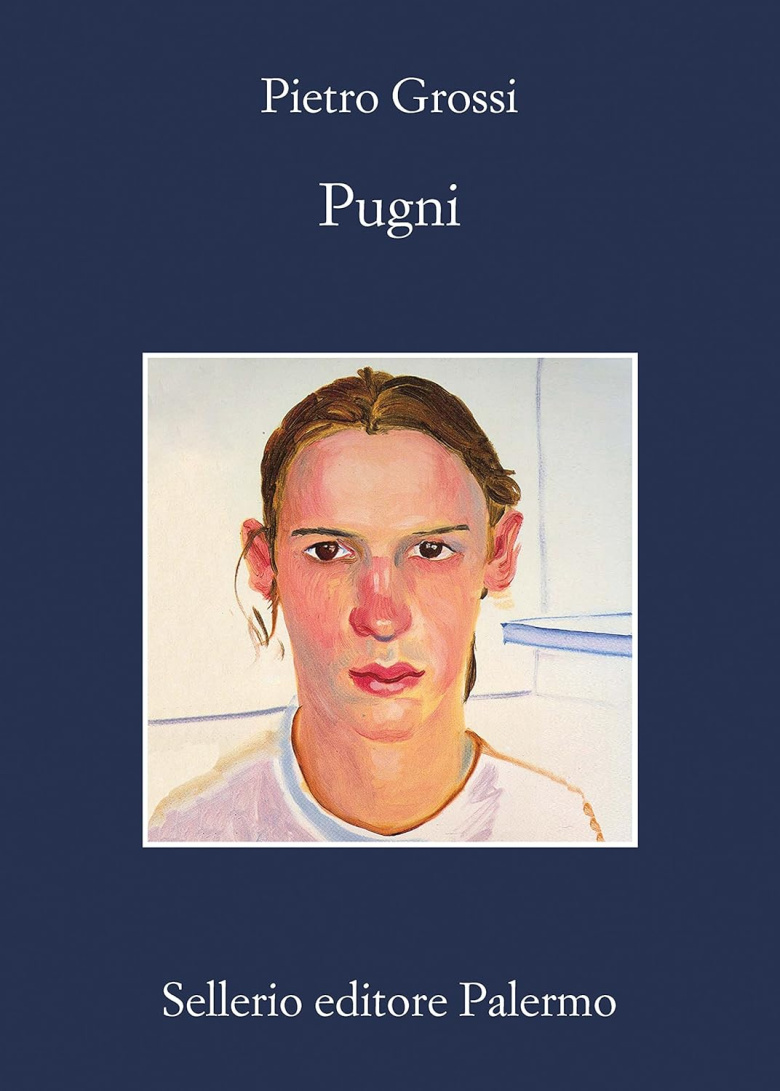
La voce che racconta è un coro già consapevole della sua polifonia interna, ma il bambino di cui si descrivono i primi approcci con la finzione non sa di essere plurale, si crede unico e incompleto, vive un malessere che non sa interpretare, dotato di “una spiccata propensione al ragionamento astratto”, si sente intrappolato in un corpo esile e fragile, dentro il privilegio luminoso di una famiglia ricca e influente, tra giardini, campi da tennis, cavalli, piscine, camerieri, viaggi e “tutta quella smagliante bellezza. Brillava talmente tanto da bruciare. – dice la voce che racconta – Ci avremmo messo molti anni, ma alla fine avremmo imparato anche noi quanto potente fosse. E quanto inadatti ci sentissimo a farne parte, quanta assuefazione desse, quanto spaventose – e magnetiche – fossero le ombre che la circondavano”.
La luce che lo circonda appiattisce i contorni e cancella le sfumature, non lascia nascondigli e per far fronte al malessere che lo attanaglia, sin dall’infanzia, la prima strategia messa in atto sarà appunto la finzione: inventa dolori, sofferenze, afflizioni che attraggono attenzione, sguardi di cura e compassione di genitori, amici, e anche dottori, per i quali diventa “oggetto di test e analisi, in mano a specialisti e attrezzature adatti a scovare nei meandri di noi stessi l’incrinatura che oscurava la nostra esistenza”.
Non si tratta di semplici di invenzioni, ma di “esperimenti di chirurgia plastica della nostra esistenza, talmente ben riusciti da finire per confondere ciò che eravamo e ciò che raccontavamo di essere”, e il confine tra realtà e immaginazione si assottiglia sino a confondersi.
La finzione, nascosta o esibita, come nelle esperienze di recitazione o nella scrittura, sembra ammansire il malessere che lo abita, ma essere visto, acquisire corpo attraverso lo sguardo dell’altro, non basta, torna a pungerlo come un “senso di solitudine. Dei sentimenti che ci capitava di provare, assomigliava più di tutti alla nostalgia […] Questa era una sensazione meno forte, ma più insinuante, e la sua apparente assenza di cause ci turbava”.
L’invenzione delle cause (un forte dolore al fianco, la morte di un amico immaginario…) sembra autorizzare il dolore, ma c’è la luce del paradiso dorato in cui vive che smaschera il gioco e chi scrive si sente sempre più attratto dalle zone in ombra.
Le cerca allora in quella che ai suoi occhi appare come la “losca elettricità della periferia”, con le macchine bruciate, gli avanzi di galera e la scritta a bomboletta sul fianco di uno dei palazzi “Benvenuti all’inferno”: “Eravamo, finalmente, nel luogo di cui ci pareva di aver sentito a lungo i magnetici odori, il luogo capace di strapparci al regno incantato delle nostre ville in collina e dei loro parchi. Ecco cosa avevamo sempre sospettato: che quegli ulivi, quelle margherite, quel profumo di erba appena tagliata, quell’affetto e quella felicità e tutta quella luce fossero in realtà le sbarre della più scintillante e stordente delle gabbie”.
Per abitare quei nuovi spazi senza esserne schiacciato deve prenderne la forma, sperimenta allora il pugilato (oggetto del racconto che dà il titolo al primo notevole libro di Grossi, Pugni, Sellerio, 2006), il combattimento, si lascia percorrere da “quella particolare corrente magnetica, così poco umana, così radicata nelle nostre viscere animali, nelle stesse viscere magmatiche del mondo” e dal grande caos che ne scaturisce. E anche lo sguardo degli altri cambia, vi legge finalmente ammirazione, timore, vi cerca il riflesso della propria straordinaria e spietata forza distruttiva, fino a sfociare in un gesto di violenza incontrollata e a scoprire con sgomento “quanto fragili e impercettibili siano le deviazioni che determinano le nostre esistenze, […] fino a che punto fossimo in grado di compromettere l’esistenza nostra e di chi ci circondava”.
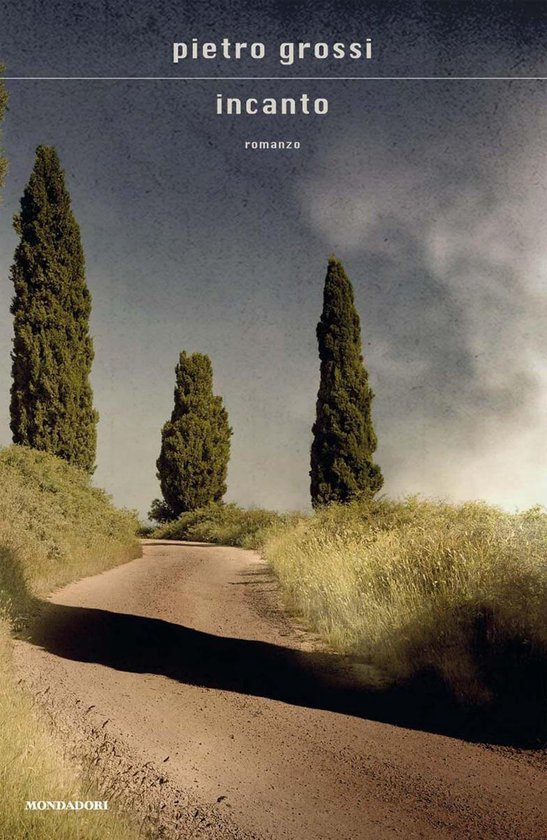
Ma è ancora dentro “il luogo protetto della gioventù”, nella gabbia da cui crede di fuggire, che c’è anche il riparo e il privilegio di commettere errori senza essere annientati dalle conseguenze.
Costeggia allora altri confini, sperimenta ogni tipo di droga ed esplora stati di alterazione della coscienza in cui il buio si riempie di uno sfrigolare di colori, si spalancano dimensioni nuove, dove il mondo si dissolve in scintille e la morte è una soglia da cui sbirciare, un crinale su cui misurare il desiderio di gettarsi oltre e la vertigine di caderci dentro (“non l’avevamo soltanto varcato, il nostro confine, avevamo spiccato il volo ed eravamo planati sulle sue distese. Tutto il resto, al confronto, appariva grigio e ridicolo”).
Il libro dà conto di questo moto costante, dentro e fuori, nelle esplorazioni lisergiche e negli innumerevoli viaggi per il mondo (“dal finestrino di un sedile in prima classe, però”), nell’accumulo di esperienze senza sedimentazione, in tutto l’affanno della “orrenda, sanguinosa, interminabile battaglia tra la vita vissuta e la vita immaginata” e nel corteggiamento della morte, refrain che ritorna costantemente, il rassicurante miraggio della fine di quel vorticare.
Ma l’accelerazione non porta in nessun luogo e la vita, a un certo punto, chiede di fermarsi, di costruire, di scegliere, costringe allora a guardarsi dentro e a fare i conti con sé stessi, “Cercavamo, come ognuno con fatica, di capire chi eravamo, di collocarci, e tutte quelle invenzioni erano entrate talmente a fondo nella nostra vita da scombinare la percezione di noi stessi”.
Arriviamo dunque nella seconda parte del libro, quella dei cantieri e delle prove, la parte del “fare”, che implica scelte e rinunce e l’insidia del libero arbitrio, che pesa tanto più quanto più il ventaglio delle possibilità è esteso (“la tragedia è che la scelta ce l’abbiamo e il problema non è la strada che scegliamo, ma la logorante consapevolezza di tutte le altre che non abbiamo imboccato”).
È proprio qui, quando lo sforzo letterario incontra il successo, il lavoro si concretizza, si solidificano le fondamenta di una relazione e la possibilità di una vita in cui realtà e sogno arrivino a combaciare sembra realizzabile, che affiorano contraddizioni, dilemmi e ostacoli e il moto interno si traduce in parole. Quelli che punteggiavano la trama della storia come corsivi sparsi si fanno dialoghi, battibecchi, chiedono udienza, si staccano dal mormorio di sottofondo come personaggi di una ciurma scomposta e disordinata e prendono nomi, storie, parola.
Nei loro discorsi, nelle polarizzazioni, nell’alternarsi del comando, dapprima accidentale, poi sempre più consapevole, chi narra rintraccia i fili che hanno tessuto la propria vita, le deviazioni, le accelerazioni, gli stalli, le derive.
“È talmente ovvio.
Siamo sempre in movimento.
Dondoliamo.
Le raffiche.
Le tempeste.”
[…]
“Noi non viviamo.
Filtriamo.
Diosanto, è così vero.
Filtriamo? Ma che cazzo vuol dire “filtriamo”?
Andiamo a giro a fare i sacerdoti della vita...
Vivi, vivi, vivi, vivi...
Ma tutto ciò che siamo in grado di fare è starcene chiusi in una
stanza a filtrare tutto attraverso quei dannati fogli di carta.
Scappiamo, scappiamo di continuo, da sempre.
Con le nostre invenzioni.
Con i cazzotti.
Con le droghe.
Con i viaggi.
Con i libri.
E mentre lo facciamo ci diciamo anche che invece stiamo vivendo.”
Per chi racconta diventa improvvisamente manifesto come, nei diversi momenti della sua vita, a turno i personaggi che lo abitano abbiano governato la nave, meno chiaro è chi abbia tracciato la rotta e verso dove fosse puntata.
Alle domande che si generano da quella moltiplicazione di senso l’equipaggio restituisce riposte sempre uguali, ognuno con il suo credo che non muta: non c’è stratificazione ma schiera, giustapposizione di caratteri che insieme compongono un noi molteplice ma invariato.
E si sente come un’inerzia dietro l’imperativo di vivere, di rispondere all’angoscioso senso di esaurimento della vita con l’accumulo (“tutto ciò che ho sempre cercato di fare è tentare di riempire la vita, come un uovo”), ciclicamente tornano gli stessi motivi e la nave sembra non levare mai l’ancora, scossa solo dalle maree, dalle tempeste e dalle forze che le si muovono intorno.
Così si finisce per tornare dove si è cominciato, con la sensazione che nulla si sia mai veramente spostato e che la soluzione suggerita, dopo tanto cercare, stia forse nel fermarsi, far spazio all’affollamento che ci abita, impostare il timone a vento e dargli fiducia.







