Le metamorfosi dell'immaginario fantascientifico
Saranno i conclamati propositi di Elon Musk di sbarcare presto su Marte o gli infiniti commenti sull’Intelligenza Artificiale, ma la fantascienza vive attualmente uno dei suoi periodi di successo, o, per lo meno, gode dell’attenzione di editori, recensori, giornalisti. Intendiamo la fantascienza e le sue varianti, che è possibile raccogliere sotto l’ombrello di un genere narrativo sempre fluido, nel cui range troviamo la distopia (molto di moda, soprattutto nella versione femminista), il racconto della catastrofe ecologica o Cli-Fi, la fantapolitica (come sempre avviene, superata dalla ferocia imprevedibile degli eventi storici), le contaminazioni tra space opera e fantasy (al cinema Dune di Villeneuve) e, last but not least, l’ucronia, che, con i suoi universi paralleli, si interroga sulla casualità di certi episodi cruciali. Cosa sarebbe successo, il 13 luglio 2024, se a Butler, Pennsylvania, l’attentatore Thomas Matthew Crook (il cognome sembra inventato da Dickens) fosse stato arrestato dalla polizia prima di sparare a Trump? E se l’allora candidato repubblicano alla Casa Bianca fosse rimasto ucciso? E, soprattutto, se Trump non avesse trasformato quel momento drammatico nella apoteosi di un Cristo risorto, immortalata dalle fotografie di Evan Vucci?
L’interesse per la fantascienza non si limita al nostro paese. Nel numero del 14 aprile di quest’anno, ad esempio, il New Yorker ha pubblicato, a firma di Elif Batuman, un lungo saggio basato sull’intervista alla scrittrice giapponese Sayaka Murata, che prende in considerazione il suo ultimo romanzo, Vanishing World (in Italia anche le edizioni e/o utilizzano il titolo inglese). Il titolo del saggio è “The Alien World”, e il sottotitolo “Sayaka Murata sees the ordinary world as science fiction.” (“Murata il mondo di tutti i giorni come fantascienza”). Nella nostra cultura, in questo campo, ancora un po’ provinciale, si punta ancora sulla ricostruzione della storia della fantascienza in chiave evoluzionistica. “La fantascienza non è più quella di una volta”, titola, intendendo che oggi è molto meglio di prima, un articolo di Vittorio Giacopini apparso sul Venerdì di Repubblica, che recensisce Il grande libro della fantascienza. Dalle origini del genere ai nostri giorni di Sebastiano Fusco (Mondadori Electa). Aldilà dell’indiscussa competenza di Fusco, la parte più interessante del libro riguarda la corrispondenza che Fusco ebbe a suo tempo con Philip K. Dick, il cui ricco epistolario è ancora ignorato nel nostro paese. Più che di stabilire graduatorie o di raccontare pur gradevoli aneddoti, abbiamo bisogno di lavorare sulle fonti, di consultare gli archivi (laddove esistono), di misurarci con un metodo critico che superi l’elencazione cronologica o la compilazione divulgativa, e di mettere da parte un approccio dilettantistico che celebra puntualmente il “coming of age” della fantascienza del presente a spese delle varie forme dell’immaginario scientifico del passato. Il “coming of age” della fantascienza è già avvenuto subito dopo la fine della seconda guerra mondiale con Asimov, Bradbury, Clarke, e si è ripetuto decennio dopo decennio, mentre passiamo a J.G. Ballard a P.K. Dick, da Stanislaw Lem a Octavia Butler e a Ursula K. Le Guin, per arrivare a due autori ancora viventi: Cixin Liu e Ted Chang. Paradossalmente, potremmo anche affermare che, nella sua componente distopica, il decennio più letterariamente significativo si colloca in Inghilterra negli anni ’30 del Novecento, grazie alla ricchezza immaginativa di romanzieri e romanziere come Olaf Stapledon, Aldous Huxley, l’ultimo H.G. Wells, Katherine Burdekin e Storm Jameson. Intanto negli Stati Uniti cominciava a scrivere una certa Ayn Rand, di origine russa, ferocemente anti-comunista. E se volessimo retrocedere alla fine dell’Ottocento quando H.G. Wells pubblica i suoi primi, rivoluzionari, scientific romance, ammirati da Joseph Conrad, un altro romanziere alle prime armi, mentre Jules Verne si dedica ad alcune delle sue opere più inquietanti? Insomma, potremmo rovesciare il paradigma evoluzionista in uno straordinario ritorno alle origini, risalendo ancora più indietro al gotico di Mary Shelley (non solo Frankenstein, anche L’ultimo uomo), e sempre più indietro, alla satira dell’utopia, dello scientismo, e del razionalismo che informa il capolavoro dei Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift (1726).
Riguardo ai diversi percorsi della fantascienza, ovvero della narrativa dell’immaginario scientifico, il lettore italiano ha la fortuna di scoprire l’esistenza di due interpretazioni divergenti nella versione delle Metamorfosi della fantascienza (Metamorphoses of Science Fiction) di Darko Suvin pubblicata da Il Mulino nel 1985.
In quel testo critico ancora fondamentale, lo studioso della McGill University compie un viaggio vertiginoso che comincia nell’antichità con la letteratura dei viaggi immaginari, si concentra sull’utopia rinascimentale, passa da Swift all’Ottocento romantico di Mary Shelley, poi a quello tardo-vittoriano di H.G.Wells, fino ad approdare al Novecento, in nome di una concezione della fantascienza come narrativa del novum cognitivo, regolata dai meccanismi dello straniamento e dell’analogia, escludendo le derive futurologiche e la banalità di una vocazione pedagogica. E tuttavia, nella Prefazione dello stesso volume di Il Mulino, Oreste Del Buono contesta l’impostazione suviniana, riconducendo la science-fiction alla cultura di massa novecentesca, ai pulp magazine americani e alla loro proiezione giovanilistica e sensazionalistica. A distanza di tanto tempo, possiamo affermare che Suvin e Del Buono si muovono su due piani contrastanti, ma entrambi ricchi di implicazioni stimolanti: Suvin rivendica la qualità letteraria e la forte spinta conoscitiva della science-fiction, tanto da ridurre fortemente il peso della componente gotica e fantastica, facendo torto, a parere di chi scrive, soprattutto all’impatto delle short story di E.A. Poe, mentre Del Buono ha capito le potenzialità della fantascienza nell’arena sterminata dei mass-media. Non è un caso che egli scriva la sua Prefazione all’inizio degli anni ’80 del Novecento, quando la fantascienza rinvigorisce la tradizione dei comics, sia nella versione DC che in quella Marvel, e si trasferisce sul grande schermo nei cicli cinematografici di Alien, di Ritorno al futuro, di Terminator, oltre che in alcune opere di John Carpenter (1997: Fuga da New York, 1981 ) e di Stephen Spielberg (E.T.1982 ) e soprattutto in Blade Runner di Ridley Scott, uscito nel 1982, l’anno della morte di Philip K. Dick, il suo ispiratore. È pur vero che un altro momento d’oro per la fantascienza extra-letteraria si era situato negli anni ’60, durante l’“Era Marvel” di Stan Lee, iniziata nel 1961 con il lancio dei Fantastic Four, e grazie alla trasmissione, avvenuta tra il 1966 e il 1969 sul piccolo schermo delle prime tre serie di quell’unicum che è stato Star Trek, che certamente merita un discorso a parte. Nel 1968, un anno prima dell’allunaggio di Neil Armstrong, Stanley Kubrick aveva finito di girare 2001: Odissea nello spazio.
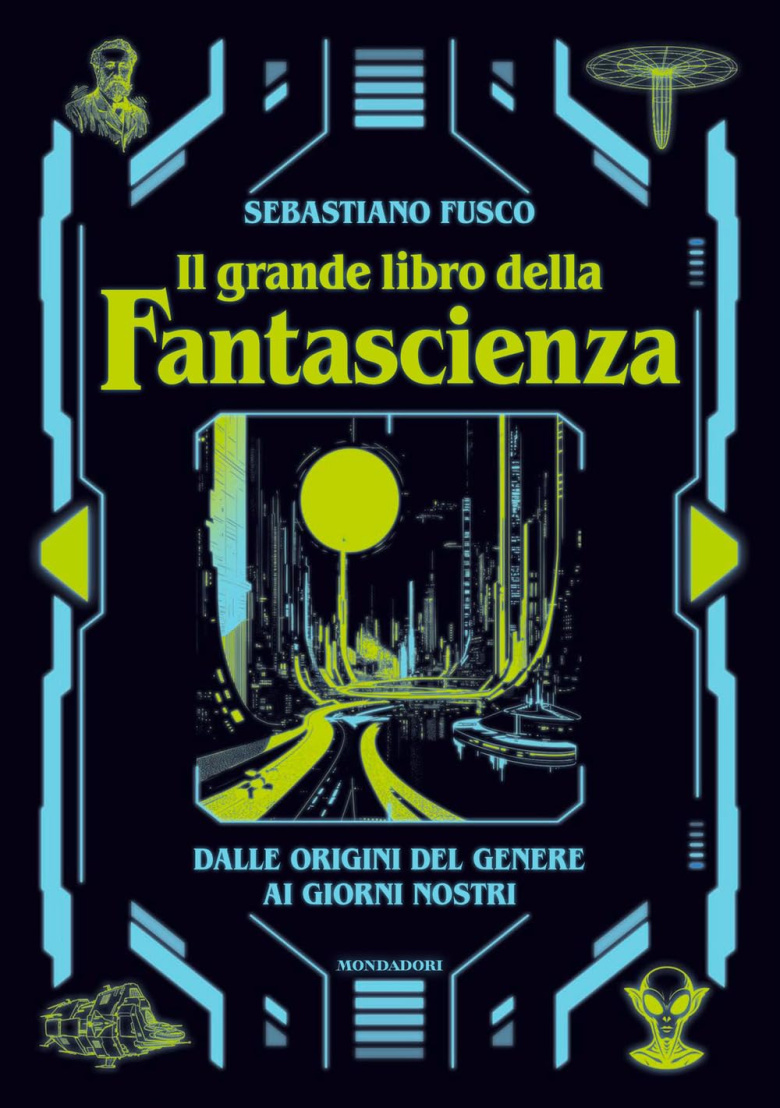
Personalmente, sono dell’idea che la fantascienza moderna, pur con tutte le radici dissotterrate da Suvin, conosca il suo periodo di incubazione nella seconda metà dell’Ottocento, quando la rivoluzione epistemologica operata da Charles Darwin e dai suoi seguaci stravolge i parametri scientifici, ma anche letterari, del passato spalancando la porta a una nuova visione della geologia e dell’astronomia, dell’antropologia e della biologia. In fin dei conti i primi romanzi di Wells, da La macchina del tempo (1895) in avanti, possono essere definiti “favole darwiniane”, ricche di stimoli intellettuali, ma anche capaci di rivitalizzare il genere del romance, iniettando nel realismo ottocentesco una carica visionaria e apocalittica. Un utile contributo all’esplorazione della cultura del positivismo, sia pure limitatamente all’Italia, è il recente studio di Lorenzo Benadusi Il mondo che verrà. Gli italiani e il futuro (Laterza), corredato da un bel repertorio di illustrazioni. Giustamente Benadusi si avvale del più ampio studio di Stephen Kern Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento (Il Mulino 2007, in origine The Culture of Time and Space, 1983), ma poi scova nel nostro paese i segni più stimolanti di un immaginario avveniristico, di cui si nutrono autori come Yambo (Enrico Novelli) e lo stesso Emilio Salgari, che nel 1906 pubblica il romanzo fantascientifico Le meraviglie del Duemila. A questo romanzo Benadusi dedica pagine divertenti e dense di riferimenti alla cultura italiana del primo Novecento, mettendo in luce, qui come altrove, l’esistenza di un territorio europeo dell’immaginario che faceva capo a Verne e a Wells, e che anche in Italia ha dato frutti significativi, seppure molto marginali rispetto ai percorsi più nobili della letteratura italiana. Se un appunto si può fare a Il mondo che verrà, esso consiste nella scarsa attenzione rivolta alla presenza di Darwin e delle sue idee nel nostro paese. Darwin ebbe in Italia seguaci ed estimatori autorevoli, tanto che nel 1864 – cinque anni dopo l’uscita dell’edizione originale – venne tradotta L’origine delle specie e nel 1875 “Carlo Roberto Darwin” fu eletto socio straniero della Reale Accademia dei Lincei. D’altra parte, merito di Benadusi è anche quello di condurre i suoi lettori fino all’epoca del fascismo, mostrando come la nuova ideologia totalitaria coltivasse fantasie futuristiche: “Il fascismo, dunque, come Giano bifronte con uno sguardo indietro e uno in avanti”.
Che la fantascienza abbia una natura metamorfica e sappia insinuarsi nelle forme più svariate della cultura contemporanea è fuor di dubbio, tanto da stimolare la ricerca di chi si occupa di cultural studies o di visual studies è fuor di dubbio. Uno stimolante contributo in questa direzione come in quella dei gender studies è offerto dal recente volume di Giulia Martino e Francesco Toniolo Playher. Rappresentazioni femminili nei videogiochi (Edizioni Tlon). Si tratta di un’opera di ricerca, che evita le sabbie mobili delle promozioni pubblicitarie, per affrontare una serie di problematiche inerenti alle strutture del linguaggio niente affatto banale dei videogiochi e che si concentra su alcuni personaggi femminili, come scrivono i due autori nell’Introduzione, “Alcune vivono ai margini, altre al centro di universi narrativi che si interrogano sul potere, sul capitalismo, sull’identità, sul corpo, sullo sguardo. Figure complesse che aprono spiragli inattesi su temi profondi come la maternità, la memoria, la predestinazione, la ribellione e la trasformazione.”
La trasformazione, la metamorfosi… torniamo al nocciolo della questione, alle strutture che sottendono all’immaginario scientifico, alla sua sostanza metanarrativa, che riorganizza l’attraversamento del territorio, anch’esso non certo granitico, della scienza e delle tecnica su cui è stato eretto il mondo moderno e quello contemporaneo, in fiction, in romance (nel significato che a questo termine danno gli studiosi del romanzo anglo-americano o il grande critico canadese Northrop Frye), nel racconto di un’esperienza individuale o collettiva, in cui si mescolano stupore e paura dell’ignoto, fascinazione e terrore del futuro.
In copertina, opera di di Simon Stålenhag.
Leggi anche:
I precedenti articoli di Nicoletta Vallorani
Niccolò Scaffai | Ecologia e fantascienza / Jeff Vandermeer e la misteriosa creatura di Borne
Adele Errico | Il mondo secondo Philip K. Dick
Alberto Mittone | Che cosa è reale? / I mondi di Philip K. Dick
Alberto Mittone | Lino Aldani, maestro di fantascienza







