Stupore e impossibilità di William T. Vollmann
Roger Caillois, in Pierres (Gallimard, 1966), descrive un viaggio immaginario in un geode: la piccola pietra da tavolo, quasi un fermacarte del quotidiano, diventa un viaggio verniano al centro della Terra. In quella che Gaston Bachelard chiamava la fenomenologia del nido e della conchiglia, la mente immaginante si miniaturizza, si incista nell’inabitabile, e trasforma l’esperienza del minuscolo in immensità. Questo accade al lettore di L’atlante di William T. Volmann (minimum fax, 2023), un libro che è una Wunderkammer di frammenti geografici, di metonimie terrestri in un multiverso fisico e psichico. Ma non basta. Questi frammenti cristallini, questi ciottoli e schegge, da coacervo di detriti scritti, assumono un ordine geometrico, come tessere e perline tra gli specchi di un caleidoscopio. L’autore raccoglie, riordina, organizza in movimento palindromo i pezzi, stabilisce echi interni, attiva richiami a distanza, simmetrizza, e al tempo stesso sabota tutto (struttura e funzione). Così, se chiede convenzionalmente a chi legge di tenere il volume sul comodino e di esplorarlo senza un ordine particolare, lo invita poi a una sacra dissacrazione: “Nascondilo sotto il sedere quando darai inizio ai piaceri notturni. Ammazza le orride mosche del sonno con la sua copertina rigida. Appoggialo sugli occhi per ripararti dalla luce. E che la tua anima volteggi libera su quel mondo!” (pp. 17-18). Un libro-mondo, appunto.
Per il lettore, che riconoscerà tra queste pagine tutti i semi, i tuberi e gli innesti della produzione futura di Vollmann, L’atlante si compone di prove di reportage, narrazioni punteggiate, abbozzi di racconto, lampi di diario radicati in un’isola temporale piuttosto distante, tra il 1982 e il 1995, con un campionario del mondo fatto di 130 geositi verticali e orizzontali, materiali e mentali, realmente calpestati o generati dalla visione, per un libro tradotto in italiano ventisette anni dopo la sua uscita. Leggerlo oggi, però, non è fare archeologia di una grande mente letteraria, è praticare l’antropologia di un’anima, un’anima che, come avrebbe detto Artaud, brucia domande di vita:
Si sarebbe fermato? E le zanzare, avrebbero lasciato lei per lui, in quell’unico barlume della sua divinità? E lui, dopo, avrebbe proseguito in silenzio, seguito da nugoli inimmaginabili di nero ronzante? E lei, sarebbe caduta in ginocchio ringraziando Dio di averla salvata? Oppure non si sarebbe proprio fermato, continuando a marciare con disprezzo, ignorando il bisogno di quella donna come aveva ignorato il mio dono, rimpicciolendo nella stessa maniera sul rettilineo disumano di quell’autostrada? (p. 75)
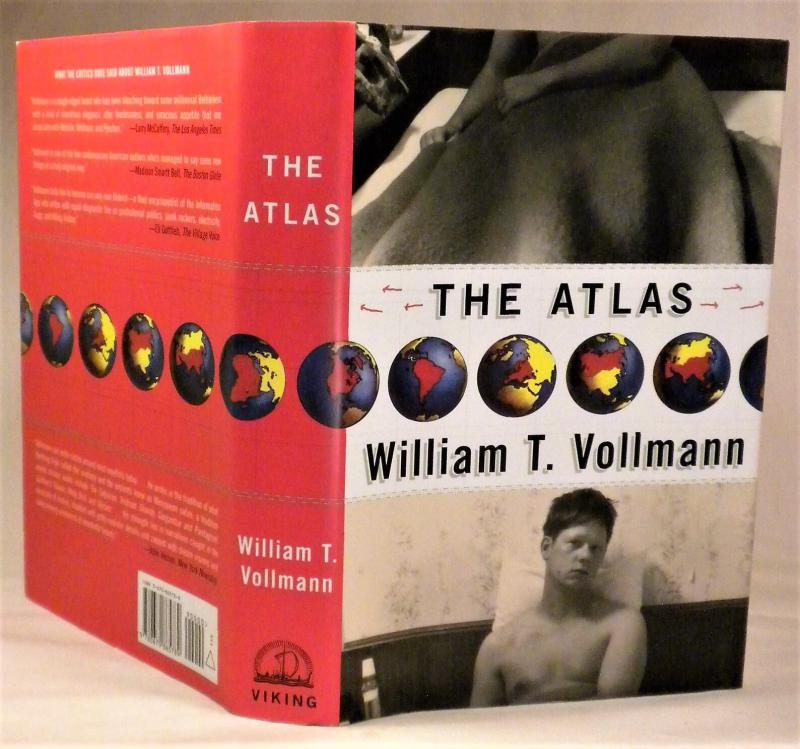
Geografo, antropologo, geoantropologo, Vollmann porta sulle spalle uno zaino di domande così voluminoso da sviluppare un metodo totale, una ricerca sul campo estrema, fatta di corpo implicato selvaggiamente e teneramente in prima persona, di movimento asintotico verso un centro che perennemente si sposta, di proiezioni empatiche al limite del delirio dissociativo, di metamorfismo percettivo, prospettico, stilistico. Come un’ars poetica di chi Vollmann è e sarà come scrittore, L’atlante non funziona come un semplice apparecchio di cattura di luoghi, cose e persone, ma è un manuale narratologico per uso privato, una macchina di moltiplicazione potenziale dei discorsi. Se dunque la prima impressione è quella di un viaggio intorno al mondo in tredici anni, quello che può e deve restare è un’ipotesi di vita che, se pure al ribasso, ognuno di noi (scrittori e non) dovrebbe fare propria, per non rassegnarsi al monologo esistenziale, alla condanna dell’ordinario. Perché Vollmann è una specie di angelo caduto ed esploso, un divoratore bulimico di ecceità, uno sciame incontinente di personalità possibili, e un geniale nerd che, quando scrive facendo Vollmann, lo fa meglio di Vollmann.
Nella pépinière letteraria della Penisola Qualunque, dove il caviale metafisico di un McCarthy, di un DeLillo o di un Vollmann diventano uova di lompo a 60 euro al chilo (con le dovute eccezioni, certo, che un giorno, all’improvviso, si paleseranno come folgorazioni elettriche), L’atlante è un libro che si rivolge a una nicchia quattrogattesca, quella che ancora sa riconoscere la bellezza di chi è veramente bello, la bravura di chi è veramente bravo, pur non avendo né bellezza né bravura. Ci vuole molto coraggio e un certo senso della vergogna, insomma, per parlare di Volmann. Per quanto mi riguarda, l’unico modo di farlo è guardarne il profilo con visione periferica, concentrandosi sui margini, astenendosi dal fissare il nucleo (radioattivo). Nell’impossibilità di dire la sua umanità francescana e libertina, nello stupore per un ibrido teriomorfo in bilico tra Amiel e Lovecraft, mi limito qui alla sua “territà”, al suo modo di vedere il corpo terrestre e al senso che questa visione sfrangiata può avere per noi:
Il fiume si cosparse subito di squame di luce. Gli alberi tremarono nei vasi. Con un brivido, la ragazza giapponese alzò gli occhi spazientiti, battendo i piedi a braccia conserte. Era notte alla panca con le teste di leone. Le lanterne illuminavano le statue. Le fronde delle palme cigolavano come molle di un letto. Alzando lo sguardo su di loro, lui dimenticò immediatamente la ragazza, ipnotizzato dai cenni di quelle teste tristi e folli, da quelle tenebrose zampe di ragno flosce e malate che si agitavano, impalate ai loro tronchi ondeggianti, accarezzandosi perfidamente a vicenda mentre le tende si leccavano dai balconi illuminati. (pp. 42-43)
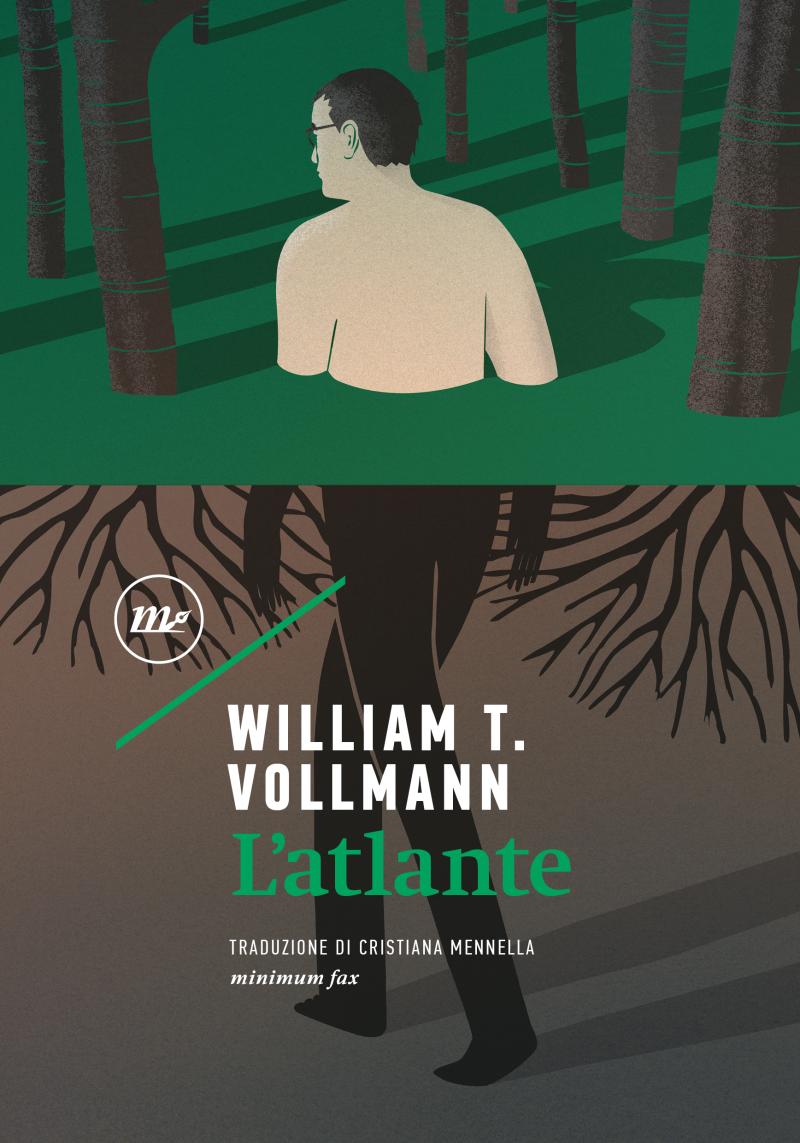
Il terreno ripido friggeva di linfa nell’aria verde faggio. L’edera cresceva sulle schiene degli alberi, fingendo di aiutarli con false vertebre verdi mentre gli succhiava le energie. Vivere significa sforzarsi come l’edera e soffrire come gli alberi. Morire unisce entrambi gli elementi in una penosa lotta. La vegetazione lo sentiva? Dicono che le piante e gli schiavi non sentono. (p. 484)
Alle undici di mattina il mondo era azzurro, bianco e perfetto, con la chiarezza della neve abbondante – la reificazione di un ideale estremo. Tutta l’isola, vasta e, rispetto ai climi temperati, quasi senza vita, era in effetti un pianeta a sé stante, basso, azzurro, bianco e marrone, spesso l’orizzonte era rasoterra, e il cielo quindi ovunque. Il regno delle forme platoniche poteva essere così. Mi sembrava di vedere solo spazio solidificato senza un predicato. Era una pagina bianca piena di possibilità, bellezza e terrore compresi. (p. 160)
Conosceva una grotta con il pavimento di sabbia. Corse lì senza sapere perché. Acqua nerissima scendeva trascolorando al verde mentre formava pozze gorgoglianti abbastanza vicine all’entrata da riflettere la giungla, dove uccelli dalla coda nera e arancione stavano appesi ai rami come baccelli. I rami più ampi ornati da festoni di rampicanti sembravano frecce piumate. Alle loro spalle, nell’aria fresca e viziata della grotta, grappoli di stalattiti calcaree pendevano come mucchi di panni stesi. (p. 427)
C’era una lunga pianura verde chiaro con alberi verde scuro sormontati da forme oblunghe, e poi lontano una lama di montagna celeste, trasparente come il vetro di una chiesa. Le nuvole macchiavano la pianura di striscianti ombre smeraldine. L’erba era glassata di infruttescenze. Alberi bassi e verdi splendevano di spine bianche. Un leopardo stava su un albero come una massa di stelle nel buio muscolare. (p. 231)
Hawaii. Svizzera. Ellesmere. Belize. Kenya. Ma ci sarebbero anche Jugoslavia, Cambogia, Egitto, Italia, India, Messico, Australia, Giappone. E poi ancora il doppio di altrettanti luoghi che funzionano come giardini di Babilonia e come orifizi tripofobici. Tutto molto “esotico”, “evocativo”, “pittoresco”, sì, ma il punto è questo: da una pragmatica intuitiva può nascere sempre una teoresi, dall’evenemenziale si può estrarre un paradigma, dall’esperienza paesaggistica può scaturire una mitopoiesi terrestre. Quello che fa Vollmann con i luoghi che visita (e dai quali si lascia visitare) è la fondazione da zero di un geo-immaginario ultimo. E perché può avere senso per noi? Perché in epoche di disgregazione e collasso è sempre dalla Terra che la nostra specie è ripartita per pensarsi al di là della faglia. Anche in letteratura: tra bordelli, deserti, coste, geologie, invasioni vegetali e fantasmi di persone e di città, l’unico libro che mi viene in mente per pensare L’atlante di Volmann è i Canti Orfici di Campana. Non è importante declinare qui l’intuizione, non ha senso immaginare adesso due vite parallele o addirittura fare esercizi di letteratura comparata fuori da un’aula. Ancora una volta, il nesso, il ponte, è un’antropologia radicale dei luoghi ultimi. Che si conoscono per intuizione e corpo e pensiero come si conosce l’amore, come si accoglie la morte:
La Donna Salice gli rotolò sopra e lo prese tra le braccia. Lo cullò facendolo addormentare. Niente più da nessuna parte nessuno. Lo coprì come un manto di foglie e lo tenne ancora più al caldo. Lui si trovava al centro intorno al quale il mondo girava, girava, senza fermarsi mai. (p. 322)







