Arché: inventare la speranza
Per il nono appuntamento della rubrica bimestrale di conversazioni psicosociali, ho incontrato padre Giuseppe Bettoni a Novate Milanese, presso la sede della Fondazione Arché e di Casa Arché, da lui fondate e guidate negli ultimi trentacinque anni. Padre Bettoni iniziò nel 1989 a occuparsi della tossicodipendenza giovanile a Milano, per poi concentrarsi sui bambini sieropositivi. Nel 1991 nacque ufficialmente l’associazione Arché, con la missione di “inventare la speranza ogni giorno” per bambini e famiglie. Nel 1997 fu inaugurata a Milano la prima Casa di accoglienza, e dopo i primi anni Duemila, con l’emergenza sanitaria ridotta dalle terapie antiretrovirali, Arché ampliò il proprio impegno a sostegno di unità madre-bambino in difficoltà psicologiche e sociali. Nel 2013 l’associazione è diventata fondazione, continuando a promuovere autonomia sociale, abitativa e lavorativa dei più vulnerabili.
Sono andato a trovare padre Bettoni perché, durante l’invasione russa dell’Ucraina, lo avevo intervistato e lui aveva definito la guerra una “bestemmia”. Oggi, dopo la pubblicazione di quell’intervista nel mio libro scritto con Ludmilla Ostermann, War as Reset (Routledge, 2025), ho voluto incontrarlo di nuovo per capire cosa sta accadendo e riflettere su cosa ci attende.
Padre Giuseppe, come descriveresti ciò che sta accadendo oggi? In quale epoca stiamo vivendo?
Papa Francesco ha proposto una distinzione illuminante: non stiamo vivendo un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca. Non è solo semantica, ma concettuale e storica. Un’epoca di cambiamenti suggerisce un’evoluzione progressiva, per quanto rapida; un cambiamento d’epoca implica invece una discontinuità netta, una frattura profonda rispetto al passato recente. È come trovarsi su un crinale, davanti a un panorama nuovo e incerto.
Guardando all’Occidente, il secondo dopoguerra ha rappresentato decenni di espansione, fiducia e costruzione. Dal 1950 in poi, il progresso scientifico e tecnologico, lo sviluppo economico, la democratizzazione crescente e la convinzione che il futuro potesse solo migliorare hanno segnato la vita sociale. Diritti civili e sociali si sono ampliati, il benessere ha raggiunto ampie fasce della popolazione, e la pace, almeno in Europa, è sembrata stabile.
Negli ultimi anni, però, questo modello mostra crepe sempre più evidenti. Non si tratta solo di decrescita economica, ma di decrescita valoriale e identitaria. Le certezze acquisite – democrazie liberali solide, centralità dei diritti umani, coesione sociale, fiducia nelle istituzioni – sono messe in discussione. La globalizzazione ha portato opportunità, ma anche disuguaglianze, precarietà e marginalizzazione. Nuove sfide planetarie – cambiamento climatico, migrazioni, trasformazione digitale, intelligenza artificiale – sconvolgono equilibri politici, economici e culturali.
Crescono populismi, sovranismi e nazionalismi. L’Europa, potenziale modello di integrazione, appare spesso paralizzata da interessi contrapposti, incapace persino di dotarsi di una Carta costituzionale comune. Nel mondo si riafferma la logica dell’egoismo nazionale: ogni Stato pensa a se stesso, mentre la salvezza collettiva sembra subordinata a quella individuale.
Siamo, dunque, in una crisi profonda.
Sì, ma è importante ricordare che la parola “crisi” deriva dal greco antico krisis, che significa "scelta", "giudizio". Quindi ogni crisi può diventare anche una possibilità, un’occasione di discernimento e ripensamento. La posta in gioco è alta, e l’alternativa che si presenta davanti a noi è piuttosto netta: possiamo chiuderci in noi stessi, nelle nostre paure e nelle nostre identità frammentate, oppure possiamo immaginare e costruire nuove forme di convivenza, fondate sulla solidarietà, sulla giustizia, sul rispetto della dignità umana e sul senso di responsabilità globale.
In definitiva, l’epoca che stiamo vivendo è fragile, contraddittoria e complessa, ma è anche ricca di opportunità. Come ogni svolta storica, essa ci interroga sul nostro modo di vivere, di pensare, di abitare il mondo. E ci chiede di scegliere, di prendere posizione, di assumere un ruolo attivo nel disegno di un futuro che sia davvero umano e sostenibile per tutti.
Cosa significa per te anima?
L’anima, nella sua etimologia greca – anemos, “vento” – è ciò che soffia dentro di noi, ciò che ci fa vivere, che ci anima. È invisibile, impalpabile, ma profondamente reale. Come il vento: non lo vedi, ma ne avverti la presenza, la forza, il movimento. Ne percepisci la carezza o la tempesta, senti quando ti spinge o ti resiste, eppure non puoi afferrarlo né rinchiuderlo. Una donna detenuta mi chiese una volta: “Tu sai dove va a dormire il vento?”. È una domanda bellissima e disarmante. Per me l’anima è quella domanda: il luogo invisibile da cui nascono le domande più vere, che non cercano risposte facili, ma aprono alla meraviglia, al mistero, al senso.
L’anima è il principio spirituale che ci abita, che ci collega a una sorgente più profonda di noi, qualcosa che ci precede e ci trascende. Non è separata dal corpo, ma la sua dimensione più sottile ed essenziale. Ci fa vibrare, ci orienta, ci chiama verso un destino che non si esaurisce nel fare o nell’avere. Non è un concetto astratto: è una realtà viva, difficile da misurare, ma ciò che ci rende umani, capaci di desiderare, sognare, amare, soffrire, cambiare.
Spinge a cercare senso, anche quando tutto sembra privo di significato. Ci tiene svegli la notte, ci fa porre domande scomode, ci spinge oltre i limiti. Non è inquietudine sterile: è tensione creativa, sete profonda, nostalgia d’infinito. Nell’anima si cela il bisogno radicale di giustizia, verità, bellezza e amore che nessun possesso, successo o spiegazione razionale può saziare. È come una ferita d’infinito, una finestra sempre aperta verso l’altrove.
E proprio in quella tensione – tra ciò che siamo e ciò che desideriamo diventare, tra la finitezza del corpo e l’apertura dello spirito – l’anima respira. Respira nel silenzio, nella preghiera, nella contemplazione, ma anche nelle relazioni autentiche, nell’arte, nella lotta per un mondo più giusto. L’anima è la voce che sussurra che la vita non è solo sopravvivenza, che ogni essere umano custodisce qualcosa di sacro e inviolabile.
Cosa significa prendersi cura dell’anima?
Credo che prendersi cura dell’anima significhi imparare ad ascoltarla, ad accoglierne le domande senza paura, a coltivare spazi interiori in cui possa parlare, crescere, maturare. Significa non anestetizzarla con il rumore, con la velocità, con il consumo. Significa riconoscere che siamo più del nostro ruolo, più delle nostre prestazioni, più dei nostri errori. Che in ciascuno di noi dimora qualcosa di unico, irripetibile, che ci rende umani in senso pieno. E se impariamo ad ascoltarla, l’anima può diventare bussola e fuoco, ferita e luce, domanda e cammino. In fondo, parlare dell’anima è parlare della nostra identità più profonda, della nostra umanità più vera. E forse è proprio quando impariamo a vivere “con l’anima in gola”, cioè con la consapevolezza e la fragilità di chi cerca sinceramente il proprio senso, che cominciamo davvero a vivere.
È possibile coltivare l’anima oggi? E come?
Coltivare l’anima oggi è uno degli atti più radicali che possiamo compiere. In un’epoca in cui tutto corre, dove ogni secondo è riempito da notifiche, scadenze e stimoli continui, l’anima rischia di smarrirsi. Non perché non esista, ma perché non trova spazio né ascolto. Coltivarla significa restituirle una casa, un respiro, uno sguardo attento, capace di vedere oltre.
Il verbo “coltivare” richiama l’agricoltore, che accompagna la terra senza forzarla. Ogni seme ha il suo tempo, ogni stagione il suo ritmo. Così è l’anima: non cresce nella fretta, né nella performance, ma nel tempo dedicato, nel silenzio accolto, nella capacità di abitare l’invisibile.
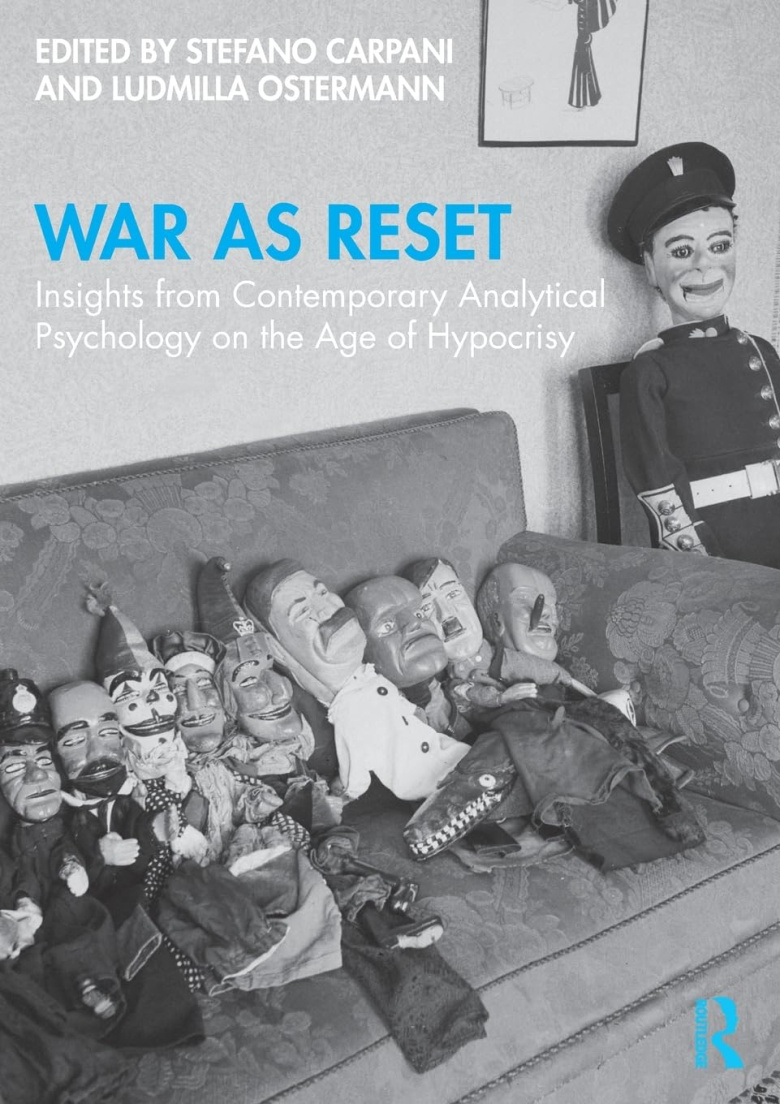
Oggi coltivarla significa anche resistere: resistere alla superficialità, alla frammentazione, all’ansia di dimostrare. Richiede coraggio per creare spazi interiori — anche piccoli, ma reali — dove il rumore del mondo non arrivi. Significa imparare a stare: nel silenzio, nella preghiera, nella lettura lenta, nell’ascolto profondo di sé e dell’altro. Come ricordava il cardinale Martini, non si tratta di aggiungere impegni, ma di abitare ciò che viviamo con uno sguardo nuovo. Ogni gesto, incontro o frammento della giornata può diventare luogo spirituale, se vissuto con consapevolezza.
Coltivare l’anima richiede disciplina: una fedeltà quotidiana che non cerca risultati immediati, ma si affida al processo. È una danza tra fare e lasciarsi fare, tra agire e accogliere. L’anima non si possiede, si riceve: è soffio da riconoscere, presenza che nasce dalla relazione, non dal possesso.
In fondo, coltivare l’anima è una forma di amore. Un amore che non pretende di cambiare tutto subito, ma si fida del tempo, del silenzio e della grazia nascosta nelle piccole cose.
Cos’è per te la libertà?
La libertà, oggi più che mai, è un concetto che rischia di essere frainteso. Siamo spesso portati a identificarla con la possibilità di scegliere, di fare, di esprimere senza limiti. Ma questa è solo una forma superficiale di libertà. La vera libertà non è fare tutto ciò che vogliamo, ma scoprire chi siamo veramente. Non nasce da un potere, ma da una verità: la verità di sé.
Essere liberi, infatti, non è uno stato naturale, ma un cammino. Un percorso che passa attraverso la liberazione da tutto ciò che ci imprigiona: le paure che ci bloccano, le abitudini che ci anestetizzano, i giudizi altrui che ci condizionano, le sicurezze apparenti che ci impediscono di osare. Siamo spesso legati da catene invisibili, più interiori che esteriori, che ci tengono legati a un’idea di noi stessi che non ci appartiene davvero.
Come il popolo d’Israele nel deserto, anche noi siamo chiamati a lasciare le “cipolle d’Egitto”, cioè quelle abitudini comode ma schiavizzanti. Ma il deserto spaventa: è luogo di solitudine, di prova, di verità. Eppure, solo attraversando il deserto si può diventare veramente liberi. Perché è lì, nel vuoto delle false certezze, che può emergere il nostro volto autentico.
La libertà, dunque, non è solo un diritto da rivendicare, ma una verità da scoprire. Non è un “fare tutto”, ma un “essere pienamente”. E questa libertà autentica ha sempre una dimensione relazionale: non possiamo essere liberi da soli. La nostra libertà si compie nella relazione, nella responsabilità, nella capacità di donare e ricevere.
Un popolo è veramente libero solo quando ciascuno può essere sé stesso nella comunione con gli altri. Una comunità è libera quando non ha bisogno di uniformare, ma valorizza la diversità. Una persona è libera quando può dire “sì” o “no” non per reazione, ma per scelta. E in questo senso, la libertà è sempre anche un atto di amore: perché chi ama, sceglie. E chi sceglie liberamente, ama davvero.
Cosa significa sofferenza?
Alda Merini disse: “Ho sempre scritto quando soffrivo”. In queste parole, così semplici eppure così dense, si racchiude una verità profonda sull’atto creativo e sull’esperienza umana. Per la Merini, la sofferenza non è mai stata un’esperienza sterile, fine a sé stessa, né un peso da rimuovere o da dimenticare. Al contrario, è stata la materia viva e bruciante da cui trarre parola, poesia, visione. In lei il dolore si è fatto linguaggio, la frattura si è fatta canto. Come accade ai grandi artisti e ai poeti più intensi, è proprio nel momento dell’ombra, dell’annientamento, della perdita di sé, che può nascere una parola nuova, autentica, lacerante e salvifica. Un linguaggio che non consola, ma disvela; che non cancella la ferita, ma la trasforma in varco.
Merini ci mostra che il dolore può diventare generativo, ma non in modo automatico o immediato. È necessario attraversarlo, sostarvi dentro, ascoltarlo. Solo così, quel magma confuso e bruciante può assumere forma, significato, potenza. Questa visione mi accompagna quotidianamente nel lavoro che svolgo accanto alle donne vittime di violenza: donne apparentemente spezzate, private della loro voce, del loro corpo, del loro diritto di esistere. Donne che arrivano con lo sguardo spento, con la vita addosso come un peso insostenibile. Eppure, se accolte con rispetto, se ascoltate senza giudizio, se accompagnate con pazienza e umanità, queste stesse donne riescono a compiere qualcosa di straordinario: riscoprire dentro di sé un nucleo profondo di forza, di dignità, di bellezza.
La sofferenza, allora, può diventare un grembo oscuro da cui nascere una seconda volta. Non è un processo lineare né indolore. Richiede tempo, silenzio, ascolto. Ma accade. E quando accade, è come assistere a un miracolo laico: vedere un volto che si illumina, una schiena che si raddrizza, una voce che torna a farsi udire. È come diceva De André: “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori”. Una frase che, come quella della Merini, racchiude in sé un'intera filosofia dell’esistenza: non bisogna temere il buio, perché è da lì che può sorgere la luce. Non bisogna vergognarsi della fragilità, perché è lì che si annida la possibilità di una nuova forza. E non bisogna censurare il dolore, perché proprio da esso, se vissuto con consapevolezza, può germogliare una bellezza profonda, non patinata, ma vera. Una bellezza che conosce il male e per questo sa riconoscere il bene.
Merini, con la sua vita segnata da internamenti, solitudini, emarginazioni, eppure così traboccante di parole potenti e visioni luminose, ci insegna che la poesia – e più in generale ogni forma di creatività – è un atto di resistenza, di rinascita, di amore. Scrivere nel dolore non è solo un gesto terapeutico, ma una forma di testimonianza: significa affermare che anche nel fondo del buio, la voce può sopravvivere, e con essa la possibilità di cambiare, di guarire, di vivere.
Cosa rimane oggi della spiritualità?
Oggi la spiritualità è più attuale che mai. In un’epoca in cui le religioni tradizionali perdono presa, cresce invece il bisogno di senso, di profondità, di andare oltre l’immediato. Molti giovani, pur lontani da chiese e riti istituzionali, sentono dentro di sé una tensione verso l’oltre, una ricerca interiore che possiamo chiamare spirituale.
Per me, spiritualità è questa ricerca: non un insieme di pratiche o credenze imposte, ma una dimensione profonda dell’essere umano, accanto a razionalità ed emotività. È una “terza via”, uno sguardo integrale capace di cogliere connessioni e armonie, di mettere in dialogo pensiero e sentimento, corpo e anima, materia e spirito.
Non è fuga dal mondo, né alienazione: radica nella realtà, accoglie dolore e limiti, li ascolta e li trasforma. Non promette scorciatoie, ma offre un orizzonte più ampio per comprendere ciò che accade.
La spiritualità ci aiuta a restare umani nelle prove, a resistere senza cinismo, a credere senza illusione, ad amare senza possesso, a vivere con pienezza. È un’arte del vivere, un’energia che ci spinge a cercare non solo ciò che siamo, ma ciò che potremmo diventare.
Cosa ci insegna il XX secolo?
Il XX secolo ci lascia un’eredità complessa e dolorosa, che richiede riflessione sul passato per costruire un futuro più consapevole e giusto. È stato un secolo segnato da eventi drammatici: due guerre mondiali, genocidi come la Shoah, regimi totalitari che hanno annientato libertà e dignità, e crisi economiche devastanti. Ma è stato anche il secolo delle grandi trasformazioni sociali, delle rivoluzioni culturali, dei movimenti per i diritti civili, dell’emancipazione femminile, della decolonizzazione e del progresso tecnologico e scientifico.
Da questo vortice di eventi traumatici emerge una lezione chiara: l’essere umano non può pensarsi come un individuo isolato e autosufficiente. La modernità aveva illuso che la libertà individuale fosse un traguardo assoluto, ma il Novecento ha dimostrato, spesso a prezzo di sangue, che siamo interdipendenti. Le nostre vite sono connesse a livello umano, sociale, economico e ambientale: le scelte di un singolo Stato possono influenzare il pianeta, le ingiustizie altrove hanno ripercussioni anche su di noi, e la crisi ecologica non conosce confini.
Abbiamo appreso che non esiste vero benessere senza giustizia sociale, né libertà autentica senza responsabilità individuale e collettiva. Se l’Ottocento ha affermato l’idea di libertà e il Novecento quella di uguaglianza, oggi il XXI secolo è chiamato a diventare il secolo della fraternità. Non una generica bontà, ma una scelta consapevole, radicata nella realtà politica, economica e culturale, che riconosce che nessuno può salvarsi da solo.
Dimenticare questa verità significa ripetere gli errori del passato: guerre, disuguaglianze, muri tra popoli e culture. Solo riconoscendo l’altro come fratello e costruendo ponti invece di barriere può nascere una convivenza pacifica.
Il Novecento ci affida una missione: imparare a essere umani insieme. Significa abitare la diversità come fonte di arricchimento reciproco, porre al centro della convivenza rispetto, solidarietà e cooperazione. Solo così potremo sperare di edificare un futuro più umano, giusto e sostenibile per le generazioni a venire.
Grazie Giuseppe, e viva Arché che da 35 anni inventa ogni giorno la speranza!
Leggi anche:
Stefano Carpani | Coltivare l'anima nella supersocietà
Stefano Carpani | Coltivare l'Anima nella Supersocietà̀ 2. Il bambino di cioccolato
Stefano Carpani | L'età tragica dei corpi senz’anima
Stefano Carpani | Luigi Zoja: cosa sta succedendo oggi?
Stefano Carpani | Una guida per la crisi di mezza età
Stefano Carpani | Rossana Campo: Intimità e resistenza narrativa
Stefano Carpani | Candellieri e Favero: un mondo sacro e profano ci salverà







