Alexander Langer: non per speranza ma per amore
Oltre le celebrazioni rituali che per primo non avrebbe voluto, forse un verso del poeta latino Terenzio descrive efficacemente lo stile di vita, la storia e l’impegno di Alexander Langer: “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”. Ognuno di noi è un essere umano e nulla di ciò che è umano ci è estraneo. Una combinazione tra utopia e realismo ha alimentato la vicenda umana di Langer, producendo frutti di particolare importanza e durata e, allo stesso tempo, inquietando costantemente la sua esistenza, fino alla tenaglia finale. Se è vero, come sosteneva Georges Braque, che finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli, è vero pure che la nostra inquieta ricerca, quando c’è, richiede almeno qualche forma di riconoscimento e qualche esito confortante. Non è stato così per l’impegno esistenziale, civile e politico di Alexander Langer. Guardando indietro con i limiti del senso storico che è consentito a circa tre quarti di secolo possiamo constatare che gli anni successivi alla seconda guerra mondiale hanno consentito alle generazioni che si sono presentate alla società e al mondo negli anni sessanta e settanta del secolo scorso la possibilità di pensare e sognare quello che ancora non c’era, di concepire un mondo possibile, di immaginare la libertà, la giustizia, la pace, l’uguaglianza, la fraternità, i diritti dei popoli, e una vera rivoluzione negli stili di vita, nelle relazioni e nel riconoscimento del valore di ogni differenza. Langer ha contenuto molte di queste prospettive e ha impegnato la propria vita per perseguirle. Così come rappresenta per molti aspetti e in un modo drammatico l’evidenza del fallimento di buona parte di quelle aspettative e di quei sogni. Non perché non vi sia alcun risultato di quel tumultuoso e contradditorio periodo storico, ma perché quanto di quelle prospettive si è almeno in parte affermato si muove in una cornice del tutto inedita e in un disordine globale che ha spazzato via quel mondo, e spesso è difficile persino riconoscere le tracce evolutive di quel tempo di progettualità e di utopiche aspettative. Certo le contraddizioni, in quei movimenti sociali e politici furono tante e di certo hanno contribuito alla creazione della situazione attuale. Una delle caratteristiche distintive del percorso di Langer è stata, forse, la capacità di contenere quelle contraddizioni in una sola esistenza, di viverle e farle lavorare in sé stesso, fino al limite della capacità di tenuta. Se si considerano le questioni a cui si è dedicato e di cui si è fatto carico fin dall’adolescenza non è difficile comprendere la fatica e quelli che chiamerà alla fine “i pesi divenuti davvero insostenibili”: il dialogo interetnico e tra culture diverse; la ricerca delle vie della non violenza e della pace; la “conversione ecologica”, un suo concetto e un suo impegno che dicono del nostro tempo e delle tragedie umane in corso più di ogni altra espressione. Se il titolo di una delle più importanti raccolte dei suoi scritti descrive bene la leggerezza dello stile esistenziale di Langer, Il viaggiatore leggero, [Sellerio, Palermo 1996], il suo viaggio non deve essere stato leggero, né gli è appartenuta alcuna forma di preservazione di sé, essendosi prodigato in ogni modo e in ogni luogo sui temi che lo coinvolgevano senza sosta, facendo del mondo la propria patria, dalla Bosnia, al Kossovo, dall’Amazzonia al Messico, a partire dalla sua piccola patria interetnica, il Südtirol – Alto Adige.
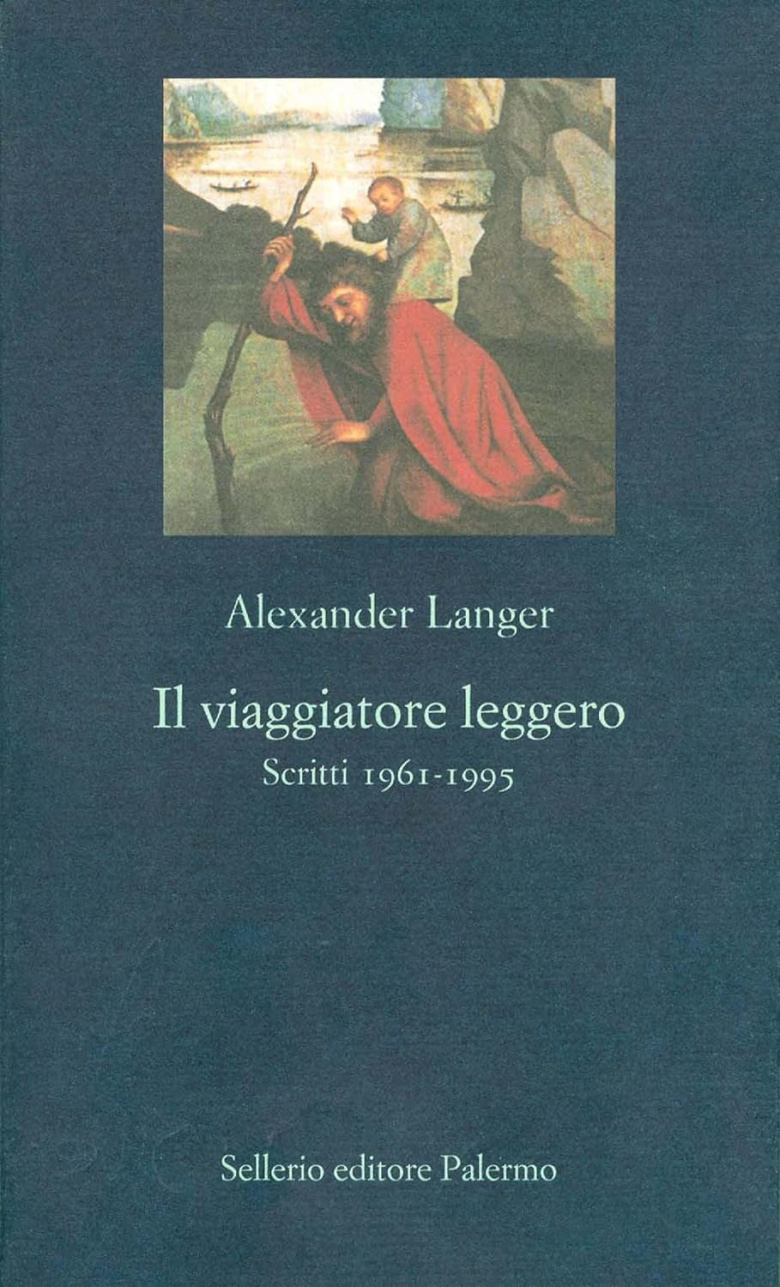
Come ha riconosciuto Goffredo Fofi, che molto gli è stato amico, Langer si è mosso, rapido e ansioso, su un sentiero di cresta, da uomo di montagna e di confine, e la sua vita è esemplare di molti dei percorsi esistenziali della sua generazione, anche se tendenzialmente unica e inimitabile per coerenza e profondità, nonostante i soliti e non eleganti accaparramenti dell’ultima ora e relativi ai rituali stinti degli anniversari. A distinguere il suo percorso è la levatura dell’ispirazione intellettuale e morale che ha guidato la sua fatica. Langer ha voluto tenere insieme un’intelligenza delle cose ultime che non si lasciasse spaventare dall’enormità delle questioni che ha provato ad elaborare e ad affrontare, e uno stile di vita quotidiana che non si discostasse dalle convinzioni proclamate. “…sì che dal fatto il dir non sia diverso” [Dante, Inferno, XXXII] si addice alla vita e all’opera di Langer come a pochi altri.
Fofi scrive che se si dovesse chiudere in una formula ciò che Alex Langer ci ha insegnato, essa non potrebbe che essere: piantare la carità nella politica. Piantare nel senso di farle mettere radici, farla crescere, difenderne la forza, la possibilità di ridare alla politica il valore della responsabilità di uno e di tutti verso la cosa pubblica, il bene comune, verso una solidarietà tra gli umani e tra loro e le altre creature secondo il progetto o sogno, – e Fofi cita Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto –, di chi «tutti fra sé confederati estima / gli uomini, e tutti abbraccia / con vero amor, porgendo / valida e pronta ed aspettando aita / negli alterni perigli e nelle angosce / della guerra comune».
L’apertura verso il molteplice e la capacità di elaborazione della complessità contemporanea, sono associate, secondo Fofi, anche alla storia familiare di Langer, una storia ricca di differenze, a cavallo tra lingue e culture, tra Germania e Italia, e tra ebraismo e cattolicesimo. L’umiltà, che è stato uno dei tratti caratteristici della personalità di Langer, e la sua propensione all’ascolto degli altri, dalla libertà dei collegamenti fino alla scelta di “fare da ponte”, hanno connotato la sua vita e la sua disponibilità a contenere differenze e contraddizioni. La parola ponte è una parola sporgente nella storia di Langer e dei suoi molteplici impegni per la costruzione di giustizia, libertà e dialogo tra le differenze. Ponti in grado di mettere in comunicazione persone e città, culture e territori. Ponti ideali, che potessero permettere ai vinti e ai vincitori di ritrovare nell’incontro e nel dialogo la possibilità di un futuro migliore. Pur essendo attaccato alle proprie radici regionali, l’ambizione di Langer era allo stesso tempo cosmopolita. Ciò gli ha permesso una concretezza precisa, mai parolaia, e una visione ampia, internazionale, quella che lo induceva a preoccuparsi ostinatamente di due ambiti da tenere strettamente collegati tra loro: “il mio villaggio e il mondo”. Viene in mente l’importante considerazione di Ernesto de Martino: “Per non essere provinciali occorre possedere un villaggio vivente nella memoria, a cui l’immagine e il cuore tornano sempre di nuovo” [in A. Pierro, Il mio villaggio, Cappelli, Bologna 1959].
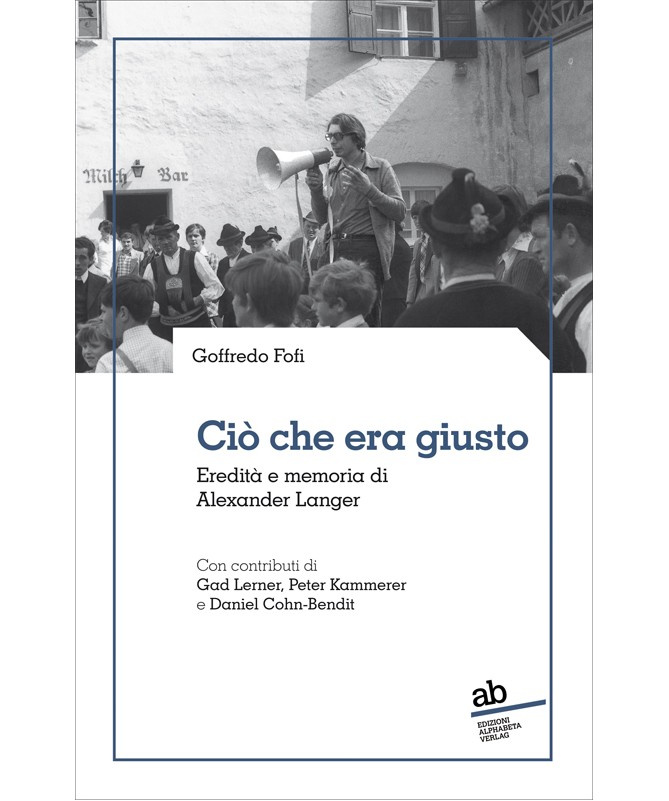
Goffredo Fofi esprime un commento sull’impegno e la tensione sistematica di Langer che finisce per essere un’analisi dell’evoluzione della sua vicenda politica, culturale e umana: «Il progetto semplicissimo e immenso di far da ponte tra le parti in lotta, che ad Alex costò infine la vita, è fallito e continua a fallire in un mondo dove le incomprensioni permangono e prosperano gli odi, sollecitati dai diversi poteri e dal peso dei torti ricevuti e fatti, di una memoria di gruppo che invece che rendere aperti, rende più chiusi alle ragioni degli altri.» E tuttavia il messaggio di Langer è stato fino all’ultimo limpido e chiaro: bisogna imparare dall’esperienza quel che se ne può ricavare, e andare avanti. Non perché “si spera” ma perché “si ama”, e la “carità” è allora il centro di tutto, più della speranza e più della fede. Proprio a partire da queste premesse Langer ha svolto una funzione di ponte in almeno due direzioni prioritarie: quella di accostare i popoli e le fazioni, di attutirne lo scontro e di promuoverne l’incontro, e quella dell’apertura a un rapporto nuovo tra l’uomo e il suo ambiente naturale. Dall’impegno e dalla cura riguardante il secondo punto si è affermata la capacità di additare nuovi territori all’azione politica responsabile, allargandone il significato da città a contesto, da polis a natura. Se sui temi della pace Langer è stato un continuatore, a partire dalla sua attenzione e dai suoi dialoghi con protagonisti come Don Lorenzo Milani e Aldo Capitini, nel campo dell’ecologia e della vivibilità è stato un precursore, uno dei più persuasi pionieri dell’indispensabilità di una visione ecologica dell’agire politico. In questo è stato confortato dall’amicizia e dalla relazione, dalla conoscenza e dalla vicinanza di uno dei pochi veri profeti del secolo scorso, il prete filosofo Ivan Illich. Convinzione di Langer era che la conversione ecologica richiedesse la necessità di prepararsi e di essere capaci di affrontare le resistenze, in particolare nelle fasi di stasi, per saper meglio muoversi nella furia che prima o poi si scatenerà. Spesso l’azione, secondo lui, soffre per il fatto di aver trascurato il pensiero, quando i suoi tempi si accelerano, e un pensiero senza azione serve a poco, cambia poco.
La ricerca della chiarezza dell’impegno ha caratterizzato il percorso di Langer fin dalle origini se si considera, per esempio, che già nel 1967, all’età di 21 anni, in un testo breve contenuto nel libro Il viaggiatore leggero, “I possibili malintesi di un discorso sulla pace”, egli scrive: «Molte volte la pace è stata scambiata per il quieto vivere ed il discorso che i cristiani hanno portato avanti, si è ridotto nei secoli ad una pace prevalentemente interiore, una pace ‘menefreghista’, che vede la sua tranquillità nell’assenza di relazioni. Certo, l’assenza di relazioni è anche assenza di tensioni, ma una pace vera che si riconosca nell’amore è monca se non entra in relazione con gli altri. […] Un altro malinteso molto comune è quello dell’unità nella quale tutti hanno sempre creduto, ma che è stata spesso trasformata in uniformità. Essere uniti infatti non vuol dire togliere le differenze. Questa costruzione della pace ci chiede di lasciare da parte l’uomo vecchio, l’uomo dell’antico testamento, di seppellire assieme a questo i molti pregiudizi della mentalità e di non fermarsi a quelle difficoltà che i luoghi comuni definiscono insormontabili.»
Venti anni dopo, con la coerenza che lo ha sempre contraddistinto, scriverà: «Liberarsi dalla guerra, dal militarismo, dalla distruzione ecologica, dall’incombere dell’apocalisse civile o militare che sia – non è solo un imperativo per chi vuole che i nostri figli o nipoti possano ancora vivere o per chi ama i popoli lontani. Non è solo questione dei ‘generosi’, per capirci meglio: no è questione che ci riguarda tutti.»
Seguendo una via narrativa e mediante un dialogo a distanza con Langer, Alessandro Raveggi ha scritto un libro che consente di entrare in alcuni aspetti del percorso di quello che lui chiama un profeta disperato e pieno di speranza che ha creduto nella possibilità di un’umanità multilingue e capace di valicare muri e frontiere. Raveggi ha scelto come titolo del libro le ultime parole lasciate scritte da Langer: Continuate in ciò che è giusto. Storia di Alexander Langer, [Bompiani, Milano 2025].
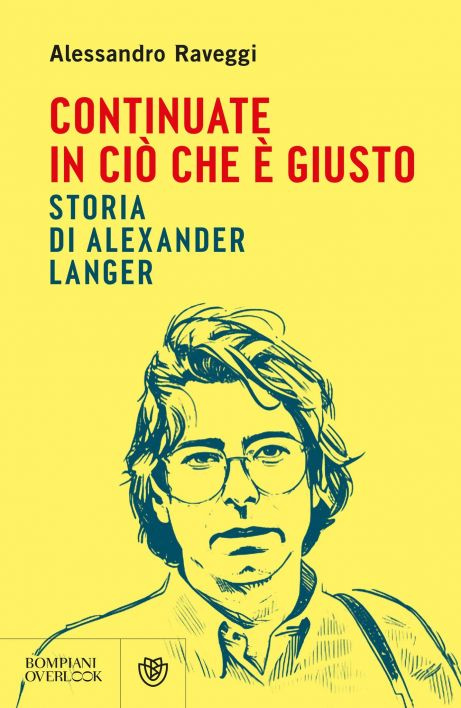
Alexander Langer veniva dall’esperienza di Lotta Continua e pensava che il pensiero verde dovesse essere ovunque, una pratica, una missione di vita francescana piuttosto che un’ideologia o un partito. Il libro di Raveggi, in forma di racconto, ripercorre i cammini di Alex, il suo impegno frenetico, riprendendo narrativamente la strada verso le nuove generazioni, quelle che oggi possono fruire della forza della sua esperienza e del suo pensiero, all’insegna della speranza.
Quella speranza è fondata su una filosofia concreta di non accettazione del mondo, così come ce lo troviamo davanti da bambini e lo incarniamo da adulti, promuovendo e mettendo in campo forme nuove di ribellione e appunto di non accettazione. Il radicale ripudio della violenza in tutte le forme che una società esprime ne è un aspetto. Non violenza secondo Langer significa intervenire attivamente. Quello stesso intervento indispensabile e necessario per la conversione ecologica. La conclusione di uno scritto tra i più importanti di Langer, Caro San Cristoforo, [per “Lettera 2000”, Eulema editrice, febbraio-marzo 1990], ora ripubblicato nel libro Il viaggiatore leggero, costituisce un fondamento del suo pensiero e della sua azione rispetto alla crisi ecosistemica e alla vivibilità: «Ci vorrà una spinta positiva, più simile a quella che ti fece cercare una vita ed un senso diverso e più alto da quello della tua precedente esistenza di forza e di gloria. La tua rinuncia alla forza e la decisione di metterti al servizio del bambino ci offre una bella parabola della ‘conversione ecologica’ oggi necessaria». In quella parola, ‘conversione’, che egli usa immaginando un dialogo con San Cristoforo, è condensata la sua visione anticipatrice, soprattutto se considerata oggi, trentacinque anni dopo, e il retroterra culturale e spirituale di Langer. In quel dialogo, particolarmente coinvolgente, anche da un punto di vista narrativo e letterario, Langer giunge a scrivere: «Bisogna dunque, riscoprire e praticare dei limiti: rallentare (i ritmi di crescita e di sfruttamento), abbassare (i tassi di inquinamento, di produzione, di consumo), attenuare (la nostra pressione verso la biosfera, ogni forma di violenza). Un vero ‘regresso’, rispetto al ‘più veloce, più alto, più forte’. Difficile da accettare, difficile da fare, difficile persino a dirsi. Tant’è che si continuano a recitare formule che tentano una contorta quadratura del cerchio, parlando di ‘sviluppo sostenibile’ o di ‘crescita qualitativa, ma non quantitativa’, salvo poi rifugiarsi nella vaghezza quando si tratta di attraversare in concreto il fiume dell’inversione di tendenza.»
Una chiarezza anticipatrice, persino impegnativa da commentare, attraversa queste parole la cui potenza è pari solo al rumore del fallimento che oggi registriamo di quell’analisi così realistica e così efficace da essere un vero e proprio progetto politico ed educativo per l’intera umanità.
Il sentiero difficile e impegnativo su cui Langer si è mosso è stato probabilmente il più esemplare ed educativo della sua generazione, il più aperto al confronto con le contraddizioni della politica e anche il più autenticamente e lucidamente drammatico e vero, come sostiene Goffredo Fofi. A partire dalle riflessioni sul suo cammino sembra necessario riflettere su come ricominciare, nella coscienza delle difficoltà e dei limiti delle scelte possibili, della precarietà e fragilità della nostra condizione di uomini e donne, dell’immane peso della storia, ma anche della necessità di reagire e di dare un senso alla brutalità o al torpore della nostra vita con scelte degne, nobili, responsabili e chiare, oggi più che mai.







