I fantasmi di Edith Wharton
I paesaggi hanno i colori sfumati dei ricordi, di un tramonto rosseggiante sui tetti di una qualche città europea visitata in tempi lontani, oppure sono investiti da “una grande distesa di luce, tenue ma penetrante”, oppure sono fatti dalle immagini che lampeggiano dal finestrino di un treno lanciato attraverso gli Stati Uniti, con una moglie che vuole nascondere che il marito durante il viaggio di notte è morto… In altri momenti ci ritroviamo in una tempesta incipiente sul lago, o tra nebbie fitte che si alzano all’improvviso e rendono il paesaggio di un luogo chiamato Valle dei Morti oscuro, inquietante, con la strada e le cose che non si distinguono e si corre in rischio di perdersi, di precipitare dalla scogliera, di cadere in un ottundimento dei sensi...
I racconti di Edith Wharton ci proiettano anche in ambienti carichi di risonanze occulte, come la casa antica nella vecchia Europa di Dopo, dove non c’è elettricità, non c’è acqua corrente e proprio per questo i coniugi protagonisti l’hanno scelta fuggendo dagli Stati Uniti e dalle speculazioni finanziarie del marito: un luogo situato in un paesaggio piacevole, ma custode di indecifrabili misteri. O, ancora, ci ritroviamo in un’altra vecchia magione in Bretagna dove appaiono misteriosi cani muti, che guardano in modo inquietante. O finiamo precipitati nel retro delle trincee, tra feriti e reduci da non deprimere, da far palpitare con storie commoventi senza scoraggiarli. Oppure ci inoltriamo nei santuari più riposti di una casa, che custodisce il segreto di due figli diventati adulti conservando l’aspetto di ormai rugosi ragazzini.
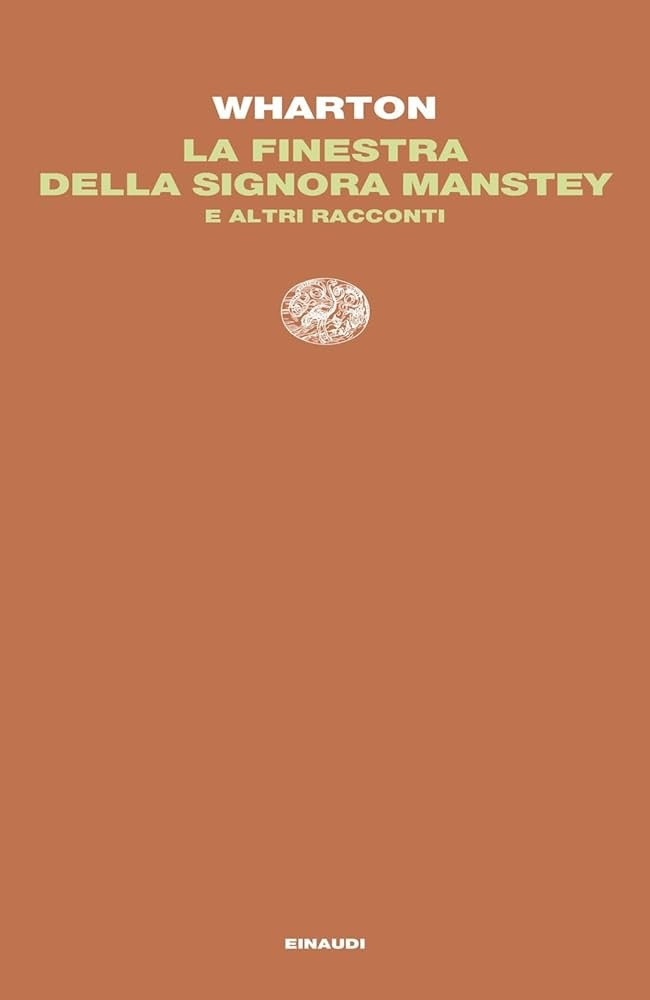
Ci narrano il passaggio del secolo visto da una signora aristocratica, molto snob ma capace di intercettare conflitti e trasformazioni, i racconti di Edith Wharton, tradotti con ritmo avvolgente e introdotti con dovizia di notizie e con acribia interpretativa da Chiara Lagani nell’antologia La finestra della signora Manstey e altri racconti. Lagani, con la sua compagnia teatrale Fanny & Alexander, ne ha anche portato in scena come drammaturga e attrice le storie più legate ai fantasmi nello spettacolo Ghosts (leggi qui).
La scelta delle opere comprese nel volume attraversa tutta la vita e l’attività della scrittrice nata nel 1862, dal primo pubblicato nel 1891, quello che dà il titolo alla raccolta, all’ultimo, composto pochi giorni prima di morire, nel 1937, Ognissanti, ambientato principalmente in una notte in cui il tempo sembra fermarsi e aprire un vuoto insostenibile in una casa che appare alla protagonista svuotata di ogni altro essere umano.
“I racconti sono la scatola nera del suo viaggio esistenziale: è qui che affiorano tutti i suoi temi, gli stili sperimentati, le rivendicazioni poetiche e politiche, è qui che emergono di più gli elementi autobiografici” scrive Lagani nella prefazione, che ci introduce nel mondo di un’autrice che di racconti ne scrisse ottantanove, oltre a venticinque romanzi, a poesie, saggi, traduzioni e articoli di giornale.
L’antologia proposta è composta di storie scritte in punta di penna, cariche di ironia; di critiche a un mondo dominante maschile e maschilista; di considerazioni sulla famiglia, sulla condizione della donna, sul desiderio di figli o sulla loro assenza. Lo sguardo è sempre upper class, ma con una sensibilità notevole anche per paesaggi urbani in trasformazione, come proprio in La finestra della signora Manstey, dove una vecchia vedova, che vive da sola, con la figlia lontana, in California, si oppone in modo inane all’innalzamento di un pensionato che le impedirebbe la vista dalla finestra da cui si bea di vedere poveri cortili, ricordando, nei tramonti, paesaggi ammirati altrove e poi solo immaginati, sognati.
È piena della luce smagliante di un meraviglioso ricevimento un’altra storia, Alla maniera di Holbein. Cosa c’entra il pittore tedesco del rinascimento? C’entra perché in realtà dietro le luci della festa ci sono altre due solitudini: quella di una donna che viveva di ricevimenti di società e che ripete, con la servitù, i rituali di un tempo ogni sera pur essendo ormai sola, con fiori che sono solo misericordiosi accrocchi di carta apprestati da un anziano servo a simulare lo splendore di una volta, e quella di un vecchio bon vivant che capita a quella festa perché dimentica dove doveva recarsi. Appare, inaspettato, alla soglia della signora, di cui aveva rifiutato più di un invito, e viene introdotto in casa. Siamo in una danza macabra, alla maniera di Holbein appunto, in una sonata di fantasmi, solo che gli ectoplasmi qui hanno un patetico corpo invecchiato, decaduto, come le loro facoltà mentali, e terribile è l’effetto di contrasto tra le luci, l’immaginato splendore high society e la realtà.
Di questo, mi sembra, vivano questi racconti di colei che fu considerata allieva di Henry James: di contrasti, tra la realtà e l’immaginazione, tra la vita apparente e oscuri viluppi della psiche che portano a materializzare i fantasmi interiori. Come in Dopo: dove in quella casa antica si sa che apparirà un fantasma, ma si scoprirà che tale è solo dopo. L’apparizione è quella, ricostruirà a posteriori la protagonista, di un giovane rovinato dal marito, che con le sue speculazioni ha potuto abbandonare il lavoro e ritirarsi nella campagna inglese per fare una vita di ozio rilassante e impegnato, a contatto con la natura, lontano dagli affari. Sarebbe, è, il sogno di ogni manager, oggi: smart working+natura+bellezza. Solo che qui il passato non perdona e la spietatezza negli affari materializza spettri che rapiscono l’uomo nel regno dei trapassati.
Il senso del contrasto è evidente in La pienezza della vita: a una suicida lo Spirito della Vita propone sulla soglia dell’altro mondo un compagno che possa introdurla a un piacere eterno, facendole dimenticare lo scricchiolio degli stivali del marito, sintomo di un rapporto viziato, trascurato, malato. Ma lei, alla fine, in una visione di luce, rifiuterà, aspettando l’arrivo del rumore fastidioso di quegli stivali.
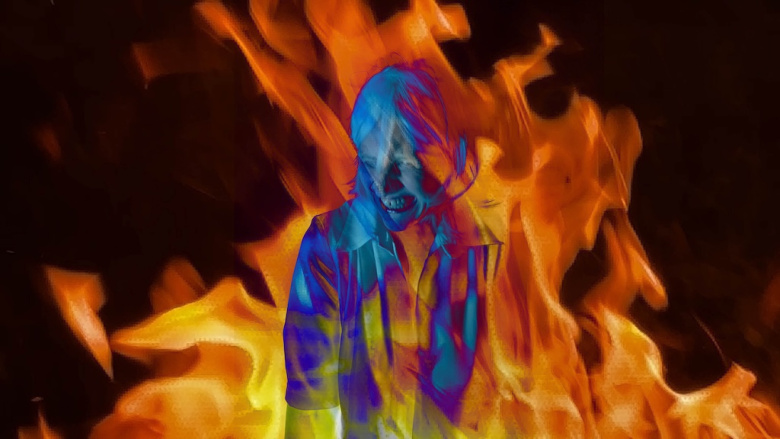
Chiara Lagani scrive che Wharton, pur notissima alla sua epoca (vinse il Pulitzer, prima donna, con L’età dell’innocenza nel 1921), visse sospesa tra il realismo ottocentesco e un nuovo mondo delle lettere, aperto da Joyce, Proust, Woolf; un modernismo che la guardò dall’alto in basso, facendola giudicare, con il suo stile, poco sperimentale, sorpassata. Spiega come il suo realismo mordace, capace di smascherare ipocrisie e crimini della ricca società statunitense, fosse impregnato di idealismo, di romanticismo, in un amalgama unico. E ritiene che il fantasma in lei sia fondamentale, perché assume il ruolo di un faro: “illumina per un istante i lati oscuri della psiche umana e allora, di volta in volta, può incarnare il rimpianto, un desiderio inconfessato, i sensi di colpa, la gelosia, l’erotismo, l’invidia, le pulsioni irrazionali, un amore impossibile, la paura della morte…”.
A proposito di Ognissanti la curatrice scrive: “La ricerca di qualcuno – una cameriera, una cuoca, uno stalliere, chiunque nella casa fredda e vuota in cui è rimasta bloccata a causa di una caduta diventa il tema di uno spaventoso viaggio interiore, al termine del quale la donna prende contato con una parte inconfessabile di sé e con la propria solitaria disperazione”.
I rimpianti, la vergogna di essere scaricati sui binari di una fredda stazione con il cadavere del marito morto in Un viaggio, il perdere le facoltà, lo smarrirsi nella paura simboleggiata da una nebbia che tutto avvolge in La signorina Mary Pask coprono le luci scintillanti. Il desiderio di una figlia si rovescia nella tirannia di questa, che fa tirare un sospiro di sollievo quando va in isposa, in La missione di Jane. Una moglie dimessa – come quella della frizzante novella Fascino familiare, diversa dagli altri membri del proprio gruppo parentale perché incapace di accendere cuori e sprizzare glamour – si rivela desiderosa solamente di quieta maternità…
I fantasmi sono in agguato dappertutto, nel caseggiato violato della signora Manstey, come tra le nebbie, come tra “bambini che non esistono, non parlano e non si vedono”, come scrive Lagani. Che continua: “i bambini cioè, prima ancora di diventare personaggi sono degli indicatori del lato più profondo, spesso oscuro, della vita adulta […] talvolta sono creature solo immaginarie, incastrate nel desiderio”. Sono al confine con la morte, con quello che non siamo o che non siamo stati capaci di essere.
Ci troviamo in un mondo di chiaroscuri dirompenti, di luci squillanti e ombre risucchianti. I paesaggi di Edith Wharton, le sue case di un’apparentemente placida campagna non vivono dello scintillare en plein air degli impressionisti: abbacinano come i quadri sfumati lampeggianti o oscuri di William Turner, trasportano altrove, in un mondo di sproporzioni, come nelle visioni caricatamente simboliche di William Blake.

Due racconti, infine, bisogna almeno citare ancora tra gli altri: L’Eremita e la Donna selvaggia, uno di quelli in cui è adombrato il rapporto tra Edith ed Henry James, in uno scenario medievale di fuga dal mondo, cioè dalle violenze e dagli stupri degli eserciti e dai rigori di un convento che non permette neppure i più semplici piaceri del corpo, come bagnarsi nell’acqua fresca di un ruscello. Qui alle macerazioni dell’Eremita corrisponde la paziente cura della Donna, il suo coltivare il giardino per nutrire la distanza dal mondo del creduto santo. E poi Scrivere un racconto di guerra, dove una giovane crocerossina, con qualche aspirazione artistica celata, viene invitata a scrivere un racconto “che non deprima e non scoraggi” per i reduci. Come fare? Sembra facile, ma la ragazza si scervella davanti a una risma di carta per molto tempo senza risultati, cercando una presa letteraria efficace. Alla fine uno scrittore famoso (altra controfigura di James?) le rivelerà cosa non è riuscito in quello che con tanta fatica lei ha prodotto. Aveva un soggetto interessante, forte, e lo ha sprecato: perché il soggetto è la cosa importante, più dello stile, su cui lei si è arrovellata. E anche qui c’è una capriola, un ironico senso del contrario: lo scrittore, come tutti i reduci, chiede alla ragazza una sua fotografia, di quelle che accompagnavano il racconto, dove la ragazza appare splendida nella sua uniforme di crocerossina. La considerazione della donna è sempre quella, incapace di apprezzarne le qualità intellettuali, avvinta a visioni legate all’avvenenza fisica.
In fondo la strada è ancora lunga: e l’ironia, il senso del contrario, del paradosso, il disincanto, come lo scavare nei vuoti, nei buchi, nelle paure dell’esistenza, nei suoi fantasmi, può aiutare a percorrerla.
Edith Wharton, La finestra della signora Manstey e altri racconti, traduzione e prefazione di Chiara Lagani, Einaudi, pp. 430, euro 22.







