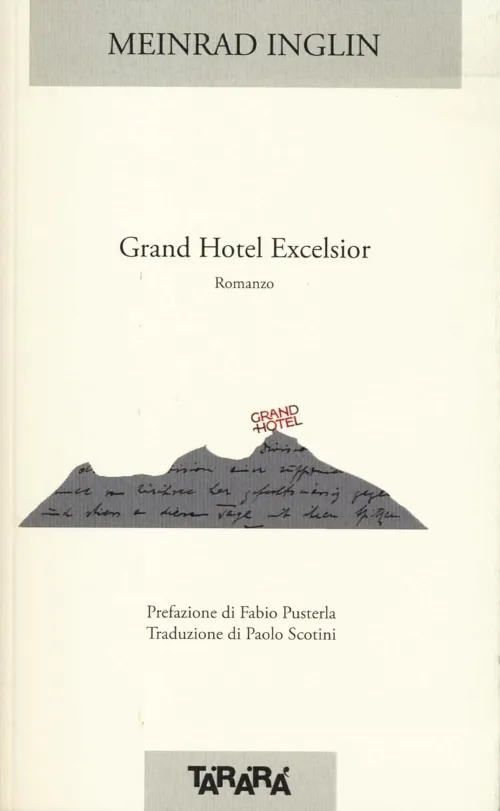Inglin, il matriarcato al Grand Hotel Excelsior
Non è semplice comprendere questo singolare romanzo dello scrittore svizzero Meinrad Inglin, nato a Schwyz nel 1893, dove pure morì nel 1971, uno dei cantoni ‘interni’, fondatori nel medio evo della Svizzera, quella ‘deep’, fiera di Guglielmo Tell, che giustizia il malvagio balivo, quella dell’impenetrabile dialetto schwyzertütsch, del cioccolato, orologi, sci e conti in banca. Mi sono avvicinato al romanzo, ricordandomi di un episodio quando lavoravo a Zurigo ed ero molto amico di Walther S., funzionario di una grande banca elvetica, anche lui giovane, ma già esperto dei flussi della finanza internazionale. Qualche volta andavo a trovarlo nel suo ufficio nella centralissima Bahnhofstrasse. Un pomeriggio di venerdì, mi propose di accompagnarlo alla sua Hütte, al suo casolare assai rustico. Un po’ più di un’ora dalla città. Arrivammo: era una piccola casa in legno, poco più di una capanna, senza acqua corrente, senza luce; attaccata alla parte esterna vista lago, c’era una panca. Mi disse: qui il contadino e sua moglie si sedevano e guardavano il sole al tramonto sul lago. Anche lui si sedette e aspettammo in silenzio il tramonto. Ecco il ‘set’ del romanzo: Grand Hotel Excelsior, edito dall’intrepida Tararà di Verbania, nella traduzione, come sempre irreprensibile, di Paolo Scotini, con un’indispensabile introduzione di Fabio Pusterla.
Il titolo di questo romanzo del 1928 rievoca subito il film Grand Budapest Hotel di Wes Andersen del 2013, che però si richiama espressamente a Stefan Zweig e al suo Mondo di ieri. L’altro grande riferimento, più pertinente, è La Montagna Incantata di Mann con il sanatorio-hotel Berghof di Davos. Così siamo in Svizzera e già più vicini a Inglin. Il Grand Hotel Excelsior nasce dalla trasformazione di un più modesto Sanatorio Sigwart in riva al lago – uno dei tanti laghi del cantone Schwyz – fondato da Peter Sigwart con la cui morte si apre il racconto che immediatamente mette in scena il contrasto tra la mentalità del patriarca, che aveva pur fondato l’albergo, solido, senza eccessive pretese, sostenuto dalla fattoria della famiglia ancora dedita all’agricoltura e all’allevamento, e quella del figlio Eugen, l’imprenditore. Lo scontro si acuisce tra i due fratelli Sigwart: Eugen, l’uomo d’azione, e Peter, il dubbioso, critico del progresso, della società consumistica contrapposta alla sobrietà contadina. In una scena centrale del racconto Peter convince un contadino a seguirlo, nei suoi abiti primitivi, prima nelle cucine e poi nelle sale di rappresentanza del hotel, producendo un silenzioso sconcerto dei cuochi, camerieri e poi degli ospiti illustri e cosmopoliti dell’albergo.
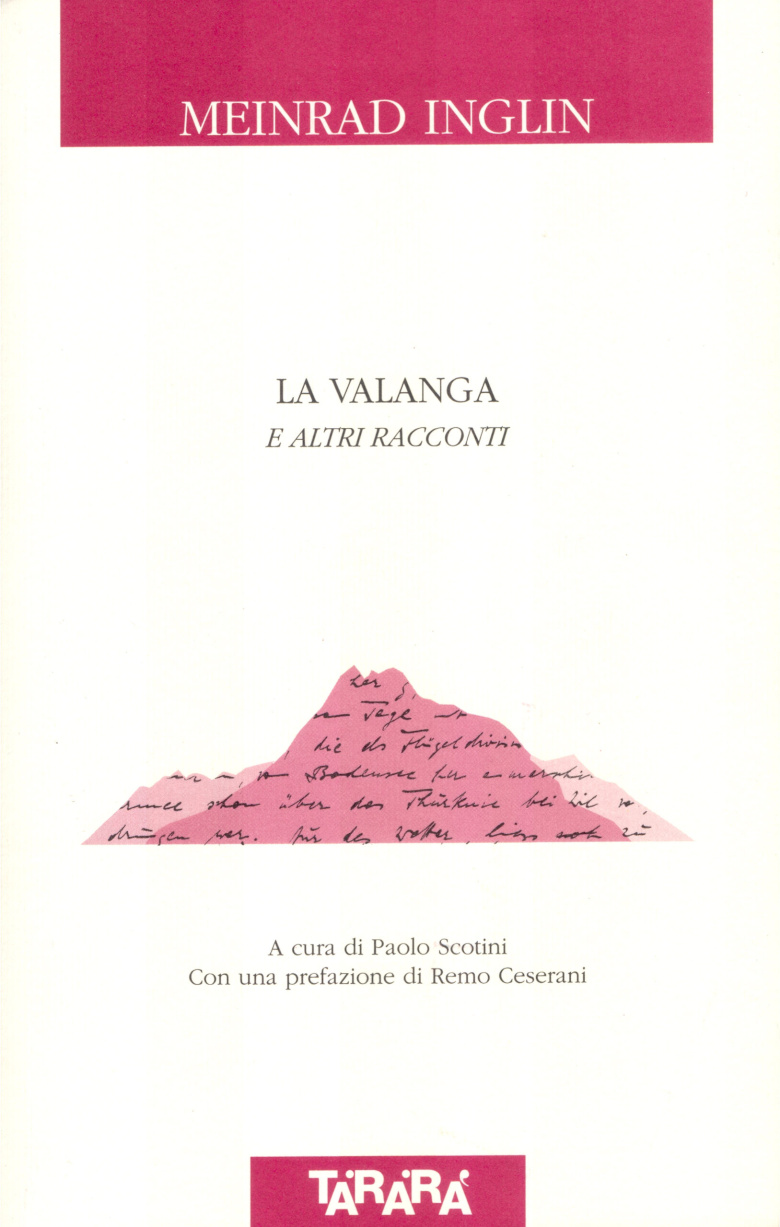
Nel romanzo si aggira ancora invisibile lo spettro Urgal. Era l’arcaico genius loci «quando in questi pascoli e colline, in questi boschi e sulla riva del lago regnava ancora una grande pace, questa era la patria di uno spirito […] era dappertutto: nei cespugli lungo la riva, nelle alture laggiù, su questi pascoli e nei boschi. Tutte le persone del luogo ne percepivano la presenza, alcuni, ovvio, solo in maniera vaga e confusa, altri con maggiore chiarezza.» Poteva apparire nei sembianti di un contadino o di un pescatore e perfino di un animale. Le voci del bosco erano le sue voci. Siamo in pieno animismo atavico che s’intreccia nella trama della società più spregiudicata, smaliziata e superficialmente furba e navigata, ma essenzialmente al limite della dissoluzione interiore: l’angoscia esistenziale viene esorcizzata dalla civiltà delle buone maniere, dalla cultura della raffinatezza e dell’eleganza, dalle relazioni di un forbito cosmopolitismo; questo sì che richiama l’ambientazione del Berghof manniano. Ma la società del Grand Hotel rappresentata da Inglin in realtà è già corrosa dall’irreparabile perdita dei valori tradizionali, gettata nel baratro del nichilismo, come registra un attento osservatore, Peter, il fratello filosofo, che percepisce la decadenza del tempo: «A volte dietro all’albergo, sul limitare del bosco, nell’ora del crepuscolo siede un uomo intento a riflettere appassionatamente su questa vita, la vita della sua epoca, che egli vede rifulgere di fronte a sé nel Grande Hotel Excelsior. […] È una vita senza dio, senza spirito, senza coscienza e senza amore. […] “Si dovrebbe sollecitare il destino che ancora esita, e chiamarlo all’azione”, pensa. “Qualcosa di incredibilmente grandioso dovrebbe accadere, una buona volta…”». E qualcosa d’irreparabile, infatti, accade nella straordinaria, epica narrazione dell’incendio del Grand Hotel distrutto in una notte da sabba in cui si rivelano le verità dei personaggi: generosi, nobili, abietti, astuti, ladri e altruisti, spietati ed egoisti, coraggiosi e vigliacchi, mentre tutto brucia.
Un fuoco per alcuni esperimentato come una rigenerazione mistica, per altri come una rovina, per Eugen come la possibilità di una rifondazione, ma ancora più in grande, di un albergo sui modelli di quelli americani, per Peter come l’inizio di una Wanderung, di un processo di trasformazione, ormai lontano dalle dinamiche del guadagno, del successo per far «ritorno come il figliol prodigo ricadendo però non tra le braccia del padre, ma nel caos materno. […] Non si chiede più quale sia lo scopo; guardando ingenuamente con occhio maturo e respirando senza limiti torna all’inafferrabile intimità protettiva, al mistero materno da cui è giunto». Insomma non a caso siamo in Svizzera nella patria di Johann Jacob Bachofen che già nell’ Ottocento aveva intuito l’origine matriarcale della civiltà occidentale. Il Peter di Inglin (per altro anche nel nome) presenta analogie con un suo più celebre predecessore, Peter Camenzind di Hermann Hesse, il personaggio più ‘svizzero’ dello scrittore. E anche per Inglin il tema centrale è quello della dissoluzione sociale della Svizzera interna, quella disperatamente fedele alle tradizioni, ormai in piena disgregazione, che diventò successivamente la materia drammaturgica per Max Frisch e Friedrich Dürrenmatt. E anche Inglin, così immeritatamente poco noto, è un autentico artista nella descrizione di luoghi, situazioni e personaggi, un grande evocatore di infiniti dialoghi, che impreziosiscono il racconto, teso e vivace, e si aprono a prospettive filosofiche, a meditazioni sostanzialmente incentrate sul tema del contrasto tra una comunità tradizionalista, agraria, sobria e una società in preda a una mobilità fine a se stessa, che pur tuttavia è pervasa da un’energia che manca alla vecchia civiltà contadina esausta, che può solo vivere sulla scia di quella moderna che anima il Grande Hotel, che per Peter – il personaggio più approfondito del romanzo – raffigura: «una metafora visibile di questa epoca, una sua meta inconscia, il traguardo a cui necessariamente deve giungere e concludersi il progresso occidentale».
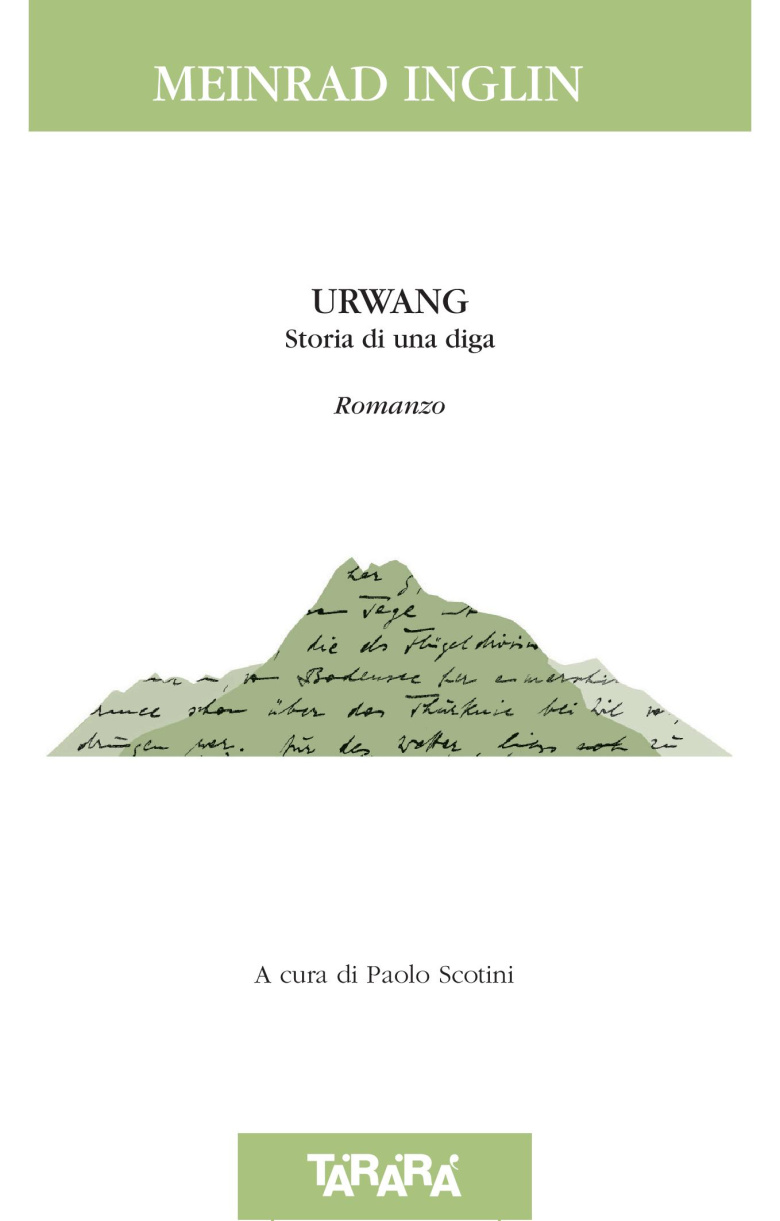
Per lui il racconto assume i connotati del Bildungsroman, del ‘romanzo di formazione’, mentre Eugen, spietato, calcolatore, razionalista, è anche un personaggio assai riuscito proprio perché rappresenta la dynamis inesauribile in questo inarrestabile processo della modernità: Eugen è, infatti, mosso non tanto dalla sete di guadagno, quando dal demone del tempo, dall’irrefrenabile Zeitgeist che lo costringe subito dopo il rogo a progettare in grande un altro Hotel: “the show must go on”. Tra i numerosi personaggi la figura di Johanna, la sorella dei fratelli Sigwart, esprime quella natura femminile di amore disinteressato, che non ha bisogno di fughe e di volontà di potenza entrambe espressioni maschili. Pure lei nell’incendio: «aveva trovato se stessa […]. Nitidamente crebbe dentro di lei la sensazione che quel mondo che stava crollando tutto attorno fosse soltanto l’opera dell’uomo, del genere maschile». Qui, tutta l’attualità della visione di Inglin.
Di nuovo uno scrittore dei confini. Uno strano destino della letteratura tedesca: Mann era nato a Lubecca da una madre tedesco-brasiliana, Hesse da un padre baltico, e gran parte della letteratura del Novecento è creata dalla Praga di Rilke e di Kafka e dalla Grande Vienna, da Schnitzler, Hofmannsthal fino alla Bachmann e Bernhard. Ora annoveriamo tra i più vivaci scrittori di lingua tedesca anche Meinrad Inglin della Svizzera interna.