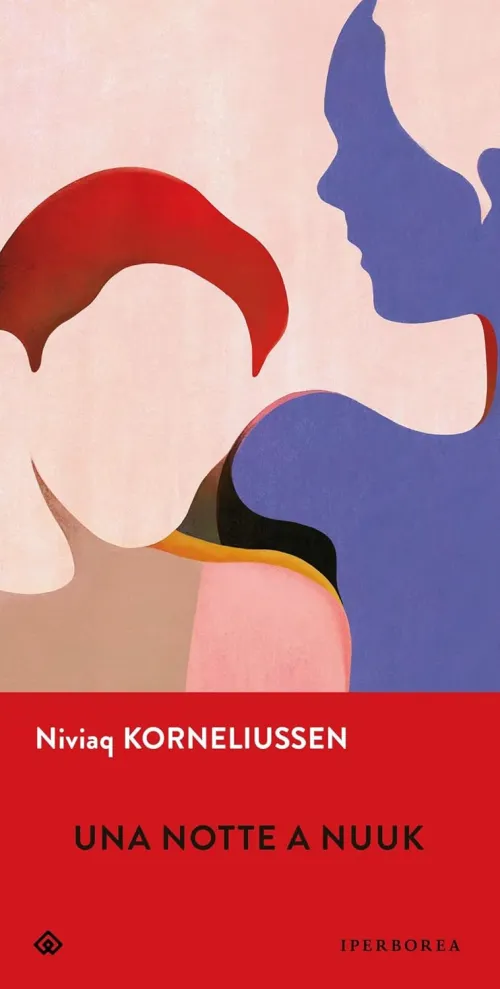La Groenlandia che è in noi
Quando parto per il Nord, cerco la luce. Quella bassa e radente che scolpisce il ghiaccio, quellache si nasconde per mesi e poi esplode in un crepuscolo infinito.
Quando ho finito di leggere Una notte a Nuuk (Iperborea 2025), mi sono sentita come se fossi appena tornata da un lungo viaggio a Nuuk, ma la luce che mi è rimasta negli occhi è un’altra. È la luce stroboscopica di un locale notturno, il bagliore freddo di uno schermo di cellulare nel buio di una stanza, il lampo di un’insegna che si riflette su una strada bagnata di nevischio. È una luce che non rivela paesaggi, ma illumina a intermittenza i volti di una gioventù che brucia e si consuma.
Sin dalle prime pagine, Niviaq Korneliussen ci porta per mano dentro una realtà dura e senza sconti: non ci conduce a vedere iceberg o fiordi, ma ci fa entrare nelle case, nelle camere da letto, nei bagni sporchi, nelle chat private. L’autrice ci fa sedere allo stesso tavolo dei personaggi, in mezzo al fumo e alle bottiglie di birra vuote, e ci costringe ad ascoltare.
Fra le pagine di questo libro ci si può perdere, si può smettere di essere lettori e diventare testimoni, o a volte sentirsi quasi degli intrusi, ammessi per un tempo breve e febbrile nell’intimità di queste vite.
Ciò che ho “visto” in questo romanzo d’esordio sono i volti.
Il volto di Fia, che all’inizio è una maschera di normalità dietro cui si nasconde il vuoto, e che poi si crepa per lasciare spazio a un amore nuovo e terrorizzante. Il volto di Inuk, contratto in una rabbia che è la cicatrice visibile di una ferita più antica, quella di non appartenere a nessun luogo, di sentirsi straniero nella propria terra. E poi Arnaq, Ivik, Sara: ognuno con la propria battaglia scritta negli occhi, nel modo di tenere le spalle, nel silenzio che segue una domanda troppo difficile.
Entriamo a Nuuk come si entra in un villaggio di frontiera: le strade sono segnate da silenzi bianchi, i volti si voltano con curiosità, un misto di attesa e sospetto. Le figure sono vive, da guardare controluce, attraversate da storie che il freddo non congela: amori instabili, desideri incerti, identità in costruzione. Le parole dell’autrice disegnano contorni duri, netti, sono “fotografie” di una realtà nascosta.
Niviaq Korneliussen in Una notte a Nuuk raccoglie le storie di giovani adulti groenlandesi che cercano sé stessi in un paesaggio fisico ed emotivo inospitale, segnato da confini invisibili ma palpabili. Attraverso una narrazione diretta e frammentata, l’autrice ci offre una sorta di reportage dell’anima, raccontando senza sotterfugi i turbamenti e le scoperte che segnano il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

I personaggi si muovono in una città che è luogo geografico e simbolico al tempo stesso, dove l’appartenenza si scontra con il desiderio di fuga, e l’identità personale entra continuamente in collisione con le aspettative sociali. L’abilità di Korneliussen sta nel restituire con grande autenticità e senza sentimentalismi questa tensione, attraverso dialoghi brevi e incisivi, che sembrano catturare istantanee di vita reale.
La dimensione emotiva del romanzo emerge potente, restituita tramite dettagli minuti e gesti quotidiani che si imprimono nella mente del lettore. Le voci di Fia, Inuk, Arnaq, Ivik e Sara si alternano come in una serie di fotografie, ciascuna con una propria luce, tonalità e intensità emotiva.
Questo mosaico narrativo rivela lentamente una generazione in equilibrio instabile tra libertà e convenzione, tra ricerca dell’identità e paura dell’isolamento.
Eppure, al di là delle storie individuali, è l’insieme a colpire: un tessuto narrativo fitto e dissonante, in cui i frammenti si compongono come un montaggio fotografico, e in cui il non detto è spesso più importante di ciò che viene esplicitato. In questo sta una parte della forza di Korneliussen: nel farci percepire ciò che non vediamo, come se dietro ogni dialogo ci fosse un secondo livello di comunicazione, fatto di silenzi, esitazioni e sguardi.
Una notte a Nuuk è una lettura necessaria, una testimonianza autentica e toccante che ci obbliga a guardare dentro i nostri stessi confini emotivi. Korneliussen ci ricorda che dietro ogni volto, ogni silenzio, c’è una storia degna di essere raccontata e ascoltata.
E quando si richiude quel libro, resta la sensazione di essere ancora in viaggio, di avere nelle orecchie l’eco di quelle voci e negli occhi il bagliore intermittente di quella città di frontiera. Ma basta spostare lo sguardo, allargare l’orizzonte, e ci si accorge che, oltre la notte di Nuuk, c’è un’altra luce: quella crudele e inesorabile del giorno artico, che irrompe senza chiedere permesso e che non lascia angoli dove nascondersi.
È in questa chiarezza totale che si apriva anche il precedente La valle dei fiori (Iperborea, 2023). È la stessa Groenlandia, eppure un mondo diverso: la città lascia il posto a un territorio aperto, dove i pendii erbosi, le nuvole basse e il vento costante diventano protagonisti al pari degli uomini e delle donne che lo abitano. La valle è un luogo reale e insieme un paesaggio interiore, uno spazio di passaggio in cui le storie si piegano e si trasformano.
Qui i volti sono scolpiti dal vento e dalla memoria. Non c’è il battito convulso della vita notturna, ma un tempo disteso, quasi ostinato, che mette alla prova chi vi resta. Le scelte hanno un peso definitivo, le incomprensioni scavano lentamente come acqua nella roccia. Gli sguardi sono più lunghi, i silenzi più densi, eppure la tensione emotiva è la stessa che a Nuuk attraversava le stanze chiuse e le notti insonni.
E se la città di Una notte a Nuuk sembrava un microcosmo in ebollizione, qui la scrittura spalanca finestre sul paesaggio, lasciando entrare una luce che non perdona. La precisione fotografica resta, ma la lente si sposta: inquadrature strette che catturano un gesto, una postura, un dettaglio di luce sulla pelle, si alternano a panoramiche ampie, dove il vento sembra spostare le frasi, rallentandole o trascinandole via.

La bellezza della valle non è mai addomesticata: è severa, spigolosa, a volte ostile, e proprio per questo vera. Gli incontri avvengono con la stessa cautela con cui si attraversa un fiume in piena, e il peso delle parole si misura come il tempo che serve per percorrere un sentiero. Qui, più ancora che a Nuuk, si ha la sensazione che ogni gesto sia irrevocabile, che ogni scelta lasci un segno che il tempo non potrà cancellare.
Anche qui Korneliussen evita ogni sentimentalismo. I dialoghi restano asciutti, essenziali, fenditure da cui trapelano paure, desideri, resistenze. È nei vuoti e negli spazi bianchi che il lettore trova la misura emotiva di questa storia, così come accadeva nella città di Nuuk. Ma mentre a Nuuk i vuoti erano pieni di rumore, nella valle il silenzio è quasi assoluto, e diventa esso stesso un personaggio.
Leggere La valle dei fiori significa percorrere un sentiero che richiede attenzione e ascolto, fermandosi a osservare ciò che non si dice e ciò che il paesaggio restituisce. È un’esperienza meno vertiginosa, forse, ma più duratura: il lettore sente di aver costruito un rapporto con quei luoghi e con quelle persone, come accade solo quando si resta abbastanza a lungo da riconoscere le sfumature della luce e i cambiamenti del vento.
Così, tra la notte elettrica di Nuuk e la luce ininterrotta della Valle dei fiori, Korneliussen compone un dittico che racconta la Groenlandia senza cartoline, mostrando che i luoghi estremi non sono solo geografie lontane, ma stati dell’anima. E che in ogni volto incontrato, sia illuminato da un lampo di neon o dal sole di mezzanotte, c’è la stessa urgenza: essere visti, essere riconosciuti, restare vivi.