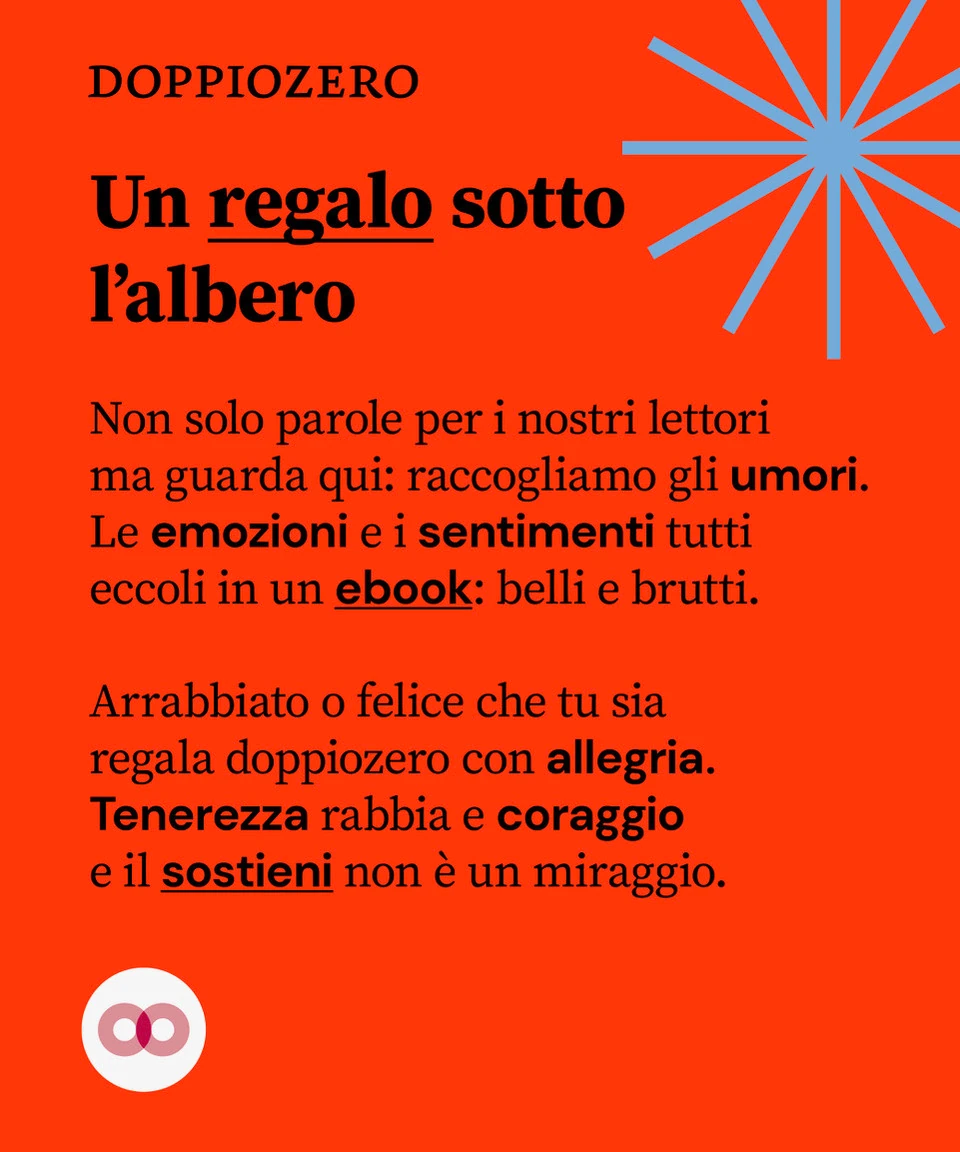La Biennale di Antonio Latella / L'invenzione della regia
È più di una selezione di spettacoli la Biennale Teatro di Antonio Latella. È un segno d’autore, è una domanda sui paesaggi della regia oggi, su come quest’arte che ha segnato il Novecento sia cambiata e, sopravvissuta a se stessa, stia cercando nuove strade. La rassegna – che si è inaugurata il 25 luglio e si è conclusa l’11 e il 12 agosto con la dimostrazione di lavori creati negli atelier del College, con allievi attori e maestri registi o registe – è il primo atto di un progetto quadriennale, ancora non svelato in tutte le sue tappe dal neo-direttore.
Questo primo episodio si intitola “Registe” e ha il coraggio di mostrare lavori di donne che si possono definire a pieno titolo autrici dei loro lavori, anche quando usano testi preesistenti, classici o contemporanei. Hanno tutte circa quarant’anni e sono quasi tutte sconosciute o poco note da noi. Tutte usano incrociare, in spettacoli scritti principalmente sulla scena, teatro, musica, danza, performance, momenti ispirati decisamente alle arti visive, in cui il corpo, l’immagine, la poesia (e spesso l’indignazione) giocano un ruolo centrale. Tutte lavorano con gruppi stabili di attori, piuttosto secondo le pratiche del teatro indipendente che secondo quelle delle grandi istituzioni. Tutte affrontano temi scottanti, sociali o individuali, spesso condensando segni, arrivando a un espressionismo che contiene nel frammento visioni complesse e dirompenti, toccando nervi scoperti con sintesi bruciante di mezzi.
Questa prima analisi si basa solo sui lavori visti nella prima settimana del festival, con spettacoli della polacca Maja Kleczewska, formatasi con Warlikowski (uno solo, ma è un’opera-mondo della durata di tre ore, La rabbia), dell’estone Ene-Liis Semper, che ha presentato due tappe del progetto seriale “Teatro NO99”, della francese Nathalie Béasse, alla Biennale con quattro titoli, mostrati in ordine inverso rispetto alla data di debutto, dal 2017 al 2008 (ho visto i primi tre). Il programma è stato completato da tre “favole” nere di Maria Grazia Cipriani, da tre lavori di Livia Ferracchiati, due opere di Anne-Sophie Mahler, due, rispettivamente, di Susan Boogaerdt e Bianca Van der Schoot e di Claudia Bauer, con gli ultimi giorni dedicati alle opere create nei laboratori del College.
Altra novità: non si tratta di singoli spettacoli di maestri riconosciuti, ma di piccole “personali” con più titoli per autrice, che disegnano la carta d’identità di artiste poco conosciute da noi, spesso, come nel caso di Nathalie Béasse, seguendone gli sviluppi in un ampio arco di tempo.
Segno d’autore del direttore, dicevamo: da sempre Latella fa un teatro che supera la regia comunemente intesa, intervenendo con piglio autoriale sui testi, scrivendo con gli attori e con l’assistenza di bravi drammaturghi, creando spettacoli che tendono i classici in direzione delle inquietudini dei nostri tempi. Si veda, come esempio chiaro, Santa Estasi, il viaggio nella tragedia greca che il regista quest’anno ha portato ad Avignone, tutta la saga degli Atridi attraverso opere differenti, con precipitazioni, psicanalitiche e non solo, nelle ansie, nei conflitti dei rapporti familiari di oggi. Condensazione di segni, metonimia e metafora in funzione di un espressionismo esistenziale.
 La rabbia di Elfriede Jelinek, regia di Maja Kleczewska, ph. Natlia Kabnow
La rabbia di Elfriede Jelinek, regia di Maja Kleczewska, ph. Natlia Kabnow
La rabbia
Maja Kleczewska mette in scena un testo del premio Nobel Elfriede Jelinek, scritto come reazione all’assalto a “Charlie Hebdo”. “Mette in scena” è un’espressione riduttiva. Le opere teatrali della scrittrice austriaca chiedono sempre di essere riscritte in teatro, pena una saturazione dell’ascolto che può dare l’impressione di asfissiante pedanteria. Perché incrociano voci dei media, flussi di pensieri, spunti ed esempi tratti dai classici, dati e parole della cronaca in un andamento diluviale, che travolge il lettore e chiede al regista di trasformarsi in (co)autore, per rendere carne e sangue, insieme ai suoi attori, i collage apocalittici dell’autrice.
La rabbia si svolge in uno studio televisivo, tra schermi in varia posizione e di varia dimensione che rimandano in continuazione telegiornali e interviste o scrutano dettagli della scena, mentre sullo sfondo vediamo un salottino con scaffali ricoperti di sciarpe di tifoserie di calcio. All’inizio sono schierati sul set alcuni giornalisti e giornaliste (una ha già qualcosa del clown): poi appariranno leghisti e neonazisti vari, immigrati o attrici che dipingendosi di nero li rappresentano e ne narrano odissee e dolori, un vescovo o cardinale, la statua di un Cristo crocifisso senza croce che finirà gettato in una pozza d’acqua tra i lumini. Ci sono anche in questo caravanserraglio del presente un solenne africano che intona “Allah Akbar”, una bellona palestrata che invita, con voce petulante, al fitness e vari altri personaggi-maschere.

La rabbia di Elfriede Jelinek, regia di Maja Kleczewska, ph. Natlia Kabnow
Tra notizie di cronaca in tempo reale, servizi su rom e su sbarchi di immigrati, scoppiano in continuazione rabbie diverse: dall’indignazione per le condizioni di chi cerca un mondo migliore da noi a quella per il sangue che macchia volti, camicie, vestiti dei giornalisti, a quella incontenibile di chi cerca di difendere dall’“invasione” dell’Altro le proprie piccole patrie, i propri cortili; da quelle per i morti clandestini considerati “irrilevanti”, a molte altre. Si piange, si spara, ci si confessa, si fa finta di informare, si grida l’indignazione o l’insofferenza, in un affresco iperrealista, che non si interrompe neppure per l’intervallo, costruito, con ritmo mirabile di frammenti della nostra realtà esplosa, tra disperazione, evasione nello yoga, nel ballo con un manichino, nell’evocazione della pazzia di Ercole delle Trachinie di Sofocle, in un lavoro sospeso tra la pietà (anche in senso figurativo, con quel corpo di Cristo che vaga per il palcoscenico), l’esplosione di ogni tipo di rancore, le sventagliate di kalashnikov, la ricerca di un dio, quale che sia, che sembra aver abbandonato l’essere umano.
L’umanità qui è desolata, ridotta a rifiuto, e la verità è continuamente messa in discussione dalla rappresentazione, che illude con le sue telecamere di poter scrutare i retroscena. Ma i retroscena dell’umano sono malati, bipolari, imprevedibili, tra il lamé e gli schizzi di sangue, tra arie pucciniane, litanie e colorati palloncini con freaks da circo, risate che si trasformano in tempesta e l’intonazione con accompagnamento elettronico di arie barocche che rivelano panorami di città scarnificate, ghiacciate, nebbiose, esaurite. Con il silenzio che diventa grido di rancore e Dio che si trasforma nel Leviatano. Uno spettacolo sovrabbondante, dispersivo e intensissimo, un canto di morte, una danza macabra dai colori sgargianti. Un ossimoro felice, affascinante, travolgente.
Maja Kleczewska ha vinto il Leone d’argento. Quello d’oro, il massimo riconoscimento della Biennale, è andato a una scenografa, la tedesca Katrin Brack. Non è, neppure questa, una provocazione: è un riconoscimento di come la scenografia sia, debba essere, un elemento della drammaturgia, della scrittura di scena.
 Ena-Liis Semper, teatro No43 Filth, ph.Tiit Ojasoo
Ena-Liis Semper, teatro No43 Filth, ph.Tiit Ojasoo
99 pièce – verso lo zero
L’estone Ena-Liis Semper lavora da tempo a un progetto definito “seriale” e di “arte concettuale”. Teatro NO99 è “una sorta di conto alla rovescia verso lo zero. Quando arriveremo allo zero, il nostro teatro si dissolverà”. Dichiara che nei diversi episodi sono centrali le improvvisazioni, il ritmo, il rito. Come spesso avviene nei lavori di arte concettuale, l’impalcatura di pensiero sembra certe volte più interessante dei risultati. Nei due lavori presentati si apprezzano soprattutto la concentrazione e la presenza degli interpreti. Il primo, No43 Filth, diretto con Tiit Ojasoo, sviluppa un reticolo di rapporti tra nove personaggi su un tappeto di fango. Gli incontri diventano sempre più scontri, lotte tra le persone e i sessi; le cadute si fanno via via più rovinose, fino a un’esplosione finale, al dissolvimento di ogni forma di coesistenza. Ricorda qualcosa di una certa Bausch, con un’ossessione, una ripetitività diversa, esasperata, come indirizzata verso un oscuro cul de sac.
 Ena-Liis Semper, Teatro No42 El Dorado, ph. Tiit Ojasoo
Ena-Liis Semper, Teatro No42 El Dorado, ph. Tiit Ojasoo
In Teatro No42 El Dorado siamo precipitati, invece, in un mondo di clown, che riproduce la storia dell’umanità. Su una piattaforma girevole assistiamo a grottesche sfilate di tipi umani condensati in pagliacci dai volti deformati da protesi esasperate, parrucche coloratissime, nasi realizzati con garze, oggetti estranei inseriti in bocca, trucchi caricati. Hanno caratteristiche femminili, le mogli del clown Diopadre, con croci, piogge, ripetute evocazioni del peccato originale, in una struttura che ugualmente guarda al rito, che evoca la crudeltà del sacrificio, la sadica vicenda dell’essere lanciati nel mondo, la punizione del diluvio universale. Tra gemiti, rantoli e affanni si ride a denti stretti, in una struttura che soffre, come l’altra, di una certa ossessiva, nera ripetitività, con qualche salto metafisico, in un orizzonte residuale che ha qualcosa di beckettiano, con banane e carote d’ordinanza, e si chiude con uno squartamento delle pelli apparenti del vecchio clown Padre con sesso femminile e la rivelazione della natura circense delle pelli finte indossate, e pioggia di palle d’oro, tra l’apocalittico e il cialtrone, il sadomaso, il prevedile, il post-umano. Qui l’espressionismo diventa barocco, un vagabondare nel sudiciume, nella sovrabbondanza confusa di oggetti, forme, possibilità, ossessioni di un’umanità sospesa tra le gag e i fantasmi, i lustrini e la macelleria .

Nathalie Béasse, Tout semblait immobile, ph. Marine Oger
Nelle oscure foreste familiari
Spettacolo seminale, che aiuta a comprendere gli altri, è il terzo presentato da Nathalie Béasse, Tout semblait immobile, del 2013. Inizia come una conferenza sulla fiaba di tre bizzarri, estrosi studiosi e diventa un viaggio nelle paure, nei terrori che la favola disegna, fin sull’orlo di un bosco oscuro dove si corre il rischio di essere divorati da orchi, da lupi, comunque da esseri strani, travestimenti con parrucche, pance e altri elementi posticci del padre e della madre che hanno abbandonato. Inizia, lo spettacolo, con un’aria di complicità con l’uditorio, da conversazione simpatetica, e si chiude in modo assoluto e lancinante, con un’accelerazione preparata da vari salti oltre la logica quotidiana. Sempre tra realismo e accelerazione poetica, in un’immaginale emozionante scavo dentro complessi, paure, archetipi.
Così la famiglia, i suoi necessari legami e i suoi abissi, è la protagonista degli altri due lavori della regista, formatasi nelle arti visive ad Angers, con un amore dichiarato per il cinema, la poesia e le creazioni visionarie di François Tanguy e del Théâtre du Radeau. Sempre con il contributo di straordinari attori che con la regista autrice formano un affiatato ensemble (alcuni ritornano nei tre titoli). Roses del 2014 è un pranzo di famiglia che si trasforma in Riccardo III di Shakespeare, per alludere alle dinamiche crudeli dei rapporti familiari. Chi sia, chi tra i vari tipi incarni il personaggio di Riccardo è la grande domanda, la questione irrisolta, perché ognuno dei convenuti ha qualcosa della mostruosità di Duca di York, del suo infido complottare contro i congiunti per interesse personale.
 Nathalie Béasse, Roses, ph. Wilfried Thierry
Nathalie Béasse, Roses, ph. Wilfried Thierry
Lo spettacolo si svolge intorno a un lungo tavolo, con pochissimi elementi scenici: un drappo che diventa fondale, sipario, mantello regale, disegnando spazi. Con sospensioni struggenti di certi personaggi, come quelle di una donna che si blocca in equilibri instabili su vari punti della tavola, tavola che viene apparecchiata di tutto punto, svuotata rovesciando tovaglia e stoviglie in terra, spostata, occupando e definendo diversamente lo spazio. Certe volte i personaggi shakespeariani prendono la ribalta; certe altre sembrano rivelarsi le personalità degli attori, di varia nazionalità, che rompono i freni del copione parlando la propria lingua madre.
Non sempre però funziona in modo ben articolato l’assunto, il proposito della sovrapposizione tra il quotidiano contemporaneo familiare e i personaggi del testo classico. L’autrice è costretta, versa la fine, a un’accelerazione della metafora, per congiungere due sfere rimaste spesso separate o comunque non connesse tanto da illuminare l’una con l’altra. La condensazione dei segni e l’espressionismo del quotidiano, pur con un ammirevole lavoro degli attori, non sempre creano i cortocircuiti necessari. Eppure di quello si tratta: di illuminare o almeno di rovistare lati in ombra del nostro essere e dei nostri comportamenti con la lanterna analitica, fantasmatica, dei classici.
 Nathalie Béasse, Le bruit des arbres qui tombent, ph. J. Blin
Nathalie Béasse, Le bruit des arbres qui tombent, ph. J. Blin
Nella pièce più recente, Le bruit des arbres qui tombent, siamo in un viaggio nella memoria, nell’infanzia, ancora in relazioni familiari che richiamano certi toni crepuscolari del Giardino dei ciliegi o i paesaggi stratificati di Annie Ernaux, con un retrogusto poetico o poeticistico che può anche far venire alla mente certe atmosfere del Favoloso mondo di Amélie.
Lo spazio palpita e muta per dissolvenze quasi cinematografiche di paesaggi, con un gran telo di plastica nera che all’inizio, sull’Adagietto della Quinta di Mahler, diventa sipario, fondale, cielo che oscura le luci di flebili neon e lascia al buio, forma agitata dal vento, prodotto da fili manovrati dagli attori... Si parte e si ritorna, dentro di sé, nelle storie familiari, in case abbandonate o sognate, tra le generazioni bibliche e quelle del paese, della città, in tempi dilatati, sovrapposti, danzati. Un cespuglio, forse un albero di Natale dell’infanzia, avvolge, segue, assiste, incalza un personaggio. Si finisce soli, ingobbiti, ricoperti dalla terra, inginocchiati, svuotati. Si evocano i morti, i vestiti vecchi, che volano o vengono accumulati su una ragazza come il peso di intere schiatte domestiche. Si parla inglese, danese, arabo, tedesco, oltre il francese, sempre con poche farsi, con sfoghi, con le vere lingue madri degli attori. Si corre, ci si arrampica, si danza, si gira in tondo, sempre più vorticosamente, si accelera, come in uno slapstick. Tra la terra che riempie il palcoscenico, si impara a ricordare, a dimenticare.
 Nathalie Béasse, Le bruit des arbres qui tombent, ph. J. Blin
Nathalie Béasse, Le bruit des arbres qui tombent, ph. J. Blin
Non abbiamo incontrato un nuovo Grotowski o un nuovo Kantor, una nuova Mnouchkine o un nuovo Marthaler. Forse. Abbiamo visto segni di un lavoro svolto con passione, con profondità, con l’ansia di interrogare se stessi, il mondo, lo stesso teatro e le sue possibilità non convenzionali di rappresentarci, di rappresentarsi, quando ogni possibilità di efficace restituzione, raffigurazione, sembra inficiata dal continuo mettersi in scena sociale e mediatico, e il segno necessario sembra essere solo quello dirompente o, all’inverso, quello implosivo, che porta verso se stessi, l’interiorità, le profondità del silenzio echeggianti dal frastuono del mondo.