Speciale
Gli animali di Kafka
Negli ultimi tre racconti di Kafka – Ricerche di un cane, Josefine, la cantante o Il popolo dei topi, La tana, scritti tra il 1922 e il 1924 – i protagonisti sono animali, rispettivamente un cane, un topo, un animale che scava (si pensa a una talpa o a un tasso). Li differenziano i rispettivi tratti: il primo è un ricercatore, la seconda è un’artista, il terzo è un essere alla ricerca di protezione. La loro posizione è fondata sull’eccezione. Il cane è diverso dagli altri appartenenti alla sua specie; Josefine, oltre ad essere l’unica a possedere un nome, è la sola del popolo dei topi ad avere il dono del canto; il terzo è una creatura costantemente sotto assedio, minacciata da nemici inesorabili e mordaci che potrebbero colpirlo in ogni momento, ed è impossibilitato, per ragioni di prudenza, ad avere degli amici.
Gli animali, negli scritti di Kafka, sono presenze frequenti che, intrecciando mascherature autobiografiche e simbolismi, hanno guidato acute riflessioni, come quella proposta negli anni Settanta da Deleuze e Guattari in Kafka. Per una letteratura minore. Secondo il tracciato fornito da Roberto Calasso in L’animale della foresta (edito da Adelphi), scrivendo di animali, “è come se Kafka sia voluto scendere in uno strato più largo di ciò che è… perché tutto ciò che gli appartiene è già presente”. Cosa ci dicono allora gli animali degli ultimi tre racconti? Il primo, il cane, “è la massima approssimazione che Kafka ci ha lasciato, e la più perfetta, a un profilo di autobiografia”. Il secondo, Josefine, mette l’accento sull’insufficienza di “qualsiasi arte, anche dello scrivere”, cioè “racconta la loro inadeguatezza insanabile. Di conseguenza, la loro fondamentale inutilità”. Il terzo ha un ruolo decisivo, perché, finalmente, con La tana Kafka dichiara “il vero nome” del “Nemico”, la cui presenza circola in tutti gli scritti del grande scrittore di Praga: si tratta degli “animali dispersi e brulicanti, sopra e sotto la superficie della terra”, rimasti ormai “gli unici interlocutori di cui narrava”.
Ricerche di un cane è narrato in prima persona. Il cane che indaga ha lasciato la sua specie. Che qualcosa in lui non tornasse, lo aveva sempre saputo, perché a contatto con i suoi simili affiorava una “piccola falla”, un “malessere”, inizialmente reso tollerabile grazie a “certi amici” che gli permettevano di “lasciar sussistere” in lui il cane, “un po’ freddo, un po’ riservato, ansioso, calcolato, ma tutto sommato un cane normale”. Ovvero un animale verso cui Kafka ha sempre mostrato disprezzo, animale edipizzante, secondo la definizione di Deleuze e Guattari, animale che ci riporta tra gli umani, servile, allineato, conservatore. Animale degradato nella tradizione ebraica, sottouomo. Così, “un giorno può succedere che quella “piccola falla” si trasformi in una “voragine” che finisce con “l’avvolgere e intridere ogni altra forma di vita”.
La “voragine” è “sonora”, provocata dall’epifania dei sette cani, che “sprigionano musica dallo spazio vuoto”, trasformando il cane bambino nella vittima. I cani musicanti agiscono contro la legge, stanno ritti sulle zampe posteriori, “i loro gesti avevano qualcosa di indecente”. È per questo che stanno zitti? È per questo che sembrano angosciati, schiacciati forse dal senso di colpa? Con il loro comportamento fanno pensare che il mondo sia alla rovescia. I cani musicanti provocano quell’incertezza – una delle condizioni più ricorrenti in Kafka – che sta all’origine delle domande del cane bambino e della sua decisione di diventare ricercatore.
In Josefine, la cantante o Il popolo dei topi, la protagonista sembra in possesso di un’arte che nessun altro conosce. Chi dice io nella storia – non sappiamo chi sia – però non ne è così sicuro. Forse tutti i topi una volta cantavano, ma ora, spinti dalla “lotta per l’esistenza”, hanno dimenticato come si fa, anche se talvolta sembrano riemergere dal passato ombre di ricordo. Però c’è dell’altro. Forse Josefine non canta ma fischia. Ovvero fa quello che tutti i topi sanno fare. Per qualche motivo, soltanto lei ne possiede consapevolezza. E se ne serve per incantare il popolo che accorre alle performances – Josefine bisogna vederla oltre che ascoltarla – rimanendo in silenzio mentre lei canta. Col canto dà loro quella pace, che momentaneamente sottrae i topi dalla loro esistenza piena di “sorprese, angosce, speranze, terrori”.
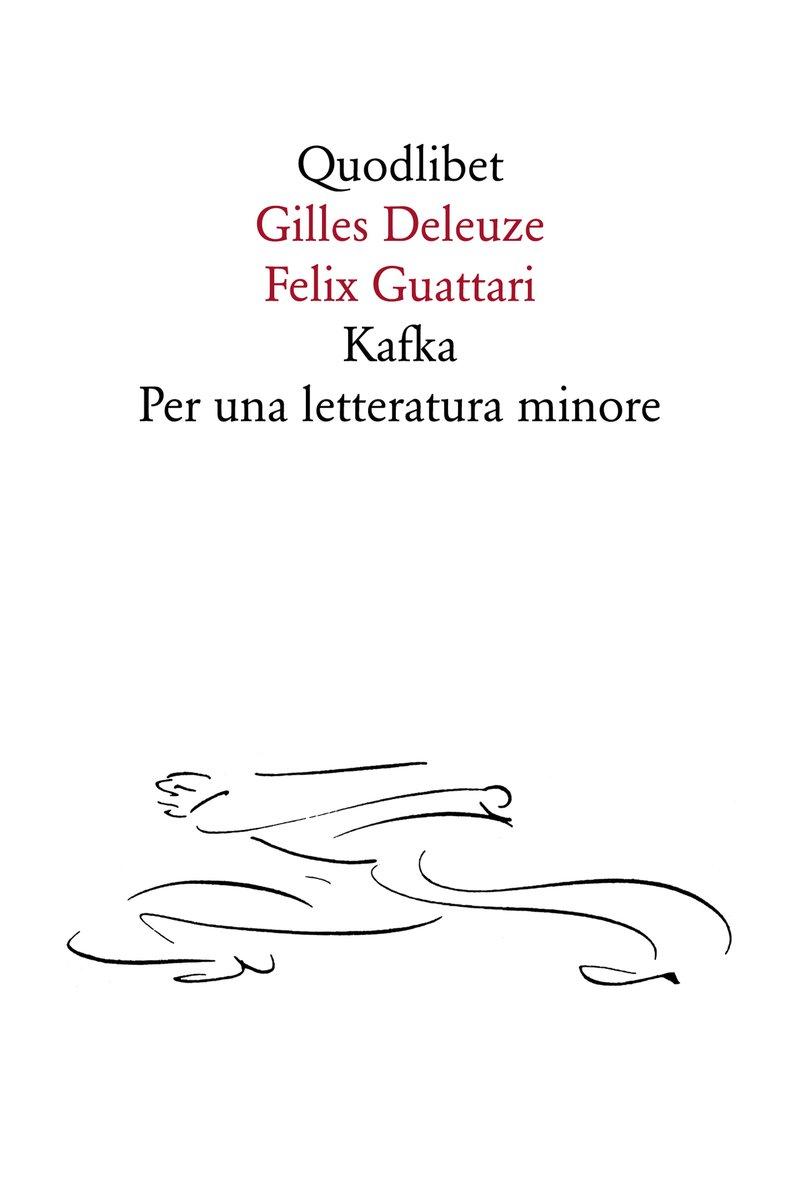
“Nella Tana chi parla è un essere che scava. Di lui si sa soltanto che il suo corpo gli permette di scavare”. L’interpretazione ordinaria – che Calasso evita – fa della voce narrante una metafora dello scrittore. Quanto si legge è che questo animale scava con la testa ed è ossessionato dal raspare delle grinfie dei nemici, che non ha però mai visto. La tana che ha allestito – e non edificato – è stata realizzata inizialmente per gioco, costruendo un labirinto là dove già esisteva qualcosa. Si è trattato però di un errore, perché nei meandri del labirinto le incursioni del nemico possono avvenire con più facilità. Del resto la tana non ha validi sistemi di protezione. Un “grosso buco” la separa dall’esterno, dove chi racconta ama andare a cacciare. Ma l’esterno, anche se non è disprezzato, è il luogo del rischio, da dove separarsi per la propria salvezza. Sul racconto si allunga il duplice senso del titolo: Der Bau in tedesco significa infatti “costruzione” e “tana”, ovvero “ciò che è più visibile e non si può non vedere – e ciò che è più invisibile, al punto che non se ne può desumere la presenza”. Il titolo definisce “l’oggetto del racconto”, cioè “il rapporto tra ciò che si costruisce nel visibile e ciò che si costruisce nell’invisibile”.
Quest’ultima sembra la vocazione di tutti e tre i protagonisti dei racconti. Al mondo com’è, l’animale ne affianca un altro, perché nel mondo c’è qualcosa di intollerabile. Mentre lo scavatore opera separato da tutti, nel chiuso della fortezza assediata, il cane e Josefine stanno in mezzo ai loro simili, che però non li comprendono. Il cane ricercatore si muove, oscillando tra impazienza e sarcasmo, in un tempo – la Grande Guerra era finita da poco – in cui domina “l’esitazione” e in cui “la parola sfuggiva ormai a tutti” e, tra i cani “normali”, si rimane in silenzio. Il popolo dei topi non capisce Josefine. “Compatto e dotato di scaltrezza pratica”, dubita di lei. Se il suo canto fosse solo un fischio non si scomporrebbe, perché “sa vivere benissimo senza alcuna aggiunta”. Né sa dare alla cantante quello che lei pretenderebbe da loro, “una devozione assoluta”, di cui il popolo dei topi “si ritenne, per costituzione, incapace”. A parte una “pattuglia” di avversari implacabili, i topi però lasciano fare Josefine e, in qualche modo, la rispettano. Di lei non ridono mai, e, anche se lei è convinta del contrario, loro la proteggono. Così, pur sapendo che Josefine, col suo canto, “non salva nessuno”, e che in fondo approfitta della puerilità di esseri di cui “non si conosce la giovinezza”, nessuno si oppone alle sue “incongrue pretese”, anche se nessuno, secondo Josefine, le dà il riconoscimento a cui aspira. Quando Josefine scompare, ben presto viene dimenticata, perché se l’arte è anche un inganno, “il popolo dei topi non aveva tempo di farsi ingannare”.
Nel gennaio del 1922 Kafka “dà l’assalto all’ultimo confine terreno”. Si lascia alle spalle la letteratura, a cui si era dedicato negli ultimi dieci anni, a partire da La sentenza, per incamminarsi verso “una dottrina segreta, una cabbala”. E “allora Kafka”, scrive Calasso, “tornò tra gli animali: fra i cani, i topi, e tutti quelli che si costruiscono una tana”. All’essere animale, a questo estremo livello, affida qualcosa in più del gioco metaforico, è evidente. Trasferirsi negli animali degli ultimi racconti non è nemmeno una metamorfosi. Le due straordinarie lettere con cui Calasso chiude il libro ci danno alcuni suggerimenti su come dovremmo orientarci. La prima è di Milena a Max Brod. “La vita per lui è cosa radicalmente diversa che per gli altri”, scrive, “questo nostro mondo è e resta un enigma per lui. Un segreto insondabile. Qualcosa che non è alla sua portata e che lui ammira con un’assoluta e commovente ingenuità perché pieno di zelo”. “Franck non sa vivere”, conclude, “lui non ha mai cercato un rifugio che lo proteggesse… è un uomo costretto all’ascesi dalla sua terribile chiaroveggenza, purezza e incapacità di ascendere a compromessi”. La seconda è delle “ultime laceranti lettere” di Kafka a Milena. “Io che sono un animale nella foresta …mi accucciai vicino a te…come se ciò fosse lecito, posai il viso nella tua mano, ero così felice, così fiero, così libero, così potente, mi sentivo talmente a casa – ma in fondo altro non ero che l’animale, il cui posto era la foresta, ora vivevo lì nell’aria aperta solo per la grazia che tu mi concedevi, e, senza saperlo perché ormai non ricordavo più nulla, leggevo nei tuoi occhi il mio destino”.
Leggi anche
Marco Belpoliti, Kafka e la vergogna
Guido Monti, Una carezza alla nuca di Kafka
Giuseppe Di Napoli, Kafka, scarabocchi e disegni
Andrea Pomella, Kafka. La vita è qualcosa di più di un gioco di pazienza
Francesco M. Cataluccio, Kafka. Un tram chiamato lampione
Alessandro Banda, Kafka: una volta, sai, ero un gran disegnatore...
Paola Albarella, Tutto “Il processo” a Berlino
Gabriele Gimmelli, Il gabinetto delle meraviglie del dottor K.







