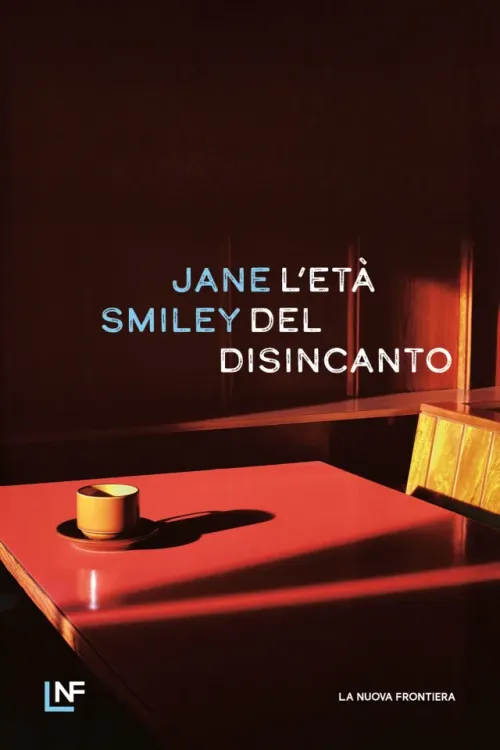Jane Smiley, l’America del disincanto
In casa Hurst va tutto a gonfie vele. Dana e Dave sono due dentisti di successo. Una coppia perfetta. Hanno tre figlie piccole, quattro dipendenti, uno studio all’avanguardia. Sembrano felici. Non è il genere di scenario che promette grandi storie ma nelle mani di Jane Smiley si trasforma nell’indimenticabile ritratto di una crisi esistenziale. L’ultimo lavoro della grande scrittrice americana portato in Italia da La Nuova Frontiera, L’età del disincanto, sceglie il territorio ristretto e spesso claustrofobico di una famiglia benestante per svelare le profonde tensioni su cui si regge. L’autrice, che nel suo capolavoro Erediterai la terra aveva ricreato la tragedia di Re Lear nelle immense pianure dell’Iowa, qui svolge il filo di una coppia con la precisione di un chirurgo. Il risultato sono 120 pagine che regalano ai lettori l’anatomia di un matrimonio e uno squarcio d’America di stringente attualità
A raccontare la vicenda, in un andirivieni fra passato e futuro, è il marito Dave. La protagonista, com’è chiaro fin dalle prime righe, è però Dana. Bella, capace, elegante. Il genere di donna che intimorisce gli uomini. I due si innamorano, si sposano. Nascono le bambine, il lavoro ingrana. Quando la storia prende il via, sono ormai così ricchi da lavorare solo mezza giornata. Poi, all’improvviso, la crisi. “Non so se sarò mai più felice”, dice lei una sera. Si è innamorata di un altro, pensa lui.
È uno spunto classico ma quel che segue è una sorpresa letteraria. In un romanzo di John Updike, che alle coppie suburbane e al loro scontento ha dedicato pagine travolgenti, il brusco risveglio di Dave sarebbe accompagnato da rivelazioni, colpi di scena, fiumi di alcol e gossip. Smiley invece abbassa i toni. Dosa le parole e affida la resa dei conti ai silenzi e al brusio delle emozioni. Less is more. La vicenda, a tratti esilarante, dei due dentisti diventa così una maliconica riflessione sul matrimonio, l’amore e il passare del tempo.
In questo territorio intimo, Jane Smiley coglie un tema universale. L’età del disincanto (trad. Valentina Muccichini) fotografa l’attimo in cui la vita sembra aver assunto la sua forma definitiva: il momento in cui l’orizzonte sparisce alla vista perchè siamo arrivati o così ci dicono. Non più infinite possibilità da conquistare ma responsabilità, doveri, routine – il sogno che diventa realtà e si rivela una prigione. È l’addio alla giovinezza, l’ingresso nel mondo degli adulti. “Ho trentacinque anni, e ho l’impressione di essere giunto all’età del disincanto”, realizza Dave. “Qualcuno ci arriva prima. Quasi nessuno ci arriva molto più tardi [...] So che in seguito si giunge all’età della speranza, o almeno della rassegnazione. Temo ci voglia parecchio per arrivare fin lì”, conclude.
In questa condizione sospesa, il presente assume un sapore diverso e pungente. “Vorrei che mia moglie mi amasse. Vorrei che i suoi occhi azzurri si posassero su di me con desiderio anziché con rimpianto. Mi chiedo se non sia sempre stato un po’ ai margini del suo sguardo. Una presenza necessaria nella vita che vuole condurre, ma pur sempre una presenza, solo una presenza.”
Eppure, si ripete Dave, il matrimonio ha una potenza insostituibile. Essere single, riflette, “Era come guidare un motorino su una strada di campagna, sobbalzando a ogni dosso, arrancando a ogni salita. Il matrimonio invece è come un camion, o almeno come un grosso pick-up con pneumatici enormi. Travolge tutto ciò che incontra sul suo cammino, lanciandosi verso il futuro con la forza di qualcosa di imponente e inarrestabile”.
È un paragone folgorante, considerata la passione degli americani per i pick up. Ruote smisurate, cofano ad altezza d’uomo, motore rombante. È un frammento del mito. Ci si mette in strada come si va alla guerra, come nel selvaggio West, come nella wilderness. L’individuo contro il resto del mondo. In questa chiave, il matrimonio è una fortezza. Noi contro gli altri. Sarà abbastanza da tenere insieme gli Hurst? È abbastanza da tenere insieme chiunque di noi?
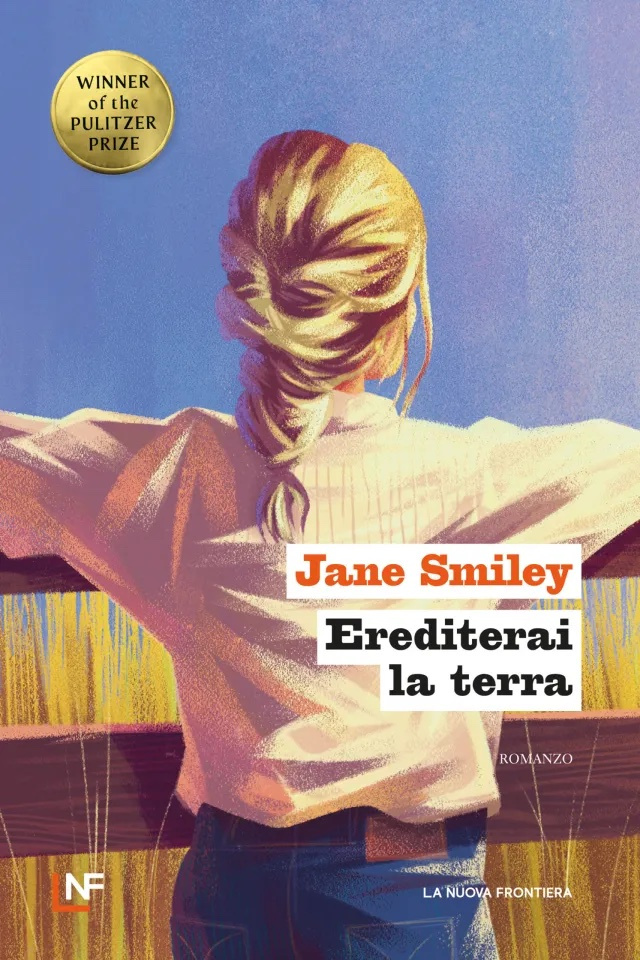
Più che nelle risposte, che si riveleranno spiazzanti, la forza di L’età del disincanto è nella sua capacità di illuminare il ritmo ineffabile del quotidiano, la scansione dell’intimità familiare, il tempestoso rapporto fra genitori e figli. È una strizzata d’occhio alle coppie che si guardano indietro e dicono con orgoglio “guarda cos’abbiamo costruito”. Ed è la radiografia di un incubo per chi sogna di attraversare la vita in sella a un motorino, il vento nei capelli e nel cuore la leggerezza dello sradicamento. È il genere di racconto che tocca il cuore di chiunque si sia mai trovato a vivere in coppia ed è al tempo stesso una storia squisitamente americana.
Basta guardare la vita degli Hurst. Le loro giornate si snodano fra casa, lavoro, shopping. È il perimetro di una società che ha riscritto i codici tradizionali e ormai gravita intorno alla famiglia nucleare. È un fenomeno che affonda le sue radici negli anni del dopoguerra. Gli americani bianchi abbandonano le città, dove le tensioni razziali sono spesso incandescenti e le case datate. Si dirigono verso i sobborghi dove le villette a schiera si moltiplicano in uno sprawl incontrollato.
È un esodo che ridisegna in modo radicale intere comunità. Mentre le aree urbane si svuotano, i tradizionali legami di quartiere vengono meno e gli spazi pubblici condivisi si riducono fino a sparire. È un nuovo paesaggio sociale. L’isolamento cresce e anche questa è una scheggia del mito a stelle e strisce. Ogni americano è re a casa sua, si dice. Il prezzo di quel regno è la solitudine ma di questo è assai più difficile parlare.
Sono temi che oggi suonano acquisiti. Negli anni in cui Smiley scrive iniziano però appena ad affiorare alla coscienza collettiva. In questo senso, vale la pena soffermarsi sulle date. La novella L’età del disincanto esce sul numero primaverile della rivista The Quartely nel 1987. Dieci anni più tardi è pubblicata, in una raccolta di racconti, con il titolo The age of grief. Il clima del paese sta ormai mutando e ancora una volta la letteratura si rivela capace di anticiparne le correnti sotterranee. La conferma arriva da un altro libro. Nello stesso periodo, in tutt’altra chiave, lo studioso Robert Putman fotografa la trasformazione in Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000) un lavoro che ormai è una pietra miliare.
Putman punta il dito sul declino del capitale sociale negli Stati Uniti a partire dagli anni Cinquanta. I nessi che fino allora saldavano gli americani, sostiene, sono venuti meno. Non solo il tessuto urbano si è disgregato e così le relazioni di vicinato ma l’associazionismo, che nella storia americana è stato un collante portentoso, è sulla via del tramonto. Gli americani non hanno smesso di giocare a bowling ma lo fanno per conto loro. Le leghe sportive, un tempo fiorenti e numerose, sono ridotte al lumicino e lo stesso vale per le associazioni civiche, quelle religiose e femminili.
Bowling Alone è un testo fondamentale per decifrare l’isolamento che sempre più segna il paese. Putnam fotografava la realtà degli anni Cinquanta e da allora, complici i social media e le piattaforme di streaming, la tendenza registra una costante accelerazione. Nel 2023 il General Surgeon Vivek Murthy lanciava l’allarme sulla solitudine e i suoi drammatici effetti sulla salute collettiva. Un’epidemia in piena regola, a suo dire, paragonabile all’impatto del fumo di sigaretta e dell’obesità. Benché i consigli in materia da allora si sprechino, è difficile intravedere una via d’uscita. I nuovi dati dell’American Time Use Survey dicono che in una giornata normale solo 3 americani su dieci socializzano o comunicano con qualcuno. Si sta in casa molto più del passato – una sorta di lockdown volontario.
Se le conseguenze mediche sono state sviscerate fino all’ultimo dettaglio, meno si è parlato di quelle politiche e democratiche. Per una diagnosi, vale allora la pena tornare a Bowling Alone dove l’erosione del capitale sociale va di pari passo con l’erosione della democrazia e della partecipazione, verso una società sempre più frammentata, polarizzata e tribale. Per una verifica, basta guardarsi attorno. L’ultima parola spetta dunque a Jane Smiley. A queste condizioni, manda a dire la scrittrice, la possibilità di scelta si restringe in modo drammatico e l’amore c’entra poco. Se così va l’America, meglio proteggersi dietro le mura del matrimonio. È un “contenitore troppo piccolo”, realizza Dave, ma è l’unico modo per non affogare – l’unico modo per portare avanti la mitica fiaccola dell’American Dream.