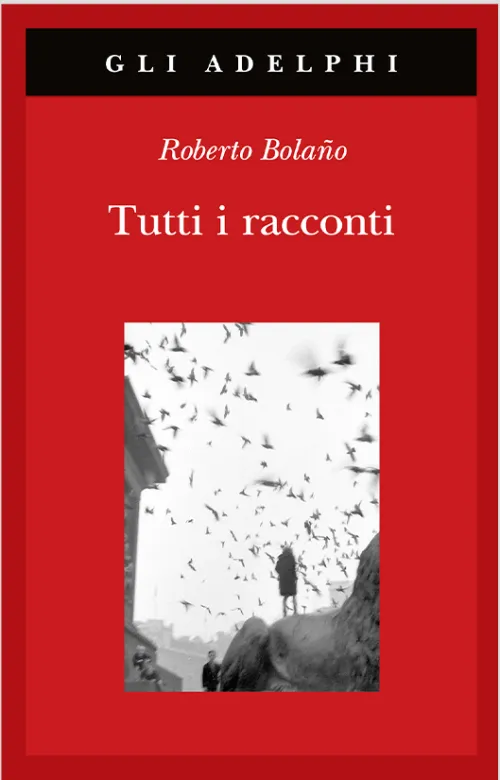Bolaño breve
Raccontava Roberto Bolaño che, quando in Italia gli chiesero di parlare dei suoi sei mesi di prigionia trascorsi nel 1973 a Santiago in mano ai golpisti, fu costretto a spiegare che erano stati solo sei giorni e come in Germania fosse rimbalzata una sua nota biografica che, di romanzo in romanzo, era sempre diversa cambiando la durata dell’arresto: nel primo era stato di un mese, nel secondo – “visto che il primo non aveva venduto molto” – di tre mesi, nel terzo di quattro e nel quinto i mesi erano diventati cinque. In Italia salirono a sei.
Evidentemente si voleva creare il personaggio, dal momento che lo scrittore cileno, poi messicano e infine spagnolo, scontava anche in Italia il prezzo di una crescente fortuna che riguardava – fino al superamento del semplice succès d’estime precedente al 1998 e all’affermazione di I detective selvaggi – più l’opera che la vita. Il rilancio e il definitivo riconoscimento nel gotha della letteratura di lingua spagnola si sarebbe avuto con 2666 che dell’autore scomparso nel 2003, quando verrà dichiarato il principale autore moderno latinoamericano dopo Márquez, farà uno scrittore cult (più conosciuto che letto, per sua stessa ammissione), unanimemente celebrato per aver voluto terminare il suo romanzo monstre trascurando l’urgenza di un ricovero in ospedale, così immolando la vita alla letteratura.
Proprio perché consapevole delle proprie condizioni fisiche, Bolaño voleva che le cinque parti del romanzo uscissero autonomamente, à la Proust, così da assicurare ai due figli e alla moglie introiti economici a più riprese, ma il suo biografo Ignacio Echevarría insieme con l’editore Jorge Herralde (colui che l’aveva scoperto pubblicando nel 1996, il solo dopo decine di rifiuti, Stella distante) optarono per il volume unico: scoraggiando così i lettori alle prese con mille pagine dove la narrazione disobbedisce in pieno ai modelli del page turner, richiedendo piuttosto uno spirito di riflessione che deve fare propri i generi del crime, del giallo, del noir, dell’odeporico, della denuncia civile, politica e sociale, tra essais, pamphlet ed elzeviro.
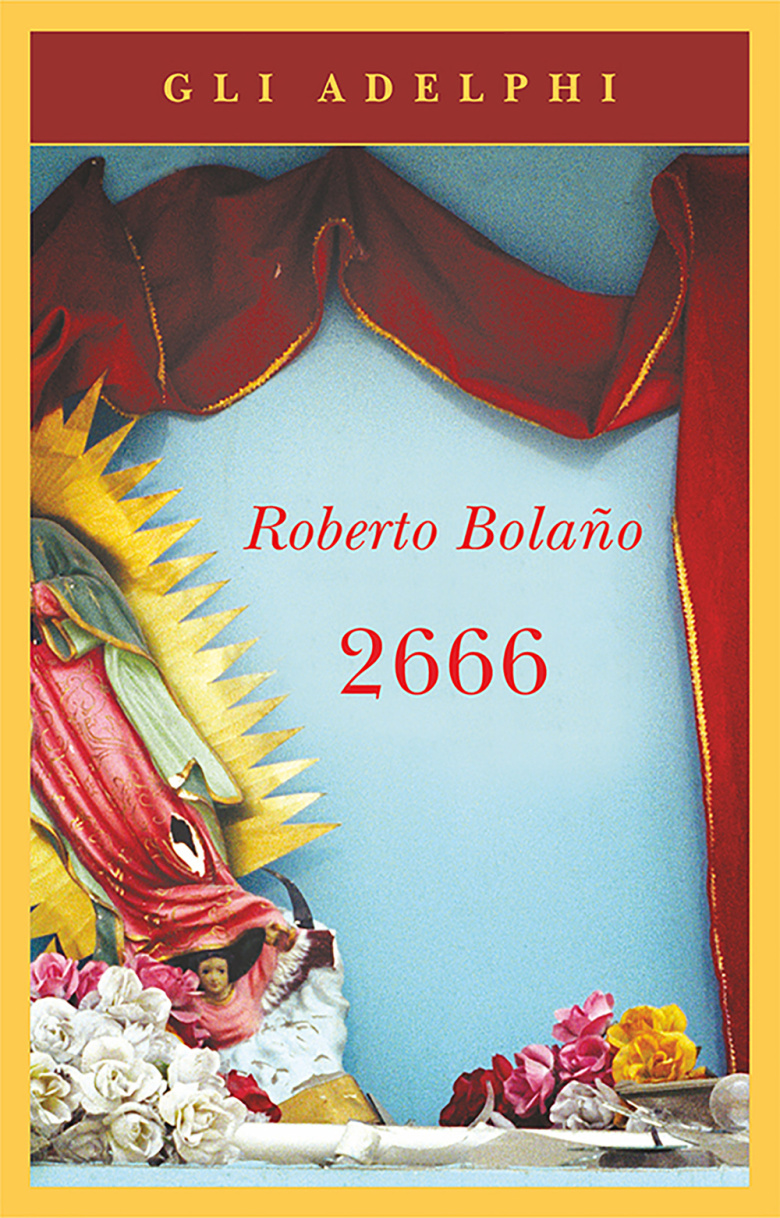
Romanzo incompleto nell’intreccio ma non nella fabula (Benno von Archimboldi non viene mai trovato dai quattro critici appassionati della sua opera, prime mover del romanzo, e tuttavia nella ricerca gli studiosi europei arrivano sua mercé – e rivolgendo il motivo conduttore – a Santa Teresa in Messico, teatro di un’agghiacciante catena di femminicidi, storicamente documentati a Ciudad Juarez), 2666 si costituisce come il coronamento di una cifra distintiva di Bolaño: la troncatura. Che è espressa in maniera manifesta e ricercata soprattutto nei racconti, come pure nella vasta opera di interventistica, tra conferenze, recensioni, articoli giornalistici, medaglioni e note di critica letteraria compresi tra il 1998 e il 2003 e da Echevarría raccolti nel 2004 in Tra parentesi (Adelphi, 2009), nel dubbio da lui stesso confessato di avere davvero scelto e ordinato i brani secondo quella che sarebbe stata la volontà dell’autore. Un autore che, nell’arco di pochi anni, vedendo prossima la fine, ha scritto in maniera forsennata e disordinata su più lavori contemporaneamente e saltando da uno all’altro, e che ha lasciato un’abbondanza di testi sui quali, d’accordo la vedova, sia l’editore spagnolo che quello italiano, Adelphi, hanno agito svuotando i cassetti e anche in divergenza, nell’incertezza del rispetto del canone bolaniano.
In Tutti i racconti, uscito quest’anno per la traduzione di Barbara Bertoni e Ilide Carmignani, la casa editrice milanese ha riunito in un unico corpus le raccolte già note di Chiamate telefoniche, Puttane assassine e Il gaucho insostenibile, aggiungendo diciassette inediti che ha pensato di intitolare “Racconti postumi”, non tenendo però conto che postume sono anche altre opere tra romanzi brevi e racconti, peraltro già uscite in Italia sotto la stessa sigla.
Il titolo avrebbe dovuto essere “Il segreto del male” (riportato come sottotitolo e nella fascetta di copertina), lo stesso di un racconto del compendio secondo la prassi bolaniana per cui uno di essi eponima ogni raccolta, ma la prima edizione spagnola comprende testi che in quella italiana mancano, certamente perché fin troppo frammentari e incompleti. Manca per esempio “Spiaggia” (che è completo e che comunque si può leggere in Tra parentesi dove compare anche una versione pressoché analoga intitolata “Sole e teschio”) a motivo probabilmente dello stato di eroinomane dell’io narrante, quasi sempre un alter ego dell’autore: scelta tuttavia discutibile perché proprio nei Racconti postumi tre di essi, “Abbronzatura”, “Muscoli” e “Daniela”, contano come narratori donne e non per questo appaiono suscettibili di addensare equivoci sull’autore.
L’incompletezza dunque, o meglio la troncatura. Proprio in “Il segreto del male” ne è espresso il principio quando l’autore avverte all’inizio che “è un racconto inconcluso, perché questo tipo di storia non ha un finale”, premettendo che esso “è molto semplice, anche se avrebbe potuto essere molto complicato”. Padrone del red herring più sofisticato, Bolaño stabilisce qui la sua legge costitutiva: sviare sempre il lettore fornendogli falsi indizi, creando attese e deludendole, nel fondamento che una storia può dilungarsi a dismisura come in 2666 o può invece troncarsi dopo due pagine, ma soprattutto nel proposito di lasciare al lettore di trovare la propria chiave di lettura del sottotesto.
Qui un giornalista viene svegliato di notte da uno sconosciuto che deve dargli un’informazione. I due vanno in un bar, il giornalista gli fa “Bene, mi dica” e lo sconosciuto gli sorride e quando smette “i suoi lineamenti riprendono all’istante un’aria gelida”. Fine. Semplice, ma certamente complicato se non incomprensibile. Il male nasconde forse un segreto che spetta a chiunque svelare, secondo la personale teodicea laica? E questo male ontologico, dopo 2666, titolo a carattere satanico, assume un fondo metafisico di tipo immanentistico? Bolaño non dà risposte. Preferisce sempre preparare pasti per una tavola alla quale non siede mai.

In “Il quartiere di Lindavista” ricorda in prima persona la propria fanciullezza messicana in una casa al cui piano superiore una coppia di coniugi faceva di notte inequivocabili rumori, finché un amico biondo del marito non cominciò ad andare a trovarli di sera. Il piccolo Bolaño sentiva che poi il biondo andava via e si metteva in attesa dei soliti rumori che però non arrivavano. Fine del racconto. Anche questa è un tipo di storia che non ha finale? O il finale è quello più facilmente intuibile di un partouze? In “La stanza accanto” l’io narrante in una camera d’albergo sente parlare due individui uno dei quali confessa di avere ucciso la moglie. Verso l’alba, quando decide finalmente di dormire sente dall’altra parte una voce femminile che dice “Buonanotte”. Il finale? “In quel momento osservai la mia stanza, che aveva tre letti, come la camera accanto, ed ebbi paura e voglia di urlare, ma mi trattenni perché sapevo che dovevo farlo”.
Bolaño è in questa sospensione del tempo narrativo e nell’interruzione che opera nello svolgimento vitale dei personaggi. Moltissimi dei quali sono sue trasposizioni. In “I giorni del caos” arriva a immaginare sé stesso nel ricorrente doppio di Arturo Belano, che nel 2005 è poco più che cinquantenne e ha un figlio quindicenne che ha fatto il suo primo viaggio all’estero, come lo stesso Bolaño alla stessa età quando lascia il Cile per il Messico. “Questo successe nel 2005” ripete a ogni paragrafo, aggiungendo alla fine: “A volte gli sembrava incredibile di essere ancora vivo”. Il racconto è del 1998, tre anni dopo la diagnosi infausta, e la possibilità di arrivare a vivere fino al 2005 è vista da lui come “incredibile”, mascherando una straziante e vana speranza.
Arturo Belano non è solo il coprotagonista insieme con Ulises Lima in I detective selvaggi (entrambi alla ricerca di una poetessa, come in 2666 la ricerca riguarda uno scrittore) ma lo troviamo nel racconto iniziale, più esattamente una scheda biografica, “Il vecchio della montagna” e in “Morte di Ulises”, l’amico che Belano va a trovare a Città del Messico dopo moltissimi anni apprendendo che è stato investito da un autobus, come è successo a Mario Santiago, di cui Ulises Lima è un eteronimo, e che è il vero e più grande amico di Bolaño, poeta per lui grandissimo ma mai pubblicato, secondo il destino toccato a un gran numero di insigni lirici dimenticati o incompresi costretti nell’ombra “dal mondo canagliesco (che si finge cavalleresco) delle lettere”, dominato soprattutto da Octavio Paz, poi da Vargas Llosa e Gabriel Márquez, gli ierofanti della letteratura latinoamericana che insieme con Cortazár e Borges, modelli formativi riconosciuti dal Bolaño giovane lettore, costituiscono l’establishment letterario, dotato di un potere che è anche politico e che consente loro di essere beneficiari di sovvenzioni di Stato, una caduta questa che Bolaño non perdona a nessuno, facendone un implacabile atto d’accusa. Il Bolaño che non ama Márquez e Llosa perché li vede impegnati e compromessi in politica, sembra dimenticare che da giovane lui stesso ha fatto politica militando come trotzkista e finendo in arresto. Ma un conto è per lui la rivoluzione, un altro la corrività.
È da questa indomita temperie giovanile che nasce l’Infrarealismo, fondato insieme con Mario Santiago come movimento di fronda che rompa con la tradizione consolidata e accolga nelle lettere istanze avanguardiste. In questa prospettiva Bolaño guarda anche a uno dei due soli italiani, oltre Calvino, che figurano nella sua genealogia: il Sanguineti del Gruppo 63, pioniere dell’antiformalismo e della ricerca sperimentale, esempio di scrittura da un lato non legata a stilemi anche grafici divenuti ufficiali (sicché Bolano, tranne che in 2666, che segna il ritorno inatteso alle regole, ridurrà al grado zero le virgolette nel parlato come anche i troppi capoversi) e da un altro libera da ipoteche che obblighino a un genere, a un’ortodossia della trama con un inizio e una fine di prammatica clarté, a un didascalismo che tenga l’autore al fianco del lettore, nell’urgenza di rendersi piuttosto anticonvenzionali anche nell’approccio alla sfera dei sentimenti e alla retorica delle forme in uso.
Per questa via si stabilisce anche il rapporto di Bolaño con Italo Calvino, reduce dall’esperienza dell’Oulipo e le sue contraintes, dandosi egli stesso rigorosi vincoli non matematici ma epistemologici che gli impongono la massima cura tanto del personaggio, visto come soggetto non pensante ma agente, quanto del plot, ricorsivo fino alla formula, se si pensa che non c’è romanzo o racconto significativo che non esplori la resilienza di un poeta o uno scrittore ai regimi oppressivi e alla violenza. «I miei romanzi girano attorno alle stesse trame» conferma infatti in un’intervista contenuta in L’ultima conversazione (Sur, 2012).
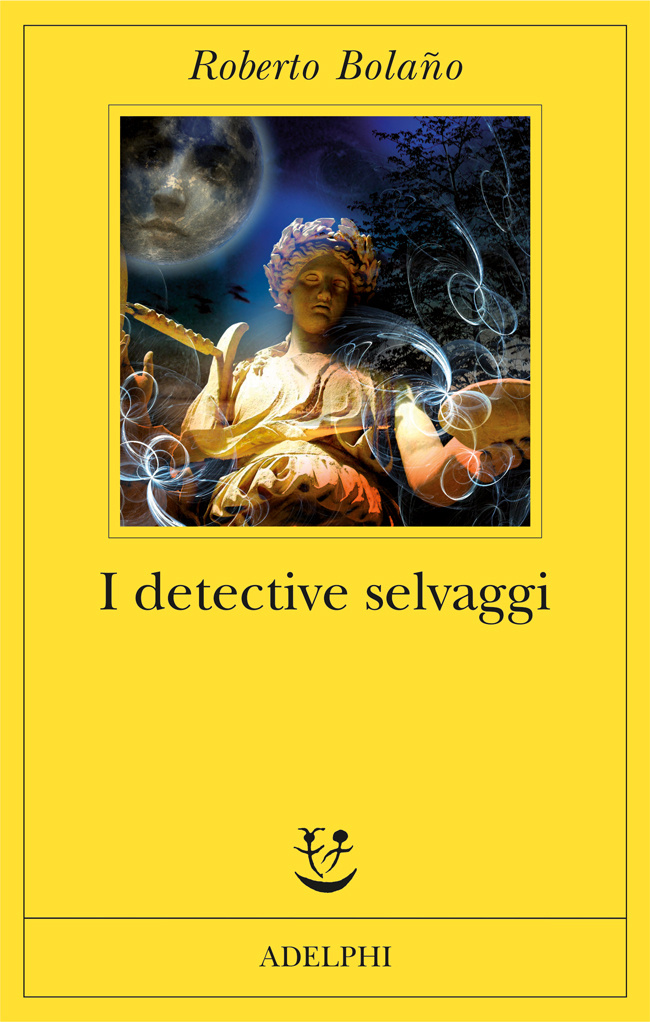
Non solo in I detective selvaggi e in 2666 (i massimi titoli, ricondotti con bella intuizione da Bolaño, per la loro natura di quête, il primo a Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain e il secondo a Moby Dick di Melville, lì nel territorio del bene e qui in quello del male) ma anche negli altri romanzi come Stella distante (un poeta che diventa serial killer), Amuleto (una poetessa che si nasconde in bagno all’occupazione dell’università da parte della polizia) e Notturno cileno (scrittori in salotto a festeggiare mentre in cantina i dissidenti vengono torturati) Roberto Bolaño non si occupa che di letterati e di letteratura, nel convincimento chiaramente espresso che la letteratura significhi “saper ficcare la testa nel buio, saper saltare nel vuoto, sapere che è un mestiere pericoloso”. Ma che ha anche un potere lenitivo, essendo la letteratura il solo anodino capace di riscattare le coscienze dall’empusa sempre incombente del male. In realtà per Bolaño il mondo si divide tra quanti leggono e quanti scrivono, ciò che spiega perché figurino racconti e scene in cui chi è in un bar o in spiaggia con un libro in mano suscita immediatamente la sua attenzione.
Quelli che scrivono e richiamano il suo interesse sono principalmente gli autori ispanofoni che conosce nella loro totalità, dai mostri sacri come Neruda ai cari ma secondari Nicanor Parra, Rey Rosa, Osvaldo Lamborghini, Alphonse Daudet. Con gli autori europei è invece tiepido, pur vivendo in Catalogna dal 1977. Degli italiani, tranne Sanguineti e Calvino, assunti quali riferimenti di scuole di tendenza, non ha una grande considerazione. Semmai ha pesanti pregiudizi.
In un racconto postumo, “Savi di Sodoma”, intrattenendosi sulla “passione nefanda” degli argentini per la sodomia, argomenta che essa nasce dalla loro origine di terra di emigranti impoveriti provenienti da Spagna e Italia: “I contadini spagnoli e italiani, dalle abitudini barbare, portano nella pampa non solo la miseria ma anche le loro abitudini sessuali, fra cui la sodomia”. In verità immagina che queste considerazioni siano di V.S. Naipaul, che in realtà ha pubblicato una raccolta di saggi sull’Argentina senza però sognarsi ovviamente di parlare di sodomiti. Lo fa Bolaño pretestando l’idea di un racconto su Naipaul lasciato a metà nel quale ricorda che il premio Nobel avesse affrontato l’argomento della nefanda passione. Che lui dichiara in un beffardo e magistrale virtuosismo “inconsistente e priva di fondamento storico e sociale”, precisando che Naipaul non poteva sapere niente “delle abitudini sessuali di cafoni e terroni spagnoli e italiani negli ultimi cinquant’anni dell’Ottocento e dei primi venticinque del Novecento”, senonché poi dice la sua: “Non dico che non si praticasse la sodomia nei buoni matrimoni contadini in Sicilia e a Valencia, ma non con l’assiduità di un’abitudine sessuale destinata a durare oltremare”: negando così la tesi, invero mai sostenuta, di Naipaul e nello stesso tempo recependo uno storico e abusato luogo comune in un bagaglio personale di consapevolezze che ripudia invece con forza e per scelta ogni stereotipo.

L’Italia di Bolaño è piuttosto più presente nei modi in cui ricorre nel racconto “Joanna Silvestri” di Chiamate telefoniche, colta l’immagine di Los Angeles le cui strade “cominciavano a scivolare dentro al buio, sotto il manto della notte come in una canzone di Nicola Di Bari”.
I Racconti postumi appartengono perlopiù al triennio 1998-2000 ma ce ne sono altri del 2001 e persino del 2003. Un mistero è costituito da “Il provocatore”, che risulta scritto nel 2000-2001, epperò tratta delle manifestazioni a Barcellona contro la guerra in Iraq nel 2003, scoppiata il 20 marzo. Le proteste di piazza, molto accese nella capitale catalana, si ebbero a febbraio e Bolaño muore il 15 luglio. Il racconto non può dunque risalire al 2000 ed è probabilmente uno degli ultimi scritti, atto di testimonianza di un autore civile reso all’umanità nella forma di un racconto che eleva un giovane poeta ad alfiere di una coscienza collettiva, tanto che finisce con il suo grido in treno “No alla guerra” e la risposta antibellica di “quasi tutto il vagone”.
Trova così conferma in questo breve e prezioso testo quello che appare il credo di Bolaño, pronunciato nel 1999 a Caracas nel discorso per il premio conferito a I detective selvaggi: «Tutto ciò che ho scritto è una lettera d’amore e di addio alla mia generazione».
Leggi anche:
Massimo Rizzante | Bolaño, combattente e bon vivant
Federica Arnoldi, Alfredo Zucchi | Bolaño. La letteratura nazista in America
Federica Arnoldi | Bolaño, Lo spirito della fantascienza
Laura Erber | La misteriosa poetessa di Bolaño