Da Pynchon a PT Anderson: Una battaglia dopo l'altra
Diversamente che in Vizio di forma, il film trasposto nel 2014 dall’omonimo romanzo di Thomas Pynchon del 2009, in Una battaglia dopo l’altra Paul Thomas Anderson ha voluto sin dal titolo tradire apertamente lo scrittore newyorkese. E mentre lì la sceneggiatura si era mantenuta pressoché fedele al testo (con la riproposizione anche del parlato e l’affidamento del narrato a una voce fuori campo: una Sortilège secondaria in Pynchon e primaria in Anderson), qui si costituisce invece, per mano di Anderson, in antinomia: una contraddizione entro lo stesso sistema postmoderno al quale appartengono sia Pynchon che Anderson, il primo da maestro e il secondo come discepolo.
Pynchon ha comunque accettato il disinvolto adattamento del suo Vineland (uscito nel 1990), almeno stando alle parole di PTA – l’acronimo del regista voluto per distinguersi dagli altri Anderson – che molti anni fa disse, mettendo mano al copione, di “averne rubato le parti che gli piacevano di più con la benedizione di Pynchon, ovviamente”. Ma visto lo stravolgimento che ne ha fatto, del tutto legittimo quanto discutibile, viene in taglio quanto, proprio in Vineland, Pynchon dice di una causa di divorzio simile “a uno di quei film sparatutto che si vedono i ragazzini al drive-in”.
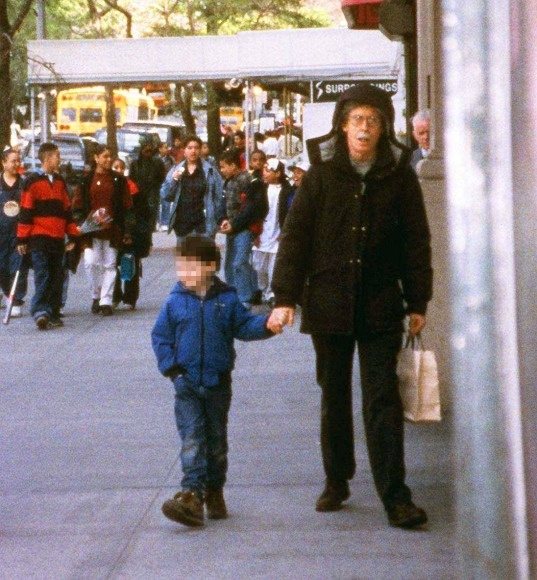
Messo così, Una battaglia dopo l’altra (titolo che sottende già l’etichetta di film d’azione) è tutt’altro che l’anabasi delle migliori generazioni Usa dalle frontiere delle illusioni e delle ideologie libertarie e rivoluzionarie, quale la critica lo ha consacrato in un coro unanime e sperticato di osanna, candidandolo pure a fare incetta di Oscar come “film del decennio”.
In realtà il film abbonda di scontri a fuoco, esplosioni, incendi, devastazioni, inseguimenti, armi spianate, autovetture ridotte a cartocci, morti ammazzati, scene insomma tipicamente “mozzafiato”, secondo il più classico, vieto ed esausto canone dell’“americanata”: a godimento appunto dei “ragazzini” ai quali certamente è dedicata la battuta del sensei Carlos (personaggio sudamericano per il solo fatto che Benicio del Toro è tale, quando il sensei, maestro, di Pynchon è Inoshiro Sensei, giapponese anzichenò): “La libertà è non avere paura, come il grande Tom Cruise”. Non proprio da farne un’epigrafe.
Certamente di paura non ne ha avuta Anderson girando la scena finale del rocambolesco inseguimento d’auto in una interstatale ai confini dell’Arizona fatta di profonde cunette e di alti dossi, ottima per tenere il fiato sospeso, ma pari dopotutto a una trovata nella quale la presenza del regista appare così ricercata e insistita da distrarre l’attenzione dalla concitata battaglia mortale on the road, l’ultima della serie, per spostarla sull’abilità degli operatori di ripresa e tale da rendersi alla fine conto di essere davvero al cinema. Né timore alcuno ha avuto il regista accostando temerariamente sequenze (rigorosamente camera in mano e long take) nelle quali si parla di selfie, wifi, facebook ad altre dove le telefonate sono possibili ancora con i telefoni a gettoni.
Come in gran parte dei film americani di genere, occorre sospendere la credulità e farsi appunto ragazzini di drive-in per entrare in frenetico alla vista di erezioni esibite e addirittura a comando, di una sedicenne che guida e spara come se non avesse mai fatto altro, o a sentire di un club “Pionieri del Natale”, di una congrega femminile chiamata “Sorelle del prode castoro”, di un circolo di suprematisti devoti a San Nicola, di un colonnello che di nome fa Lockjaw, “mascella serrata”, così da permettere a un troppo elettrizzato Sean Penn di fare il misirizzi articolando a ogni momento la faccia in una smorfia che dovrebbe dare un carattere.

Nella sostanza il film poggia sul piano instabile di un Lockjaw ingaggiato dalla misteriosa associazione di estemporanei fascisti e razzisti perché dia la caccia non a qualcuno in particolare ma indiscriminatamente a immigrati, spacciatori e farabutti all’ingrosso, missione alla quale il colonnello si vanta peraltro di essere già unicamente dedito. In cambio avrà un posto dentro l’organizzazione. Per realizzare il suo sogno, Lockjaw deve però eliminare una figlia meticcia avuta con la nera che lo ha violentato e che, per qualche motivo, è diventata una sua agente in segreto, salvo poi ucciderla. Altrimenti si scorda di diventare… pioniere del Natale.
Allora il padre anagrafico della ragazzina, Leonardo Di Caprio (troppo ostentato nel recitare in levare), per qualche altro motivo nel mirino del colonnello che evidentemente pensa di dovere eliminare per soprammercato anche lui, fa tre cose: si ricorda di essere stato un terrorista fino a sedici anni prima (cioè suppergiù agli inizi del nostro secolo già inoltrato, quando gli anni di piombo sono però tramontati da un bel pezzo), si dimentica di essere un tossico e un alcolizzato e, riscoprendosi nel pieno di tutte le energie di un uomo in salute, diventa un eroe lanciato alla ricerca della figlia da salvare. L’esito è uno stanco dejà vu di film come Taken con Liam Neeson, Commando con Arnold Schwarzenegger, Ransom con Mel Gibson, L’ultima svolta con Bruce Wills e di decine di altri girati sullo stesso tema del padre guerriero in cerca della figlia in mano ai cattivi.

Ma allora cosa ha inteso fare Anderson? Sospeso tra David Lynch e Ken Loach, ha cercato di fare incrociare lo sguardo visionario e lisergico del primo, rivolto alle dissociazioni personali, ai disadattamenti familiari e alle distorsioni egolatriche, con quello realista del secondo puntato sui guasti sociali, gli scontri istituzionali, i conflitti di classe, implementando l’accrocco di lacerti presi dal Thomas Pynchon più anguillare e meno amalgamabile perché anch’egli cercatore accanito del rapporto osmotico ma incendiario tra sfera interiore ed esteriore. Risultato, un ibrido che si propone nel genere del political action drama (dove Vizio di forma è stato una analogica detective story), ma che si attesta invero al grado di specifico action movie al quale è richiesto lo spettacolo e non la speculazione.
Guardando a Pynchon, undici anni dopo Vizio di forma, PTA ha voluto riprendere il tema del declino della cultura hippie e underground legata ai valori degli anni Sessanta e Settanta, dell’immaginazione al potere e della libertà attraverso l’alienazione delle droghe, concependo un rigurgito di istanze veterorivoluzionarie in un contesto che è quello attuale, casualmente finito per coincidere con il tempo di Trump, che molto richiama quello pynchoniano di Reagan.
Senonché ha prelevato da Pynchon sangue dal sistema arterioso e non da quello venoso, ignorando così la linfa vitale che irrora in profondità Vineland, da molti considerato oggi romanzo superiore a L’arcobaleno della gravità, visto tradizionalmente come il suo capolavoro. Se è così, le dinamiche che muovono il film integrano una semplificazione e una riduzione al banale delle complesse linee di senso che intramano il ben più ricco e articolato romanzo, fatto di ghirigori e volute estenuanti da seguire ma seducenti come suggestivi sentieri da scoprire. Pynchon è uno scrittore ogni romanzo del quale si ha cento volte voglia di abbandonare ma, se letto fino al termine, si ha cento volte voglia di rileggere. Affronta sì in Vineland (immaginaria città a ridosso della contea di Humboldt, nel North California, dove PTA è andato a girare) la caduta degli ideali che infiammarono gli anni della contestazione, segnando la decadenza del sogno americano nella specie del cambiamento vagheggiato dalle minoranze, ma non arma la mano di alcun sovversivo e, a differenza di Anderson, indica – o meglio addita – le cause del regresso, che è sociale e non politico, puntando il dito sugli effetti meno evidenti e ancora più privati del “reflusso reaganiano”.
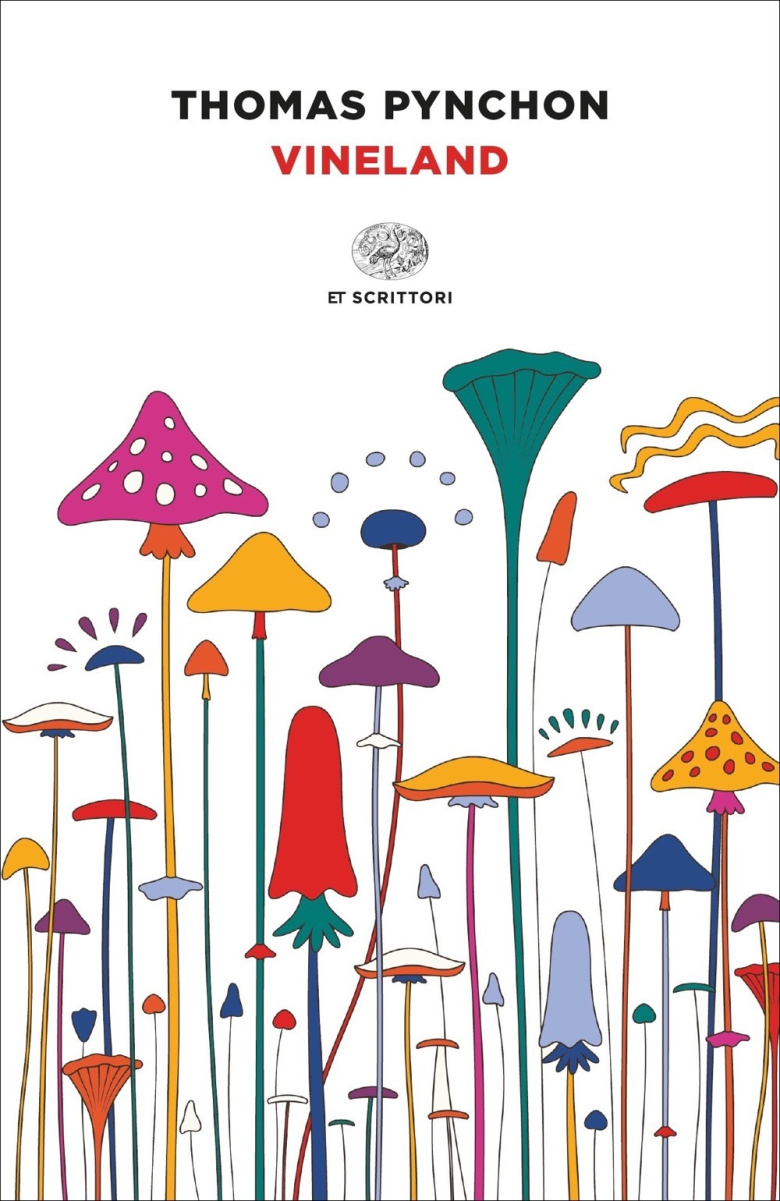
Gli eroi di Pynchon sono ex musicisti e non ex terroristi come per PTA, hippies fattoni che vivono il presente paranoico e irrelato riconducendosi al loro passato d’oro pavesato di eroina ma soprattutto di sogni. Un personaggio, Hector Zuñiga, grande assente nel film, detective Fbi della Narco, si rivolge a Zoyd per parlare a tutti gli hippies rinfacciando una verità che richiama il verbo degli Usa del 1984, l’anno di ambientazione, lo stesso della seconda elezione di Reagan e del consolidamento del Grande Fratello orwelliano: “Tutti voi siete dei bambini dentro, vivete le vostre vite nel passato, negli anni Sessanta. Aspettate ancora quella magica resa dei conti”.
È così. Frenesi Gates, l’improbabile ed evanescente Perfidia Beverly Hills del film, dice a Darryl Louise, forse la Deandra di PTA: “Come abbiamo fatto a perdere contatto con la realtà fino a questo punto?”. Il punto di non ritorno è segnato dal sopravvento della Tele (“Tube” in Pynchon: la valvola catodica) che soffoca tutti gli ideali, sotterra un’intera civiltà ed estranea dalla realtà. Per Pynchon la nuova droga che oscura le menti, appiattisce la ragione, riduce allo stesso stato di ogni vecchio stupefacente e uccide, è la televisione.
Dice tutto Isaiah Due Quattro (figura assente in PTA come decine di altre) a Zoyd Wheeler, il Bob o Pat del film: “Il vero problema con quelli della tua generazione è che voi credevate davvero nella vostra Rivoluzione, vi siete giocati la vita… ma certo non avevate capito molto della Tele. Quando la Tele vi ha presi è tutto finito in un attimo, tutta quell’America alternativa, proprio come gli indiani, l’avete venduta ai vostri veri nemici”.
Con efficace immagine, Pynchon parla degli Stati Uniti chiedendosi se “si trovassero in un crepuscolo prefascista o se le tenebre fossero già calate a sorpresa diversi anni prima, e la luce che credevano di vedere provenisse soltanto da milioni di Tele che trasmettevano tutte le stesse ombre tinte di colori brillanti”. Nel romanzo i Thanatoidi, sconosciuti a PTA, formano proprio la generazione votata volontariamente alla morte perché dedita a stare sempre di fronte alla Tele a vedere sit-com. Il piccolo Justin, figlio di Frenesi, dice alla mamma che non deve avere paura di Brock Vond (il procuratore federale, inquietante e carismatico nel quale si riconosce il clownesco Lockjaw) perché hanno visto la televisione insieme, cioè si sono affratellati, come avrebbero fatto un tempo due tossici con la stessa canna.
Brock Vond opera nel ruolo di repressore, per conto del potere costituito, della controcultura hippie e progetta di realizzare un film documentario che serva a educare le coscienze sui pericoli della droga e le minacce di rivolta popolare. Perdutamente innamorato di Frenesi, la conquista e ne fa una sua informatrice. Frenesi non è l’esaltata Perfidia Beverly Hills di Anderson, ninfomane e terrorista, ma una mite filmmaker che insieme con il collettivo “24fps” (24 fotogrammi al secondo) gira scene e momenti della vita hippie per documentarli. Nel romanzo non muore affatto, anzi alla fine ritorna e abbraccia la sua Prairie, la Willa di PTA, che nessuno insegue o vuole eliminare.

E quello che costituisce il finale del film – il tentativo di Lockjaw di uccidere Willa-Prairie – rimane invece vago nel libro. Brock Vond ha il tempo di dire, in circostanze pynchoniane, cioè calato da un elicottero in volo sulla testa di Prairie addormentata nel bosco, di essere suo padre, ma in quel momento viene risucchiato in cielo perché Reagan ha appena sospeso il programma di rieducazione popolare di cui il procuratore è a capo, per modo che della paternità non si saprà più niente. Tipico di Pynchon che ama ogni tipo di sospensione.
Ciò di cui il film manca – per deliberata scelta, s’intende – sono proprio le circostanze pynchoniane, sicché può parlarsi di opera liberamente tratta da Vineland e altrettanto liberamente sviluppata. Il fantomatico e improbabile club dei “Pionieri del Natale” è nel romanzo un clan mafioso di origine italiana, il cui rampollo, Ralph Wajvone junior, vuole fare il comico e ama raccontare barzellette sugli italiani, tema d’elezione questo in Pynchon, che arriva a mettere Cesare Lombroso al servizio di Brock Vond perché dalla conformazione dei crani capisca chi sono i soggetti pericolosi e perciò da rieducare come “misoneisti”, odiatori del nuovo, quali sono gli hippies passatisti. Ralph junior incarna la nuova mafia californiana, disincantata e distaccata, ed è diverso dal padre, Ralph Wajvone senior, portatore di interessi che collimano con i disegni di Brock Vond, attraverso il quale il boss collude con il potere governativo.
Senonché un precetto pynchoniano, quasi una legge, avrebbe dovuto offrire ad Anderson il destro cinematografico per coniugare potere, minoranze e lotte di riscatto: “Quando il potere corrompe, tiene un diario dei suoi progressi, scritto nel più sensibile dispositivo di archiviazione: il volto umano”.
Anderson, che avrebbe avuto materiale abbondante per lavorare su questa materia così intrigante, ha pensato piuttosto a un film realista nella forma risultato però vuoto nel contenuto diegetico, privo com’è di quelle fughe nel surreale, delle derive nell’enigmatico e delle incursioni nel simbolico (adottate invece in Vizio di forma, dove si rincorrono corrente karmica, Fratellanza ariana, Pantere nere, oscure associazioni come “Golden Fang”, personaggi d’immaginazione) che costituiscono la sua cifra ma prima ancora quella di Pynchon. E ha dunque tralasciato tutte le trame metaforiche, le refluenze oniriche, gli effetti paranormali che fanno di Vineland un romanzo irripetibile anche per il suo autore.

Nel film non c’è traccia non solo dei Thanatoidi, gli eredi degli hippies, ma nemmeno del “Ritiro delle ninjette” dove Sorella Rochelle, usando la macchina Puncutron, riporta in vita Takeshi Fumimota, il giapponese che Darryl Louise (introdotta ai segreti delle più sofisticate arti marziali da Inoshiro Sensei) ha destinato alla morte entro un anno applicando la “palma vibrante”, cioè toccandolo facendo sesso. Non c’è l’orrorifico mostro che a Tokio distrugge il laboratorio di Takeshi. Non c’è la Kasumi, la Nebbia, che a Darryl Louise permette di rendersi invisibile e liberare Frenesi dalla “Riserva dei servizi di sicurezza nazionali”. Non ci sono nemmeno i dialoghi e gli incontri tra vivi e morti, come quando Prairie parla con Ween Atman, l’ideologo, fatto uccidere dalla madre Frenesi. E manca del tutto lo straniamento, non solo di tempi, luoghi e personaggi, ma anche di atmosfere, stati d’animo e credenze, che formano la sostanza prima del costrutto labirintico, cerebrale e molte volte cervellotico di Pynchon.
Una battaglia dopo l’altra reifica il romanzo e ne fa un fumettone, ma va valutato a prescindere da Pynchon. Si ha allora un buon film di intrattenimento, tuttavia gravato di significati epistemologici che appaiono più suggeriti che pronunciati. Da cercare con molta buona disposizione, come ha fatto tutta la critica. Richiamare Vineland, da Anderson innanzitutto, anche solo come fonte ispiratrice, vale un confronto dal quale il film esce decisamente a pezzi.







