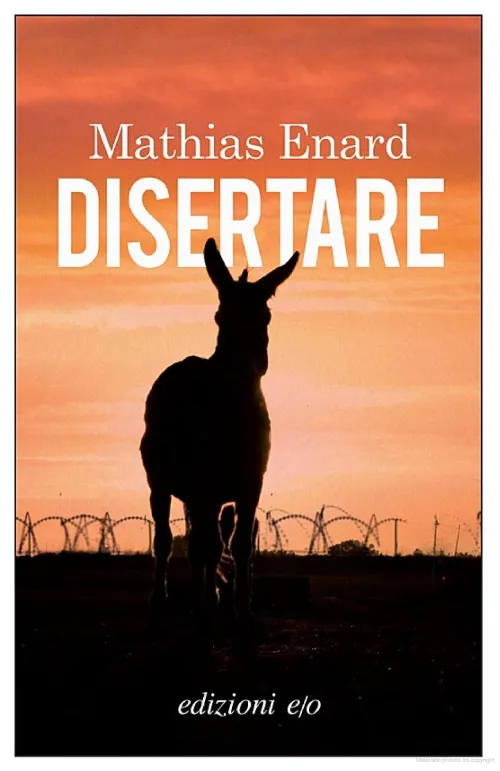Mathias Énard, guerra alle guerre
L’ultimo romanzo di Mathias Enard porta un titolo, Disertare (Edizioni e/o, 2025, traduzione di Yasmina Melaouah), che interpreta solo una delle sue due parti, quella del soldato senza nome e di tutte le guerre che scappa dai campi di battaglia, mentre sottace l’altra sulla biografia immaginaria di un matematico fedele alla Germania Est e agli ideali comunisti pur nella disillusione del loro crollo. Con le stesse ragioni avrebbe potuto dunque intitolarsi “Militare”, osservando così un diverso imperativo, perché il senso di un’esortazione a disertare sembra proprio suggerire il titolo: quasi che lo scrittore francese volesse fare del ripudio della guerra la bandiera di un’umanità la cui storia, come ha detto in un’intervista, è fatta più di periodi bellici, mentre la letteratura «nasce nello spazio tra pace e guerra».
Allo stesso modo, uno sprone alla professione di fede ideologica appare la vicenda di Paul Heudeber, sognatore da un lato ed escapista da un altro, fervente comunista, tanto da volere l’unità della Jugoslavia e dell’Urss in dissoluzione, e tenace teorico matematico capace di andare incontro al mondo in fiamme con lo spirito dell’omerico pastore di Ilio che, davanti alla presa di Troia, pensa alle sue pecore, come lui fa concentrandosi sulle sue sole congetture.
In più occasioni Enard, poliglotta, traduttore, cosmopolita, arabista, germanista, ha detto che la guerra russo-ucraina lo ha spinto ad aggiungere al romanzo già pronto – sul matematico che all’amore preferisce la fede politica – la storia a sé di un disertore in fuga, che però non incrocia mai la prima e si sviluppa in maniera autonoma equivalendosi all’altra, anzi sovrapponendosi. Due romanzi in uno per una scelta che lascia perplessi anche quanto allo stile linguistico, analogico-realista nella parte biografico-rimemoriale e lirico-espressionista in quella docu-testimoniale.
All’invasione russa dell’Ucraina, nel 2022, l’autore sente dunque irresistibile l’urgenza di denunciare il presente e si serve di una vicenda finzionale ambientata nel passato, quella del matematico, per creare un piano inclinato sul quale la storia dell’incendiario Novecento si riversi di peso nell’attualità del brutale Duemila, a dimostrazione del teorema, fatto proprio, che il progresso umano è avanzato di pari passo con l’ulteriore abbrutimento della natura dell’uomo.
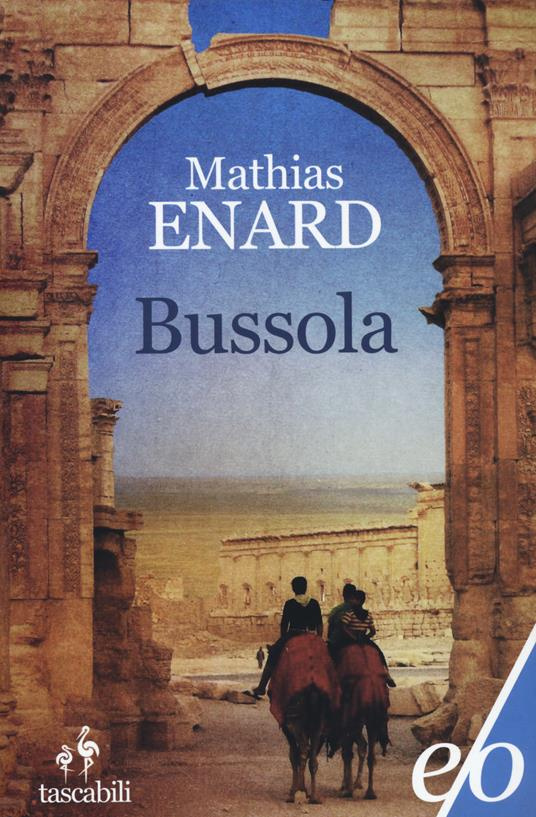
Meglio avrebbe fatto Enard, autore tanto cerebrale quanto di culto, almeno in Francia, a tenere separate le due vicende storiche, giacché non riesce mai a conciliarle, senonché il proposito di dimostrare il suo teorema lo ha spinto ad accostare due figure molto diverse perché, anche se non si guardano, si tendano la mano nella determinazione di andare contro il loro tempo: il disertore rendendosi nemico alla sua patria per guadagnare la condizione di uomo libero restituito alla bellezza del paesaggio nativo devastato (e qui cade in taglio Anselm Kiefer e la considerazione che “il paesaggio porta sempre reminiscenze di catastrofi, di guerra”), il matematico non volendosi arrendere alla fine della Ddr e del sogno comunista e scegliendo di togliersi la vita piuttosto che sopravvivere alla fine dei propri ideali.
A stare al titolo del romanzo, sembrerebbe che prevalga il disertore, apparendo peraltro per primo, e che la sua storia sia perciò di primo piano. E sarebbe allora da chiedersi perché premi lui, dal momento che la vicenda di Paul Heudeber, il matematico, non solo è più lunga ma anche meno incompleta. Vediamo meglio come.
Nel caso di Heudeber, ci si aspetta che la figlia, l’io narrante, ne scopra le cause della morte per annegamento, se suicidio, disgrazia o delitto, ma il finale è lasciato aperto, in un’indeterminatezza che riguarda anche la figura della madre, Maja, la compagna amatissima ma mai vissuta con Paul, se davvero lo ha tradito consegnandolo alla Gestapo e se è stata una spia. La ricostruzione che del loro rapporto e dei rispettivi ruoli fa Irina Heudeber attraverso le lettere e le testimonianze dei colleghi del padre (incontrati in un convegno che si tiene il 10 settembre 2001 e si interrompe l’indomani nel trauma dell’attacco alle Due Torri), termina quando settantunenne nel 2022 si inoltra a piedi lungo la salita che porta al Museo di Buchenwald, un tempo il lager dove il padre è stato rinchiuso e ha scritto il suo libro sull’infinità dei numeri primi gemelli, Congetture di Ettersberg, elegie matematiche.
Irina vuole vedere i luoghi dei quali il padre non le ha mai parlato se non una volta, dopo un film alla televisione sul lager, vedendo insieme il quale le aveva detto: “Sai Irina, eravamo tutti molto più sporchi, molto più brutti. Eravamo delle cose feroci e puzzolenti e ci torturavano giorno e notte, non è qualcosa che puoi mostrare in un film”.
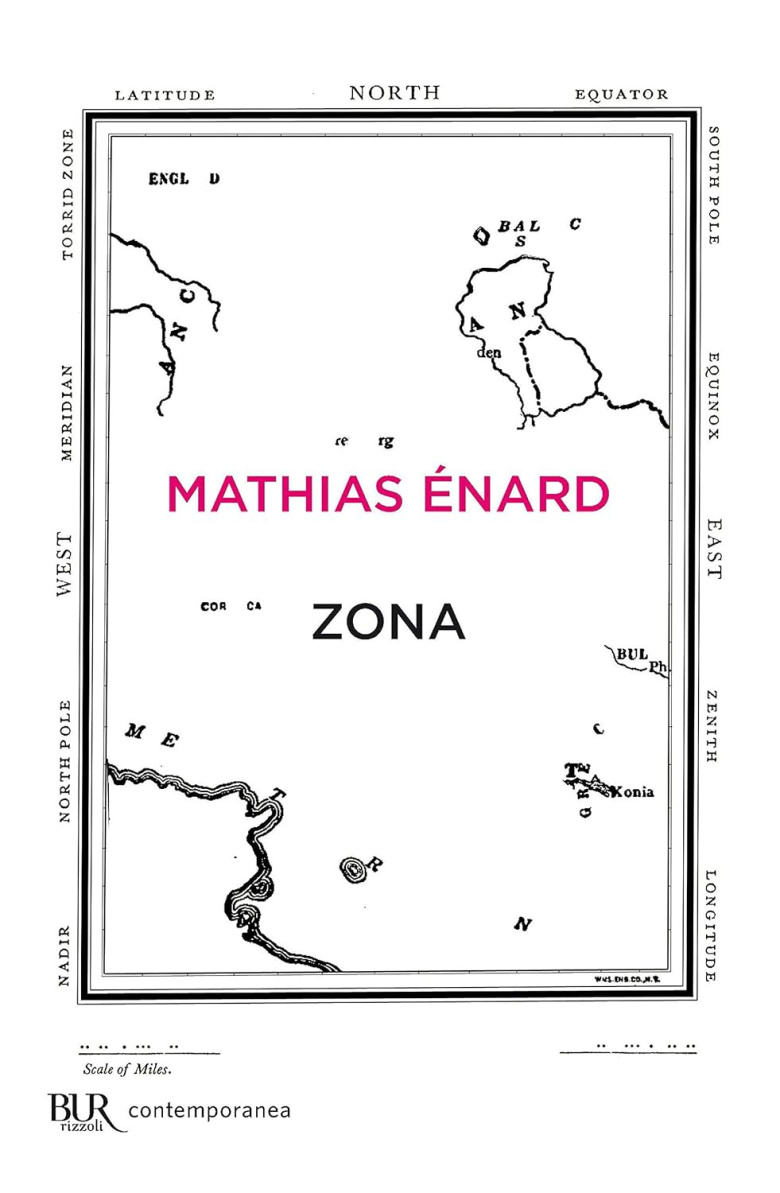
Vuole dunque recuperare la memoria del padre e degli eventi che hanno segnato il Secondo Novecento. Il disertore senza nome vuole invece dimenticare i fatti feroci e atroci che ha vissuto e dei quali si è reso protagonista uccidendo e torturando in nome di un credo politico di parte. Per fare questo rinverdisce la memoria andando in montagna dove in una baita ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza con il padre e il nonno. Stando a categorie echiane e di psicologia cognitiva, la memoria che vuole preservare Irina è semantica, riguardando la storia collettiva, mentre quella che vuole recuperare il disertore è biografica interessando la sua sola sfera personale.
Anche la vicenda dell’eponimo romanzo ha un finale aperto, dal seguito però molto meno immaginabile: il disertore salva la donna sconosciuta, anche lei fuggitiva con il suo asino, dalla violenza di altri tre soldati sbandati e si addormenta bevendo la loro acquavite per crollare – fine della storia – “in un sonno pesante, popolato di cadaveri e avvoltoi”. Vivrà con la donna e l’asino nella baita? Raggiungerà la vicina frontiera e si rifarà una vita, magari con lei? Enard ne lascia impregiudicato il futuro, non importandogli cosa l’uomo farà lontano dalla guerra, giacché è il presente che fissa nel suo gesto di ribellione e forse di coraggio: il giovane soldato vuole tagliarsi i ponti alle spalle, tanto da essere più volte sul punto di abbandonare il fucile d’ordinanza e liberarsi nella baita dei brandelli dell’uniforme, i soli elementi che lo legano al suo ripudiato passato.
Il linguaggio, gravido di echi cioraniani, è tanto più poetico nella parte del disertore quanto è prosastico in quella del matematico – benché in entrambe eccedano gli stilemi sperimentali e di tipo oulipistico, fin troppo cari all’autore, intesi a costruire immagini evocative di dubbio effetto quali “un battito regolare di solitudine”, “sento sulla pelle il fuoco dell’aurora”, “posare la smorfia della morte sul volto dell’icona”.
E se nel caso del disertore il tono assume volutamente ritmi da tragedia greca con sticomitie frenetiche e febbrili passaggi di voce, da quella interiore del disertore a quella in terza persona del narratore all’altra di un virtuale coro che si rivolge al protagonista con l’uso di stasimi molto ispirati e una versificazione di tipo alessandrino e martelliano, in quello del matematico il ritmo ubbidisce alle regole della ricostruzione “per tabulas”. Sicché, nel tentativo di distinguere le due narrazioni, volendole evidentemente tenere distinte, seppure parallele, Enard ha scelto di sofisticare la parte del disertore e di semplificare l’altra del matematico, ottenendo però uno scarto uguale al salto da un libro all’altro.
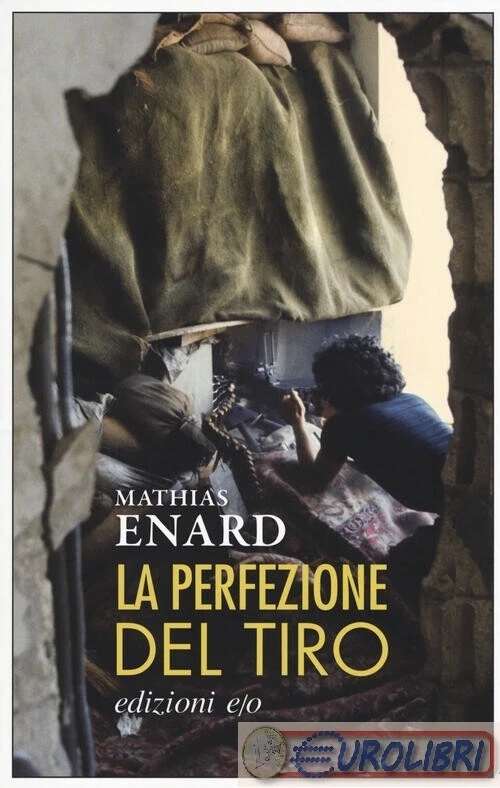
Quanto al contenuto, mantenendo fede al suo statuto narrativo, Enard innesta anche stavolta personaggi e vicende di fantasia in contesti doviziosamente documentati, facendo sapiente uso della verosimiglianza, arricchita da una proprietà esatta di linguaggio, quasi scientifica quanto ai nomi di piante, organi animali, attività umane e elementi naturali, tale da assicurare un forte effetto di realtà. Forse è questo il suo talento maggiore, da cui rileva un amore spiccato per la ricerca, non solo storica e geografica ma anche di materia, com’è in Disertare il tema della musica: un campo questo che lo seduce molto, se Franz Ritter, io narrante di Bussola (libro vincitore dei premi Goncourt e Von Rezzori), è un musicologo, ma non quanto lo ossessiona la guerra, basso continuo della sua intera opera, da La perfezione del tiro del 2003 al satirico Breviario per aspiranti terroristi del 2007 allo sperimentalissimo Zona di tre anni dopo (una proposizione sintattica che dura per tutto il libro) fino a Bussola e a Disertare, che costituisce una prova di variazione nonché di sintesi tra musica (definita in Bussola “un bel rifugio dall’imperfezione del mondo e dal declino del corpo”) e guerra, vista come condizione permanente dell’umanità e in La perfezione del tiro posta nei termini in cui il cecchino (che spara dai tetti di una innominata città, forse Beirut, teatro di una guerra civile, simbolo ancora di tutti i conflitti intestini) si rivolge a Myrta dicendole che durante una guerra è inimmaginabile la pace, così come durante la pace lo è la guerra. Al pari del disertore, è anch’egli un combattente, pur non pentito, ed è altrettanto spietato e allo stesso tempo dotato di umana sensibilità: il disertore risparmia una ragazza della quale finisce per invaghirsi e il cecchino si innamora di una adolescente che ospita in casa.
Ed è entro l’arco dei vent’anni compresi tra queste due figure omologhe e antipodiche che si situano gli altri personaggi sempre maschili enardiani, tutti intenti a stabilire con figure femminili impalpabili, più desiderate che conquistate – o, come per Paul e Maya di Disertare, lontane e presenti solo spiritualmente –, rapporti catulliani ondivaghi tra odio e amore, quando non, come in Bussola tra Franz e Sarah, di innamoramento inconfessato e non corrisposto.
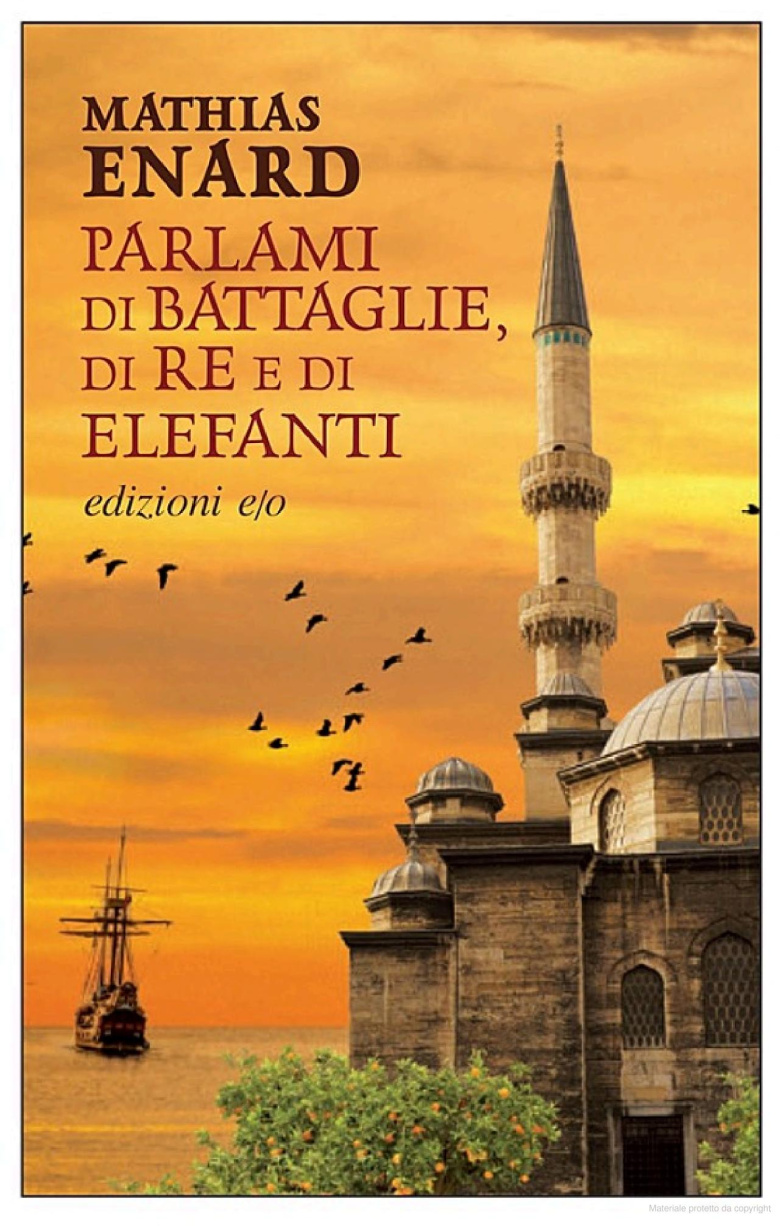
Nella prospettiva di un complesso di romanzi che rispondono anzichenò a un’unica chiave di lettura e sembrano formarne uno solo, multiforme e polifonico, anche i due titoli eterogenei ed “extra ordinem”, Il banchetto annuale della confraternita dei becchini e Parlami di battaglie, di re e di elefanti, dove l’evocazione della guerra stinge e il registro drammatico si stempera in uno da commedia, parlano di coppie irrisolte, inscenando lì un giovane antropologo che vive un indistinto legame con la misteriosa Lucie e qui un trentenne Michelangelo Buonarroti che a Costantinopoli (dove in realtà l’artista non è mai stato per progettare un ponte sul Corno d’oro, ma è vero che propose al sultano un suo disegno: elemento sufficiente all’autore per offrire una superba prova di verosimiglianza) si fa stregare da una ancora più misteriosa danzatrice. Non diverso è in L’alcol e la nostalgia del 2011 l’ambiguo rapporto tra Mathias e Janna, rivissuto dal primo sul filo della memoria durante un viaggio in treno verso Mosca.
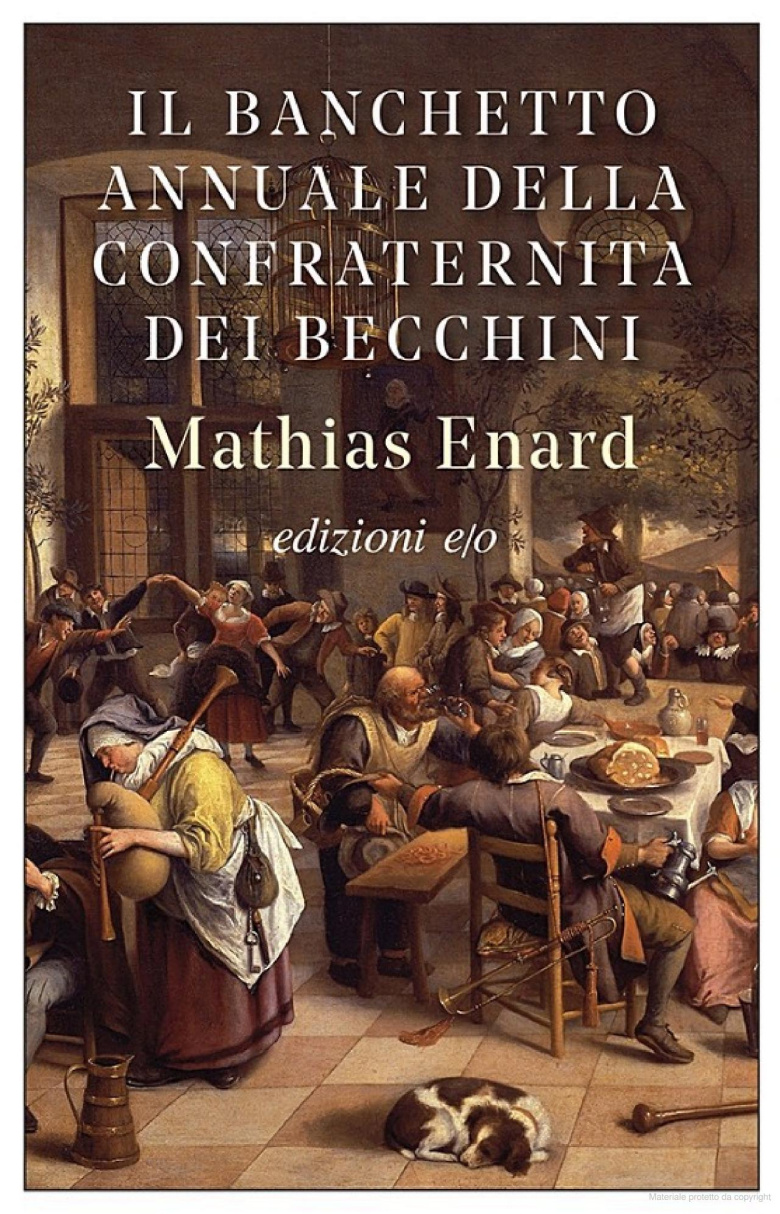
Ecco, la memoria, il principio attivo di Enard. Agìta sempre a nome dell’autore implicito che narra in prima persona, tranne che in Il banchetto annuale della confraternita dei becchini (romanzo ambientato nei dintorni di Niort, città natale dell’autore, dove un dottorando dimora per una tesi sulla vita rurale: pretesto per sollevare, al di là della cifra leggera, la grave questione socio-economica della provincia francese), la memoria funge da leva per recuperare i ricordi personali durante uno stato temporaneo di sospensione (un viaggio in treno in L’alcol e la nostalgia e in Zona, una notte insonne in Bussola) o un processo mentale di autoanalisi e di scavo interiore come in Via dei ladri e La perfezione del tiro.
Valendo la prima persona come mezzo di recupero della memoria, nel segno del più decadente Primonovecentismo (e Proust è autore di riferimento se intitola il verseggiante Ultimo discorso alla società proustiana di Barcellona del 2016), lo “stream of consciousness” diventa il modello primario di narrazione: che, essendo condizionato dalla capacità mnemonica, elude il vero certo, il dato reale e oggettivo per affidarsi alla sola percezione intimistica e personale, con tutte le incertezze della coscienza soggettiva.
Di qui forse il tono moralizzante e a volte declamatorio, certamente retorico, cui Enard troppo spesso indulge nella ricerca di un grado di liricità che, sostituendo il narratore all’autore implicito, guasta il racconto e finisce quasi sempre per pesare sull’andamento discorsivo, stridendo peraltro sulla plausibilità del flusso di coscienza e facendo da linfa mortale.

Disertare (per metà in prima persona e per l’altra in terza) non sfugge a questa ipoteca e sembra una summa del pensiero e della visione enardiani, appartenendo a un uniforme retaggio nel quale convergono temi esistenziali quali il dolore (la parola più frequente in tutta l’opera), l’estraneità al proprio tempo, lo sradicamento dai suoi mali, il senso del rimpianto e della nostalgia, il sentimento dell’inappartenenza, il peso della solitudine. La smania di Enard, interprete inquieto e indomito della nostra epoca, segnata da guerre, ingiustizie sociali (Il banchetto annuale della confraternita dei becchini) e divisioni razziali (Via dei ladri), è intesa a trasfigurare la realtà in una dimensione letteraria e volgere la storia nella letteratura: in Disertare il libro di Paul Heudeber su specialistici teoremi matematici vale più per le sue qualità letterarie che tecniche, tale da essere definito “un mistero matematico e letterario assoluto, qualcosa che aveva a che fare insieme con la poesia e la musica segreta della matematica”, e in Parlami di battaglie, di re e di elefanti “i trattati scientifici gli interessano [a Michelangelo] soprattutto per le storie che racchiudono”.
Può allora dirsi riuscito l’esperimento di Enard, reiterato da oltre vent’anni a ogni libro, di sublimare la realtà e dunque distillare la prosa in poesia e mutare la bruttezza in bellezza come in un tentativo accorato di salvare il mondo? Disertare è la prova ultima e più ambiziosa, forse spericolata, di questa operazione e indica quale sarà la strada che lo aspetta. Appare certamente chiaro che Enard ha ancora molte cose da dirci, o meglio da raccontarci, nell’augurio che narri da “conteur” e non predichi da quaresimalista.
Leggi anche:
Paolo Landi | Mathias Enard e la confraternita dei becchini
Federico Iarlori | Mathias Énard, ricostruire il Mediterraneo