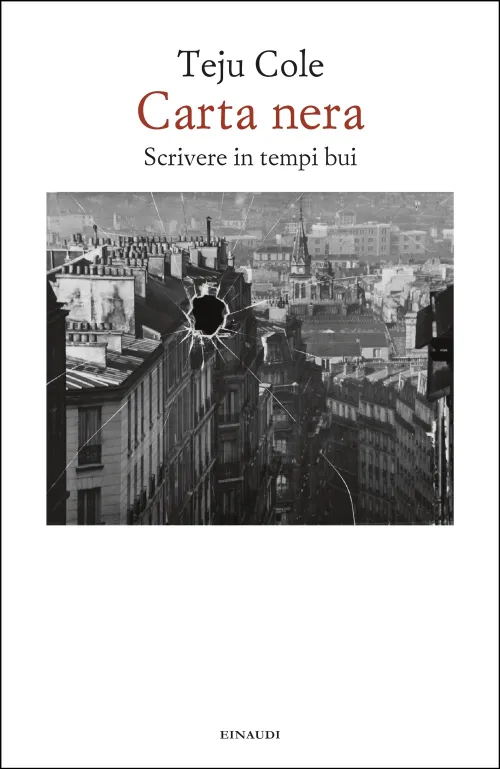Speciale
Teju Cole. Pelle nera, carta nera
Il continente nero, la pelle nera, l’uomo nero… tutto ciò che viene associato all’Africa è segnato dal colore della pelle. Dal colore visto da chi si presume bianco (e bianco non è), o meglio si presume incolore, trasparente, visto che definisce i neri “gente di colore”. Il colore nero diventa poi un fattore che rende negativo qualunque termine gli si associ: mercato nero, lavoro nero, giornata nera… I pigmenti della pelle, ultimo confine tra noi e il mondo, prodotto dell’evoluzione e dall’adattamento al clima, assurgono ancora oggi troppo spesso a marcatori di giudizio o meglio di pregiudizio. Come se il colore determinasse la cultura, il comportamento, i gusti, le scelte di un individuo.
Partendo dal colore nero Teju Cole, scrittore, critico d’arte e fotografo nigeriano, ci accompagna attraverso una serie di frammenti, che apparentemente sembrano casuali, ma che andando avanti nella lettura, assumono via via l’aspetto di tessere di un mosaico, messi insieme in modo coerente. Carta Nera. Scrivere in tempi bui (trad. it. di Gioia Guerzoni, Einaudi, 2025) è un viaggio nella “nerità” (blackness) come la chiama l’autore, che parte dall’analisi dei fondali scurissimi di Caravaggio, per portarci poi in Africa, lungo piste spesso segnate dal dolore, dall’esclusione, dalla tragedia. Tragedia che viene spesso condivisa con altri oppressi, come i migranti che cercano di entrare negli Stati Uniti o le vittime del nazismo.
Cole è un critico d’arte, oltre che fotografo, e scrive quasi per immagini, a volte con pensieri di due-tre righe. Ed è dalle immagini, siano esse quadri rinascimentali o moderne installazioni visuali, che parte per raccontarci l’importanza del nero e allo stesso tempo legare quelle visioni alla realtà contemporanea, viaggiando liberamente attraverso luoghi, argomenti e stili – critica d'arte, aforismi, omaggi e reportage – ognuno dei quali, in diversa misura, porta con sé una vena politica, in linea con il sottotitolo del libro: Scrivere in tempi bui.
Il libro si apre con l’autore che, seguendo le orme di Caravaggio, arriva in Sicilia e la vita del pittore, «l’artista incontrollabile per eccellenza», errabondo, sempre in fuga, come in una dissolvenza ci porta ad altre vite in fuga, quelle dei migranti sopravvissuti al pericoloso viaggio in barca dall'Africa e oltre. «Tutte le tappe dell'esilio di Caravaggio erano diventate punti nevralgici della crisi dell'immigrazione», spiega Cole, prima di visitare le città portuali in cui l'artista cercò rifugio, ma trovò anche una sorta di sicurezza tra i transitori e gli esiliati.

Mentre vaga nel porto di Augusta, si imbatte in otto imbarcazioni appena ripescate dal mare, tutte piene di enormi quantità di giubbotti di salvataggio sporchi, di bottiglie di plastica, scarpe, camicie e tutta la sporcizia di molti giorni di coabitazione in uno spazio ristretto. Muovendosi tra di esse, viene momentaneamente sopraffatto dall'odore persistente del loro carico umano: «Mi nascosi la testa tra le mani, come se il dolore mi avesse teso un agguato».
Nel saggio intitolato Etica, Cole si interroga sul linguaggio giornalistico che caratterizza la comunicazione relativa all’immigrazione. Parole come “flusso”, “afflusso”, “onda”, “sbarchi”, che rendono «i nostri simili un motivo di allarme, non per loro conto, ma per noi». Il modo in cui pensiamo ai migranti, ci ricorda Cole, è plasmato soprattutto dal linguaggio spesso disumanizzante che viene usato per descriverli da politici e giornalisti.
Con una maestria davvero invidiabile Cole intreccia una profonda conoscenza della pittura europea con immagini del mondo africano, facendo collegamenti diagonali, imprevedibili, a volta con frasi spezzettate, ma che alla fine restituiscono quel valore che al nero è sempre stato negato. La lettura delle sue pagine ripropone una annosa questione, oggetto di dibattito da anni e mai risolta. Esiste una letteratura africana? Come ne esiste una americana, asiatica, europea? Cole è nato e cresciuto in Nigeria, ma vive negli Stati Uniti, di cui è cittadino: quando scrive di Caravaggio o di Duccio da Buoninsegna è uno scrittore africano? Oppure lo è solo quando parla di maschere yoruba o della Porta del non ritorno che sorge a Ouidah, nel Benin? Quando parla di Aretha Franklin fa letteratura africana o solo se parla del cantante maliano Mady Diabaté?
Forse bisognerebbe invocare quell’opacità che lo scrittore martinicano Edouard Glissant invocava come degna di essere messa tra i diritti dell’uomo.
Leggi anche:
Marco Aime | L’Africa non è un paese
Marco Aime | L’Africa a Venezia
Marco Aime | Africa rossa
Marco Aime | Restituzione: di chi sono le opere d’arte?
Marco Aime | L’etnocentrismo ministeriale. E l'Africa?
Marco Aime | Alì “Farka” Touré: la mia musica viene dall'acqua
Marco Aime | Ousmane Sembène, padre del cinema africano
Marco Aime | African Parks: business bianco
Marco Aime | Africa: la storia dalla parte del leone
Marco Aime | Africa: il progresso del sottosviluppo
Marco Aime | Ngũgĩ wa Thiong’o: biblioteche che muoiono
Marco Aime | Donna, africana, meticcia