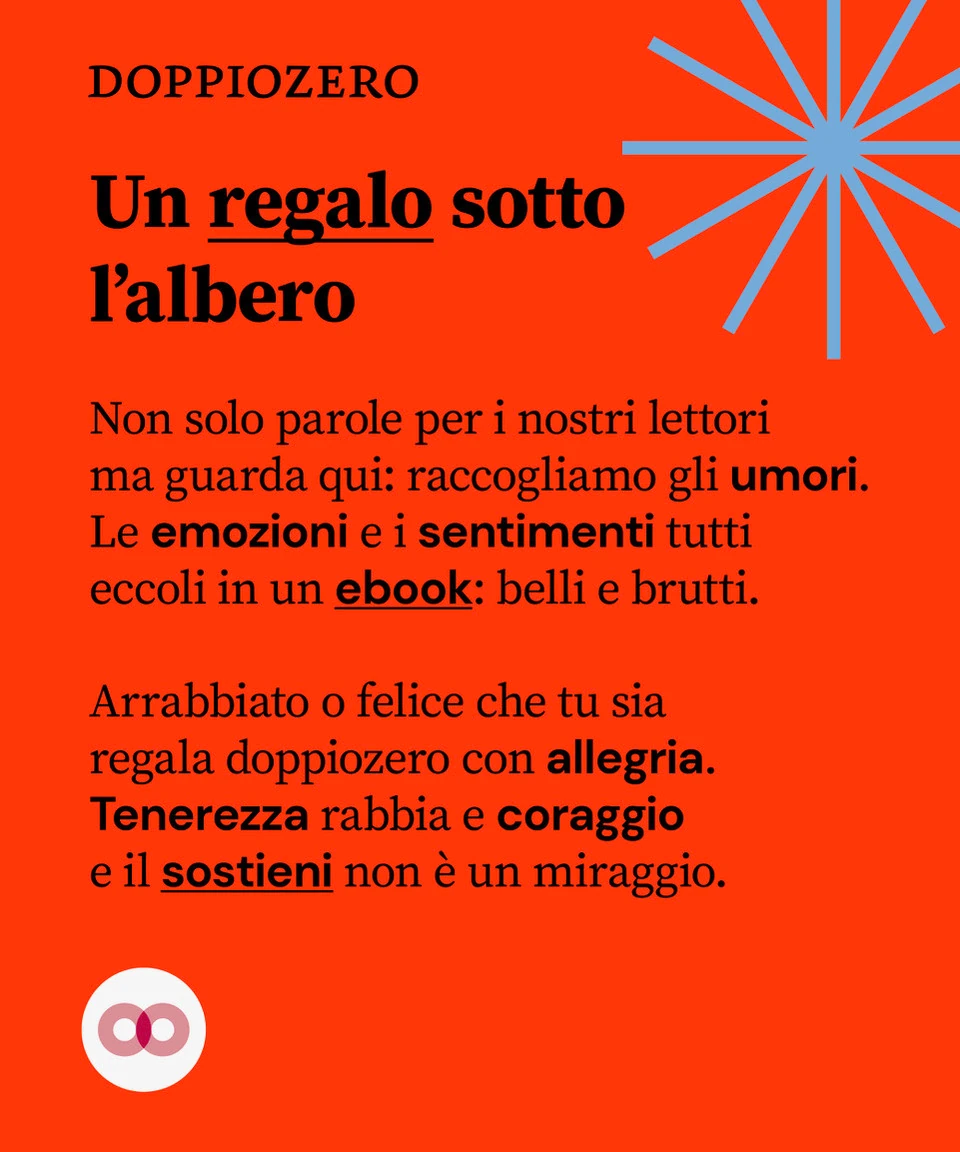Conversazione con John Giorno
Scandisce con voce dagli echi profondi l’anziano poeta che è stato amico e amante di Andy Warhol e di William Burroughs, e sembra un mantra: “deluded inside delusion inside delusion, inside delusion, / everything is delusion / including wisdom”, tutto è illusione, perfino la saggezza.
 John Giorno in Someone In Hell. Ph. di Ilaria Costanzo
John Giorno in Someone In Hell. Ph. di Ilaria Costanzo
A settantasette anni John Giorno conserva un fisico roccioso, una voce senza tentennamenti, un volto che sembra scolpito nella pietra di una pieve di campagna. A Prato, al Festival Contemporanea, è ospite dei Kinkaleri, una compagnia che ha portato la danza oltre tutti i limiti. Someone In Hell Loves You inizia con una vitale coreografia che poi scopriamo essere un alfabeto realizzato con movimenti del corpo; continua con un’intervista a John Giorno, intorno a uno scheletro, con una spiegazione del codice gestuale; si conclude con il poeta, uno dei primi a sperimentare il reading, che dà corpo, fiato, voce alle proprie parole scritte.
John Giorno. Ph. di Castorp
La danza diventa alfabeto e si smarrisce, di nuovo, nei ghirigori ipnotici del movimento; la parola si trasforma in altra presenza materica, densa, in inquietudine, in esperienza. Questo di Kinkaleri è il più recente atto di un progetto, All!, che ha esplorato musiche, architetture, poesie, con un particolare interesse per la cultura underground americana. E ora che ne abbiamo davanti questo esponente illustre e sudato (siamo alla fine della prova, prima dello spettacolo serale), anche noi proviamo a ricostruire frammenti di quella storia.
Come è diventato poeta John Giorno?
“A scuola. Ho iniziato a scrivere a quattordici anni. Uno dei compiti era: scrivi una poesia a casa. Fu uno shock. Da allora non ho più smesso. Era circa il 1950”.
Hai fatto altri lavori, prima di decidere di dedicarti totalmente alla poesia?
“Poca roba. Ho deciso di fare il poeta e l’ho fatto”.
Un momento fondamentale della tua biografia è l’incontro con Andy Warhol.
“Lo conobbi una prima volta in una mostra collettiva, nel 1963. Tre giorni dopo tornai a trovarlo alla sua prima personale, quella con le lattine Campbell, e da allora siamo diventati amici e lo siamo rimasti per anni”.
Dopo sei stato l’interprete del primo film di Warhol, Sleep.
“In quel periodo bevevo molto e dormivo anche molto. Ogni volta che Andy mi chiamava e mi chiedeva: cosa stai facendo? io rispondevo: sto dormendo. Nel 63 eravamo nel Connecticut insieme, dormivamo insieme: io dormivo, Andy era sotto anfetamina; quando mi sono svegliato l’ho trovato che mi stava guardando. Mi osservò a lungo: ogni volta che mi svegliavo lo vedevo con gli occhi su di me… Così gli è venuta l’idea di questo film su me che dormo per alcune ore, e io sono diventato il primo soggetto da filmare. Effettivamente allora io volevo fare cinema, e lui mi ha chiesto: vuoi diventare la mia movie-star? E io gli ho risposto: oh yes!”.
 Sleep di Andy Warhol
Sleep di Andy Warhol
È vero che alla prima proiezione c’erano nove spettatori e due sono andati via?
“Sì, la gente entrava e usciva: è un film che dura più di cinque ore e quindi c’era questo movimento continuo”.
Hai mai pensato di scrivere un libro su Andy Warhol?
“Sto scrivendo un libro di memorie dove parlerò ampiamente di Warhol, ma non ho ancora pubblicato niente su di lui, se non qualche ricordo in altri volumi, come Per risplendere devi bruciare (Giunti, 2005)”.
Sei stato molto vicino alla Pop Art, non solo a Warhol, ma anche a Rauschenberg e a altri protagonisti di quel movimento. Cosa ha significato per te e per la tua poesia?
“In quel periodo c’era Allen Ginsberg, che era rivoluzionario perché già scriveva certe cose, però era ancora molto lirico, conservatore nella scrittura: lavorava dentro argini tradizionali. Dall’altro lato c’erano gli artisti pop che stavano rivoluzionando tutto, facevano piazza pulita di tutto il passato. Loro mi hanno dato il coraggio di cominciare a modificare il rapporto con la poesia. Non mi sono mai rifatto alla tradizione: vedendo come loro utilizzavano la contemporaneità, ho iniziato anch’io a fare cose simili”.
In che cosa consiste questa rivoluzione poetica?
“Negli anni sessanta ho iniziato l’attività di un’associazione no-profit, John Giorno Poetry Sistem. La prima cosa che ho fatto, attraverso l’associazione, è stata organizzare in Central Park, in uno spazio dove normalmente facevano dei concerti, nove giorni di reading di poeti che potevano dire, fare, mostrare in tutte le forme che volevano i loro lavori. Poeti che lavoravano sulla performance, con loro stessi e la loro voce. Successivamente ho inciso un album con le mie poesie sperimentali, legate molto al suono. E dopo è partita l’idea di Dial-A-Poem”.
Cos’è Dial-A-Poem?
“È stata la prima idea di divulgazione della poesia con uno dei nuovi strumenti di comunicazione di massa, il telefono. Prima la poesia si leggeva, in un rapporto uno a uno; il reading ha creato un altro tipo di rapporto, raggiungeva più gente. Con Dial-A-Poem qualsiasi persona, da qualsiasi parte degli Stati Uniti, poteva chiamare e sentire una poesia al telefono”.
In quegli anni ti avvicinasti molto a William Burroughs…
“Lui è arrivato a New York nel 1964 e insieme a Bryan Gysin siamo diventati molto amici. . Abbiamo vissuto insieme. Lui cucinava. Io facevo la spesa. Ci alternavamo nel lavare i piatti. Lui amava le pistole, io non ho mai capito come si spara. Abbiamo fatto performance e reading insieme”.
Che cosa vi siete scambiati, nell’amicizia e nella poesia?
“Quando passi trent’anni al fianco di qualcuno non riesci a dire: ho preso questo, ho dato quello… Sei sempre insieme alla sua mente, e quindi è un continuo scambio, che non si può quantificare. È uno stare sempre in mezzo alle cose insieme, e condividerle”.
Dire la poesia, trasformare la parola scritta in “spoken word”, che cambiamento comporta nel poeta?
“Io lavoro continuamente con la voce. Comincio a scrivere i versi e poi inizio a dirli e attraverso il suono che questi versi producono inizio a strutturare la poesia, comincio a lavorare nel suo ritmo, che non è solo la forma scritta ma anche quella sonora. A un certo momento comincio a provarla, ogni giorno, per mesi, e chiaramente scopro lentamente la qualità musicale di questo brano nel corpo, come succede ai danzatori. Quando sento che è chiusa, diventa il testo definitivo”.
La performance modifica anche la forma finale scritta, quindi?
“La poesia ha a che fare con la saggezza e nel dirla può succedere che provando un ritmo si possono modificare le parole, che sulla carta sono uscite in una certa maniera. Nel ritmo trovi quella variante minima che ti consente di avere uno scarto anche nella parte scritta”.
In certi tuoi versi prima enunci una frase, poi la spezzi, la spezzi diversamente, la ricomponi… È un frutto di questo continuo confronto con l’oralità?
“Questi procedimenti appartengono al passato, ora non faccio più quel tipo di sperimentazione. Ogni poesia, ogni periodo ha la sua ricerca”.
Cosa stai sperimentando ora?
“Ogni cosa che faccio è una sperimentazione. Io scopro le cose facendole”.
John Giorno e Kinkaleri. Ph. di Castorp
E cosa succede a lavorare con danzatori, come stai facendo con Kinkaleri?
“È come un episodio che si può sviluppare insieme. Entrambi lavoriamo con il respiro, con l’idea della struttura, quindi è mettere in parallelo due mondi che si incontrano sulla scena”.
È importante il respiro?
“Io non ho una tecnica, come quella del cantante per esempio. Perciò ho dovuto sempre imparare da solo: ho trovato molte cose semplicemente facendole”.
Entrano nel tuo modo di affrontare il respiro le pratiche della meditazione buddhista?
“Ho sviluppato una tecnica che spinge il respiro dall’alto al basso e viceversa, creando una sorta di nucleo centrale che produce calore e fa uscire tutta l’energia. Questo, io che sono diventato buddhista tibetano negli anni settanta, l’ho ritrovato in una pratica tradizionale e ho scoperto che andavo in quella direzione. C’è una pittura con monaco nudo in mezzo alla neve che emette dall’interno il calore che lo riscalda”.
Da un certo punto in poi ti sei molto impegnato nelle associazioni di assistenza e aiuto ai malati di Aids.
“Negli anni ottanta, quando è arrivata l’Aids, ho visto tanta gente morire. Una catastrofe, che ha coinvolto tanti amici. Ero così abbattuto che ho pensato che dovevo fare qualcosa, che dovevo aiutare gli altri. Mi ricordavo che nell’età dell’oro della promiscuità sessuale nella New York di un certo periodo, quando incontravi qualcuno non ti ponevi minimamente il problema se fosse malato o meno. Lo vedevi e, se ti piaceva, andavi con lui. A un certo momento avrei voluto trattare questi malati, tutti così evidentemente malati, perché diventavano vecchi, invecchiavano precocemente, avrei voluto trattarli come avrei fatto con una qualsiasi persona incontrata negli anni d’oro, quando c’era solo l’idea di condivisione e di promiscuità”.
In quale relazione è la poesia con la tua identità gay? Ti ha aiutato a liberarti, a uscire allo scoperto, a superare i pregiudizi sociali, in anni in cui non era facile essere omosessuale?
“Ho accettato la mia identità, per lavorare nella poesia. Penso che quello che sono mi abbia aiutato a essere poeta, e quello che ho scritto, non intenzionalmente, ha contribuito ad aiutare qualcuno. Ho dato forza all’identità di altri”.
Sulle droghe?
“A un certo punto della vita per me sono state molto importanti. Non solo la marijuana ma anche l’Lsd e droghe psichedeliche, quelle che ti permettono di trovare altri stati. Aiutano a conoscere la propria mente. Aiutano. Molti artisti ne facevano uso. On The Road di Kerouac non sarebbe stato scritto così, di getto, senza staccare per giorni, senza le anfetamine”.
Il famoso allargare gli stati della coscienza?
“Esattamente questo. Serve ad andare avanti nel conoscere quello che fa parte di te”.
Dove eri l’11 settembre del 2001?
“Nella mia casa a New York. Appena sono crollate le torri gemelle, sono salito sul tetto e ho visto un ammasso di polveri e detriti. Da buddhista ho meditato: è stato un momento molto potente, perché ho sentito nell’aria migliaia di persone morte. Era l’ora di pranzo, e la città era deserta, silenziosa”. (Questa domanda-risposta la prendo in prestito dallo spettacolo, ndr.)
Che cosa è rimasto oggi in America e nel mondo della rivoluzione della Beat Generation e della Pop Art?
“Beat Generation è una sigla che esiste solo in Italia. Comunque, quei due movimenti hanno cambiato il mondo, ma sono cose di cinquant’anni fa. Sono entrate nella cultura, nel corpo, nel Dna e ognuno ne è pieno. Il mondo ha metabolizzato l’Underground e la Pop Art, e ne è stato cambiato. Tutti siamo intrisi di quello che hanno scoperto quei movimenti artistici”.
Oggi cosa ricerca John Giorno?
“Continuo a lavorare. Mi trovo in mezzo alle cose, e cerco di comprenderle”.
 Spettacolo Kinkaleri con John Giorno. Ph. Ilaria Costanza
Spettacolo Kinkaleri con John Giorno. Ph. Ilaria Costanza
Come vi siete conosciuti con la compagnia Kinkaleri?
Kinkaleri: “Gli abbiamo scritto una mail, dicendogli che volevamo lavorare con lui. Gli abbiamo mandato il progetto e, siccome lui molte cose le fa per intuito, si è documentato, è andato a vedere in rete cosa c’era riguardo a noi e ha deciso di accettare. Ha risposto alla mail mandando subito la poesia che entra nello spettacolo. Una poesia che non era tradotta in Italia”.
E perché Kinkaleri ha cercato proprio lui?
Kinkaleri: “In altre due performance del progetto All! avevamo lavorato su suoi testi: il suo lavoro, sia per la struttura compositiva della parola sia per il suo rapporto performativo aveva molte connessioni con il nostro. Tutto il progetto All! si sviluppa intorno a poeti che hanno usato la poesia non solo per quello che dice, ma anche per la sua materia fonica e corporea. Per questo siamo arrivati a Burroughs e a lui. Poi lui è ancor attivo sulla scena: lo abbiamo contattato per confrontarci con lui”.
Ancora una domanda a John. Qualche anno, fa sei tornato in Basilicata, la terra dei tuoi genitori. In che modo senti queste radici?
“Domani parto per la Puglia e la Basilicata. La mia famiglia viene da Tursi e Aliano, posti che amo. A Tursi c’è una vecchia chiesa che conserva le ossa delle varie famiglie come fosse un ‘minestrone’, perché sono tutte mischiate. I teschi sono stati rubati e sono rimaste solo quelle ossa anonime del corpo che sono femori, tibie, peroni… Sono probabilmente tutti cugini, perché le famiglie hanno continuato a sposarsi tra cugini: sento quelle ossa come miei parenti. Le adoro. Hanno avuto un finanziamento per fare qualcosa con questo ossario. Loro, i parenti viventi, sono nel panico. Io gli ho consigliato di lasciare tutto com’è, perché loro, i morti, sono felici di stare così, tutti insieme…”.
Ne approfitto per chiedere qualcosa sul rapporto con la morte, che risalta, forte, in molte tue poesie.
“Io sono buddhista. Lavoro con l’idea della morte da molti, molti anni nella mia pratica. Per allenare la mente al momento del trapasso. Questo è il mio rapporto con la morte”.
Eserciti la mente alla morte anche attraverso le poesie?
“Proprio così. Solo la morte mi farà smettere di scrivere”.