Speciale
Come un criceto sulla ruota
Le folli camminate di Dino Campana, detto anche Dino Edison per via di tutti gli elettroshock ch'era costretto a sorbirsi, e le non meno folli camminate del fugueur Albert Dadas posseggono in verità, come tutte le follie, un loro metodo. Il metodo del ritorno. Quei passi, alla fine, ritornano sempre su se stessi. E ricordano molto da vicino il nomadismo, com'è descritto da Bruce Chatwin.
Chatwin per tutta la vita cercò di scrivere un libro in cui spiegare la natura dell'inquietudine umana. Un testo che avrebbe dovuto rispondere al semplice quesito: perché gli uomini non se ne stanno mai fermi dove stanno, e invece si muovono di continuo da un posto all'altro? Cosa diavolo li spinge? Riempì d'appunti un numero impressionante di taccuini dalla carta morbida, racchiusa in una rilegatura di cerata nera, acquistati in una papeterie di Rue de l'Ancienne Comédie, a Parigi naturalmente. Ma il libro, nonostante i cinquanta taccuini neri di morbida carta fitti di appunti, non gli riuscì di scriverlo. Ne rimangono tuttavia tracce consistenti in due opere, una delle sue ultime, Le vie dei canti e una postuma, Anatomia dell'irrequietezza.
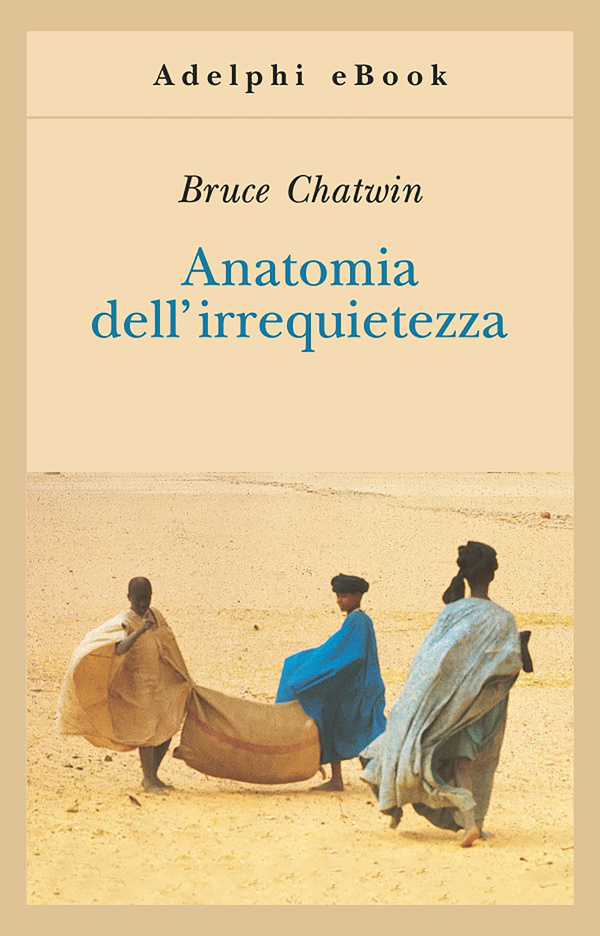
Nell'essere umano albergherebbe una sorta di impulso migratorio innato, affine a quello degli uccelli in autunno. Ma, accanto alla coazione a vagare, esiste la coazione a tornare. Un istinto di rimpatrio. I nomadi si muovono perennemente, certo, ma seguendo immutabili itinerari di migrazione. Le tribù pastorali ripetono da tempo immemorabile identici percorsi migratori, alterandoli solo in via eccezionale, in caso di siccità o altre catastrofi.
Quando un aborigeno australiano si allontana per mesi dai luoghi "civilizzati", e sembra perdersi a caso nelle distese del bush, in realtà segue sentieri precisi, noti a lui solo e al suo clan. Si tratta del cosiddetto walk-about: egli ripercorre le Piste del Sogno o Vie dei Canti o Vie della Legge. Nel Tempo del Sogno leggendarie creature totemiche avevano percorso il continente, cantando il nome di ogni cosa che incontravano – animali, piante, pozzi, rocce – e, con il canto, davano esistenza a ogni cosa. L'aborigeno si rimette sulle loro tracce per ritrovare se stesso.
Chatwin non si limita, al proposito, a citare dal terzo sonetto a Orfeo di Rilke: Gesang ist Dasein (Cantare è esistere) come avrebbe fatto un Heidegger qualsiasi, ma, con un bel balzo all'indietro, ricorre addirittura a Ovidio. Disteso sotto un albero, al confine settentrionale dell'allevamento di Middle Bore, con la testa appoggiata allo zaino, il nostro Bruce legge una traduzione inglese delle Metamorfosi (edizione Penguin) e gli viene di colpo una grande idea: e se tutta la mitologia classica riassunta nel libro ovidiano, con le scorribande degli dei, le sorgenti sacre, le sfingi, le chimere e tutti gli umani mutati in usignoli, orsi o corvi o pietre – se tutto ciò non rappresentasse che il residuo di una gigantesca Mappa del Canto, interpretabile in termini di Geografia totemica?
Un aborigeno australiano, se leggesse Ovidio, troverebbe probabilmente che vi spira una cert'aria di famiglia. L'idea è grandiosa e nient'affatto peregrina. Viaggio e ricerca dell'antenato sono una costante nel mondo classico. Basti pensare all'Odissea, ai primi quattro libri, la cosiddetta Telemachia, che non è altro che il viaggio di Telemaco alla ricerca del padre, a Lacedemone, a Pilo, e mentre il figlio si muove sulle tracce del genitore, contemporaneamente, il padre sta tornando a sua volta verso il figlio, la moglie, e il vecchio padre, Laerte. Anche Enea, alla Sibilla che lo guida nel suo viaggio ultraterreno, chiede di poter fare solo questo: vedere il caro volto del padre, Anchise.
Ma, adesso, non è questo esattamente il punto. Il punto è la ricorsività ossessiva del cammino del fugueur, che ricalca quella del nomade, o quella dell'eroe antico o dell'aborigeno australiano. Il camminante meranese, nel suo piccolo, più che un flaneur o un Wanderer è lui pure un fugueur. Un fugueur minimo. Che si muove nel giro eterno del paesaggio meranese, come un criceto sulla sua piccola ruota.
Qualcuno potrebbe esclamare: che bello! Cosa ci può essere di più meraviglioso: camminare a Merano, che è il Tempio dei Camminanti! La sede delle famose Passeggiate Tappeiner! (diventate sulla bocca di alcuni turisti Tàpper, si sa). E delle altrettanto rinomate Passeggiate d’Inverno nonché d’Estate! (primavera e autunno non rientrano nella toponomastica cittadina). Le quali Passeggiate fiancheggiano le spumeggianti acque del Passirio, e sono dette anche Promenaden! Andiamoci cauti, con gli esclamativi, e, proprio a proposito di Promenaden, riflettiamo un momento. Per farlo ritorniamo al nostro Campana.
Egli, accanto a scarpinate senza freno per la Pampa e consimili luoghi esotici, si dilettava di più domestici giretti per vie cittadine: Me ne vado per le strade/strette oscure e misteriose, così attacca la Petite Promenade du poète. Che così prosegue: Vedo dietro le finestre/affacciarsi Gemme e Rose.
Parrebbe una situazione di pieno idillio, nonostante l’oscurità, la strettezza e la misteriosità delle vie cittadine. Siamo a Firenze. Le donne che si affacciano alle finestre vengono perciò chiamate ciane, ossia, fiorentinamente, “popolane sguaiate e pettegole”. Il fatto che tali ciane stiano dietro i vetri delle loro dimore, a guardare giù per strada, non sembra promettere niente di buono. L’idillio sembrerebbe sul punto d’incrinarsi.
Ma non anticipiamo i tempi. Procediamo con ordine. O meglio: fermiamoci un momento. La Petite promenade di Campana è un testo. Un testo letterario. Campana è prima di ogni altra cosa un poeta, benché considerato folle. È anche un fior di letterato, piuttosto colto, benché sia stato a lungo e del tutto a torto considerato un primitivo, ingenuo, immediato, istintivo e così via. I poeti si nutrono di poesia. I letterati si nutrono di letteratura. Dino Campana non sfugge a questa regola. Un poeta che poetava all’inizio del Novecento non poteva evitare di misurarsi, in positivo o in negativo, con il più ingombrante Poeta esistente e poetante allora in Italia: Gabriele D’Annunzio, il Vate.
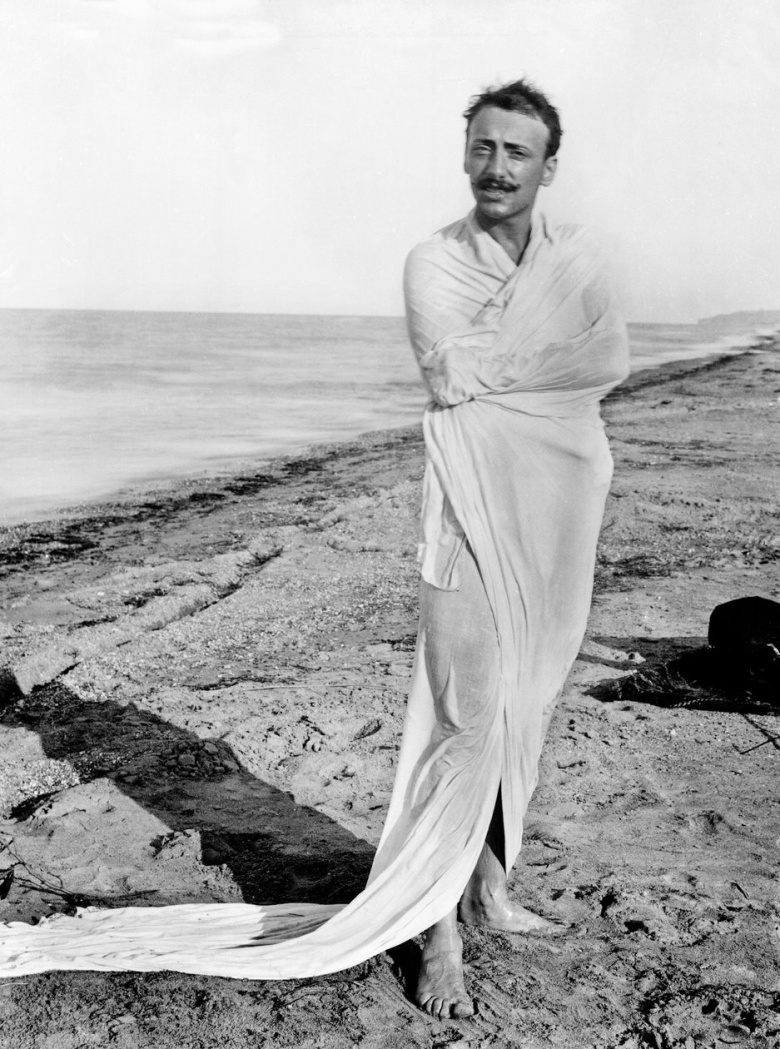
Ci sono consistenti tracce dannunziane nell’opera di Campana. Firenze è per lui Fiorenza giglio di potenza, preciso ricordo dell’Alcyone. Quando descrive il mare e l’onda che ammorza e volubile smorza Dino si rifà senza dubbio, magari con intento parodico, all’Onda che subito s’ammorza reperibile anche questa nella stessa opera di D’Annunzio appena menzionata. Perché non pensare allora alla Passeggiata, il testo forse più noto del Poema paradisiaco? Sicuramente la Passeggiata di Palazzeschi, citata in un capitolo precedente, è il controcanto ironico della celebre lirica dannunziana. Come anche La fontana malata lo può essere a buon diritto dell’Onda (ancora). Perché non pensare che anche Campana, allo stesso modo di Palazzeschi (e di Gozzano e Rébora e vari altri) si esercitasse in queste diffuse parodie dannunziane implicite?
Nella Passeggiata paradisiaca (1892) il Vate immagina di camminare al fianco di una bella signora difficile, chiusa come un giardino chiuso e dai capelli bruni come foglie brune. I due percorrono languidamente un lungomare. La superficie dell’acqua è increspata da piccole onde, bianche come lane d’agnelli e gigli senza gambo. All’inizio e alla fine della passeggiata il Poeta ripete, alla bella signora bruna: Voi non mi amate ed io non vi amo.
Sappiamo che l’incantevole dama era Maria Gravina e, benché lui non amasse lei e lei non amasse lui, finirono a letto entrambi, ebbero una relazione durata anni e anche una figlia, di nome Renata.
Il nome completo della signora era Maria Gravina Anguissola Cruyllas di Ramacca. Senza dubbio il Poeta fu affascinato, più che da tutto il resto, dal nome. Gabriele era un innamorato dei nomi, i bei nomi sonori, sonanti, scintillanti. Giustamente d'altronde, perché i corpi decadono e muoiono, ma i nomi permangono. La figlia, per rimanere in tema, aveva sì nome Renata, ma familiarmente era chiamata Cicciuzza. (Non è un gran nome questo, ma anche a D’Annunzio si possono concedere dei momenti di relax, specie in famiglia).
Quindi Campana potrebbe essersi rappresentato, in questa sua mesta passeggiata, smarrito nel dedalo delle vie cittadine, in compagnia, non gradita, di Gemme e Rose, proprio in antitesi al grande e altisonante modello dannunziano. Come a dire: il Vate in riva al mare con aristocratiche e io in mezzo alla città con donnette poco raccomandabili che spiano dalla finestra.
Ma forse, partendo precisamente da queste Gemme e Rose della Petite Promenade, si può risalire a un modello anteriore nel tempo e di sicuro più consono al tema. L’allusione è a un piccolo libro (per la mole), ma molto importante per il contenuto e anche molto sfortunato, quando apparve (1842), se il suo autore lamentava il silenzio compatto che aveva suscitato nei lettori italiani. In Francia ebbe accoglienze migliori. Si tratta della Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni.

Pubblicato in appendice alla seconda e definitiva edizione dei Promessi Sposi ne costituisce, secondo alcuni, la “vera” conclusione. Nel senso che, al posto della ben nota chiusa melensa con il “sugo di tutta la storia” e con il lieto fine della bella famigliuola finalmente riunita marmocchi compresi, bisognerebbe considerare i tremendi fatti narrati nella Colonna infame per rendersi conto di cosa davvero pensasse Manzoni delle vicende umane su questa Terra. E, leggendo la prosa serrata e incalzante della Colonna, non è possibile farsi soverchie illusioni sulle aspettative nutrite dal nostro autore nei confronti dei suoi simili, che sono poi anche i nostri, simili: ci par di vedere la natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio, e come legata in un sogno perverso e affannoso da cui non ha mezzo di riscotersi. Sembrano parole più di Leopardi che di Manzoni. Ma che c’entrano con le Gemme e Rose della promenade di Campana? si obietterà. C’entrano, c’entrano.
Il terribile racconto manzoniano inizia con questa precisa notazione di tempo e luogo: La mattina del 21 di giugno 1630, verso le quattro e mezzo, una donnicciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi per disgrazia, a una finestra d’un cavalcavia che allora c’era sul principio di via della Vetra de’ Cittadini, dalla parte che mette al corso di porta Ticinese… vide venire un uomo…
Pare un fatterello innocuo, ai limiti dell’idillio, una donna si affaccia alla finestra e scorge un passante. Invece è l’inizio di una catastrofe. Perché questa donna ravvisa in quell’uomo ignaro un untore, uno di quei supposti malvagi che, non avendo di meglio da fare, andavano in giro a ungere muraglie e porte per diffondere la peste, come se la peste stessa avesse bisogno di essere aiutata nel contagio, che le riusciva invece benissimo da sola.
Un’altra donna, di nome Ottavia Bono, sporta anche lei lo stesso giorno e la stessa ora da una finestra della stessa strada, vede lo stesso spettacolo e conferma le parole della sua degna comare.
Le due donnacole riferiscono all’Autorità Costituita ciò che hanno visto (la loro “visione” sarebbe più giusto dire) e con la loro deposizione spontanea innescano un’iradiddio apocalittica.
L’uomo che aveva avuto la sventura d’entrare nel campo percettivo delle due iene appostate, il commissario di sanità Guglielmo Piazza, venne torturato a lungo, ma non confessò ciò che d’altronde, non avendolo commesso, non poteva confessare. Dopo altre torture, ancor più raffinate e orrende, e dopo promesse fallaci d’impunità, fatalmente finì non solo per ammettere il crimine mai compiuto ma coinvolse altri sventurati in qualità di complici, complici reali per quel reato immaginario. Lui e un barbiere, a nome Giacomo Morra, vennero, in quanto untori, condannati al taglio della mano destra e ad essere squartati con tenaglie roventi e poi rotti sulla ruota e infine pietosamente sgozzati dopo sole sei ore d’agonia. Quei giudici avevano un cuore, dopo tutto.
Ci furono altri incriminati e altre esecuzioni. Fu prosciolto da ogni accusa unicamente un giovanotto ventottenne, il nobile don Giovanni Gaetano Padilla, figlio del Castellano di Milano, don Francesco de Padilla, terza autorità dello Stato. Probabilmente disponeva di buoni avvocati ma forse, suppone qualche malizioso, sussistevano altri validi motivi per questa sorprendente assoluzione.
Comunque, se uno, passando per strada e levando a caso lo sguardo, s’imbatte in una signora o signorina che occhieggia oziosa alla finestra, fa bene a preoccuparsi. Non si sa mai cosa ne può nascere.
Leggi anche:
Alessandro Banda | Flâneur sotto shock
Alessandro Banda | La schiavitù canina
Alessandro Banda | La celeberrima Passeggiata Tappeiner
Alessandro Banda | Il patrono dei camminanti
Alessandro Banda | L’invasione degli ultraveicoli
Alessandro Banda | Metafisica del SUV
Alessandro Banda | Crisi e biciclette
Alessandro Banda | Wanderlust
Alessandro Banda | Il rompicoglioni eterno
Alessandro Banda | Telefonanti
Alessandro Banda | Passanti fossili
Alessandro Banda | Dino Campana e altri fugueurs







